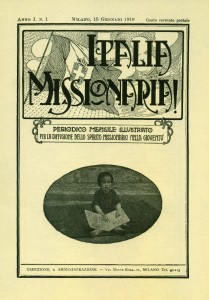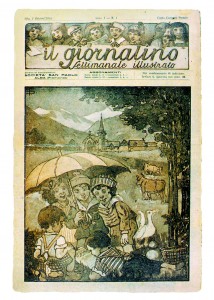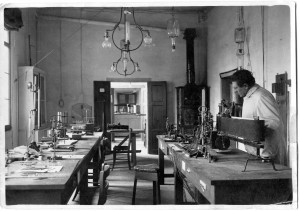In questa seconda parte utilizzeremo una diversa scansione, mettendo a fuoco dapprima la storia delle edizioni del Corano in italiano e la vicenda coloniale. In seguito ci soffermeremo sulla CEI come espressione della Chiesa italiana, prestando attenzione agli attentati dell’11/09/01 come punto di svolta della percezione comune dell’Islam nel Paese. Consapevoli dei limiti di questa indagine, non possiamo che rimandare ad ulteriori approfondimenti più mirati e circoscritti, accontentandoci di proporre il quadro generale in cui i Cattolici italiani interessati al confronto con l’Islam oggi si possono muovere.
Il Corano in Italia
La scelta di pubblicare il testo coranico ed il modo in cui viene corredato da note ed approfondimenti è chiaramente rivelativa del modo in cui l’autore si pone rispetto all’Islam. Riportiamo in sintesi la cronologia delle opere italiane proposta da Paolo Branca e le sue conclusioni in merito. Dopo l’opera del Marracci bisogna attendere ben tre secoli prima che l’editoria italiana si interessi nuovamente al testo coranico, ed all’inizio in modo farraginoso. Nel 1847, 1882 e 1912 vengono proposte traduzioni basate per lo più sulla versione francese di Kasimirski, con errori, omissioni, sintesi non segnalate come tali ed un minimo corredo di commenti e spiegazioni. Solo nel 1914 il Fracassi pubblica una versione tradotta direttamente dall’Arabo e con originale a fronte, specificando di voler così contribuire all’integrazione dei sudditi musulmani delle colonie nel Regno d’Italia. La traduzione non è esente ad errori e critiche, sia contemporanee che successive, ma segna comunque una svolta decisiva nell’approccio al Corano in Italia. Segue il Bonelli nel 1929, più fedele al dettato arabo e finalmente il Bausani nel 1955, edizione ancor oggi considerata valida e consigliabile sia per il testo che per l’apparato critico. Di qui in poi le traduzioni si moltiplicano e susseguono rapidamente. Nel 1986, a Trieste, un’ulteriore e per ora ultima aggiunta alla pubblicistica è la prima edizione italiana curata da un gruppo di musulmani e indicata semplicemente come “Qur’an”, cui ne seguiranno molte altre. Nelle librerie italiane è poi divenuto ormai normale trovare pubblicazioni tradotte dall’inglese o da altre lingue di commenti al Corano con traduzione del testo, in numero tale da rendere impossibile in questa sede darne conto puntualmente. Il professor Branca annota l’augurio di una sempre maggior diffusione e comprensione critica di queste traduzioni, come anche maggior coinvolgimento e disponibilità dei musulmani italiani che ancora risentono della storica riserva islamica all’idea di tradurre il libro sacro. Interessante l’annotazione sulla scarsità di traduzioni italiane delle principali opere classiche dell’Islam, contributo determinante e necessario per i prossimi sviluppi della materia.
Sintesi: Nell’insieme risulta evidente come ormai la questione islamica non sia appannaggio solo degli interessi teologici della Chiesa, ma tutti gli elementi della società italiana abbiano a cuore in certa misura una comprensione dell’Islam come religione, oltre che come cultura. Resta da approfondire quale sia il rapporto dei fedeli cristiani con questa significativa mole di pubblicazioni dal tenore tanto diverso, come anche l’eventuale opportunità per il Magistero in Italia di offrire indicazioni per consentire a ciascuno di orientarsi e non inciampare in testi poco affidabili o di parte credendoli invece obiettivi ed universalmente validi.
Il colonialismo italiano nei paesi islamici e la missione cattolica
Anzitutto segnaliamo la difficoltà di reperire materiale sul tema citando Romanato: «Del tutto trascurabile è poi l’interesse per le missioni nella storiografia italiana. Tolta, e non sempre, una citazione d’obbligo per Guglielmo Massaja, l’ottica rimane, in fondo, quella di Croce, che ricordava “l’operosità” di “viaggiatori” ed “esploratori”, ma ignorava del tutto la presenza dei religiosi». L’azione missionaria della Chiesa ha da sempre una dimensione universale, tuttavia nel periodo coloniale le singole chiese nazionali concentrano il proprio impegno nei territori amministrati dai rispettivi governi (sia pure mai in modo esclusivo). Il punto di partenza della rinnovata penetrazione missionaria ottocentesca e novecentesca in Africa sono i paesi musulmani della costa mediterranea, soprattutto l’Egitto, e nel caso dell’Italia le aree interessate sono quelle della Libia e del Corno d’Africa, parte del mondo islamico fin dai suoi primi secoli. Il giovane stato italiano era ben consapevole che molti suoi cittadini erano già da tempo presenti nei territori africani e mediorientali al seguito delle missioni cattoliche, e che la netta preminenza numerica rispetto ad altre nazionalità, unita alla centralizzazione in Roma delle case generalizie, aveva di fatto promosso la diffusione della lingua e della cultura italiana quasi di pari passo con il costituirsi di enclave cattoliche in quelle regioni. A differenza di Francia e Gran Bretagna, però, in Italia la questione missionaria resta di appannaggio esclusivo della Chiesa, e le ingerenze politiche sono assai contenute e sporadiche. Questo permette al missionario italiano di sentirsi «prevalentemente uomo di chiesa, portatore di un disegno di evangelizzazione, come diremmo oggi, potenzialmente universale, non condizionato da interessi politici o nazionali». Per completare il quadro, si tenga conto che i missionari italiani erano figli di una Chiesa che in Europa, ovvero là dove riteneva di essere a casa, si sentiva e sperimentava perseguitata, rifiutata, condannata ad un futuro incerto sia dal laicismo francese che dalla conquista sabauda dello Stato Pontificio: la Chiesa di Gregorio XVI, anti-liberale, contro-rivoluzionaria, impegnata a guadagnarsi la propria libertà e la speranza di un domani migliore. In tutto questo complesso movimento, che con tutti i limiti propri della cultura e dei mezzi educativi allora correnti è stato comunque il principale esempio di confronto non razzista tra europei ed africani durante l’esperienza coloniale, la Chiesa italiana opera soprattutto attraverso gli ordini religiosi. Un caso particolarmente interessante è quello di Daniele Comboni e dei suoi religiosi. Nel 1864 il Comboni propone a Propaganda Fide un piano missionario che dovrebbe superare le difficoltà e i limiti che hanno segnato il sostanziale fallimento del progetto missionario francescano in Sudan. Il religioso propone di stabilire lungo le coste africane dei centri di formazione e di preparazione per i religiosi missionari del continente, evitando così di farli venire in Europa. A suo dire, infatti, il missionario africano formato in Europa «ritornato nell’Africa ne è reso inetto per le quasi connaturate abitudini europee contratte nel centro della civiltà, che diventano ripugnanti e nocevoli nella condizione della vita africana». Il piano poi precisa la necessità di formare non solo sacerdoti, ma catechisti, insegnanti, artigiani d’ambo i sessi che possano gradualmente penetrare nelle regioni interne dell’Africa e divenire fermento di sviluppo e conversione per le comunità. Per il presente lavoro è interessante constatare come il Comboni citi esplicitamente l’esperienza dei Vicariati apostolici in paesi islamici come Egitto, Tunisia, Libia e Marocco, ed abbia direttamente affrontato anche il difficile confronto con i musulmani dell’Africa nera. Egli, nel corso della sua opera, non considera mai l’Islam una realtà impermeabile al messaggio evangelico né le società islamizzate come particolarmente ostili ai missionari. Concentrato su problemi di tipo culturale, economico, sociale e non ultimo sui disagi della calura e delle malattie, il Comboni accosta il dialogo con l’Islam in termini di assistenza gratuita e disinteressata alla promozione delle comunità africane e di esplicita testimonianza della fede cristiana.
Sintesi: Nell’insieme le missioni italiane, che siano tali per un diretto interessamento del governo nazionale o per il semplice fatto di fare riferimento a religiosi italiani, mostrano di non avere particolare attenzioni per l’Islam. Esso, pur presente e radicato presso i popoli colonizzati dall’Italia, specie in Libia, costituisce non tanto il destinatario della missione quanto il concorrente con cui contendere per evangelizzare le genti ancora legate alla propria religione tradizionale o, nella migliore delle ipotesi, un contesto tra gli altri in cui applicare il proprio progetto di evangelizzazione.
Il contesto civile del dopoguerra
Tra il 1952 e il 1954 matura nell’Università di Roma la scelta di cambiare nome alla cattedra di “Storia ed istituzioni musulmane” in “Islamistica”, sancendo così la scelta di considerare il mondo islamico come universo socio-culturale oltre che religioso in senso stretto. Si sviluppa da qui il percorso dell’islamistica italiana laica, per lo più di indirizzo positivista e segnata dal desiderio di farsi scienza autorevole e riconosciuta. Va segnalata poi la figura di Padre Federico Peirone, che negli anni ’70 e ’80 fu attivo sia nel mondo accademico laico che ecclesiastico come docente di lingua araba e di islamistica, oltre che convinto promotore del dialogo interreligioso.
La CEI e l’Islam
A partire dal 1973 nelle note e negli orientamenti pastorali della Conferenza Episcopale Italiana si affaccia la questione del dialogo interreligioso, orizzonte che va tenuto presente per contestualizzare le affermazioni specifiche legate all’Islam. Queste appariranno solo dal 1993, legate inizialmente alle questioni dell’immigrazione e dei matrimoni misti. Solo lentamente si apriranno prospettive di dialogo teologico e pastorale per la Chiesta italiana nel suo insieme e per le comunità cattoliche sul territorio. Diamo allora anzitutto conto della questione interreligiosa. Negli anni ’70 la CEI è pienamente nella linea della preparazione evangelica, e nei suoi documenti il dialogo si configura come annuncio della verità cristiana che purifica gli errori delle altre religioni e ne porta a pienezza i germogli di bene (28.2.1974, Evangelizzazione del mondo contemporaneo in Enchiridion CEI, vol.2 nn. 1061-1064, 1072-1074). La prospettiva è fortemente “ad gentes” e il contesto italiano resta genericamente percepito come cristiano-cattolico; i contrasti avvertiti nel mondo sono ricondotti esclusivamente a dimensioni ideologiche, politiche e razziali, la differenza religiosa non è ancora una preoccupazione pressante. Del resto la presenza di altre religioni, ed in particolare dell’Islam, nel contesto italiano non poteva essere avvertita facilmente. Se Francia, Gran Bretagna e Germania sperimentano fin dagli anni ’50 una massiccia immigrazione da paesi a maggioranza islamica, l’Italia ha un primo approccio al fenomeno solo nel corso degli anni ’80. I Musulmani stessi, giunti in Italia, cominciano ad organizzarsi in associazioni solo nei primi anni ’70 e, a causa delle differenze etnico-linguistiche e di appartenenza religiosa, fin dall’inizio si trovano divisi ed incapaci di offrire allo stato ed alla Chiesa un interlocutore che li rappresenti nel loro insieme. L’impressione è che il clima italiano presentasse ancora fino agli anni ’90 un’omogeneità tale da rendere trascurabile il fenomeno del pluralismo religioso, che resta ai margini del pensiero ecclesiale nel nostro Paese, tutt’al più appannaggio di missionari e specialisti. L’esperienza ecumenica ed il confronto serrato con una società in evoluzione e che si andava allontanando dalla morale cattolica tradizionale sono però l’occasione preziosa che mantiene desto l’episcopato italiano su ciò che accade al di fuori della comunità cattolica, fungendo da utile profilassi contro il rischio di un eccessivo ripiegamento all’interno. Il dialogo sorto dalle istanze conciliari, in quegli anni più evocato che descritto, resta comunque presente nella riflessione e risulta capace di affascinare i pastori d’Italia che lo riconoscono come risorsa necessaria per la Chiesa nel suo insieme e per i singoli credenti. Le sempre più chiare sollecitazioni del magistero pontificio di Giovanni Paolo II e le rapide trasformazioni sociali e culturali della fine del ‘900 spingeranno a tradurre queste riflessioni in termini pastorali. Ciò si concretizza nel 1990, quando la CEI prende atto di come, anche in Italia, il pluralismo non sia più soltanto un fenomeno culturale o etnico ma anche un dato religioso, ed esiga quindi risposte in questa sede specifica. Proprio in quell’anno il Vescovo di Milano, il Cardinale Carlo Maria Martini, introduce con forza la questione islamica nella pastorale italiana con un discorso alla sua diocesi. Già nel sottotitolo “dall’accoglienza al dialogo”, Martini si fa interprete di un cambio di prospettiva: dal musulmano visto solo come straniero bisognoso si assistenza al fratello di altra religione con cui cercare il confronto paritario, sia in termini pastorali che teologici. È un riconoscimento della dignità dell’altro, oltre che una provocazione sia per i Cattolici che per i Musulmani. Partendo dal riferimento biblico alla benedizione di Dio su Ismaele, il Cardinale traccia alcune linee-guida che andranno ben oltre i confini ambrosiani e segneranno l’esperienza italiana nel suo insieme: anzitutto l’invito ad affrontare la sfida di pensare al valore teologico dell’Islam nel suo insieme, come religione che interroga il Cristianesimo con i suoi valori, la sua visione di Dio, la sua interpretazione del patrimonio ebraico e cristiano. In secondo luogo il confronto tra singoli credenti delle due religioni, che deve essere anzitutto una testimonianza esplicita delle ragioni evangeliche per cui si agisce in tal senso. Fondamentale, per Martini, è l’invito alla reciprocità e la ricerca di obiettivi comuni da realizzare sul fronte della carità e dell’educazione a valori condivisi. Interessante il rilievo di dover segnare la distinzione tra società e Cristianesimo, mettendo a conoscenza i Musulmani delle riserve critiche nei confronti di alcune derive dell’Occidente che Cristianesimo ed Islam condividono. Il Cardinale, infine, raccomanda a tutti, e specie ai presbiteri, il dovere di non ignorare la questione, d’informarsi e di conoscere, di custodire la speranza e l’augurio che il Vangelo trovi ascolto e disponibilità anche presso i Musulmani che si vanno stabilendo in Italia. Si vedrà nei paragrafi seguenti l’attualità di queste considerazioni. Il delicato equilibrio espresso da Martini, tra disponibilità e richiamo al mutuo impegno, è condiviso dall’intera Chiesa italiana. In quegli anni essa invoca una più precisa regolamentazione del flusso migratorio ed avverte sulla necessità inderogabile della reciprocità, ponendo come mèta l’integrazione sociale in termini che comunque hanno ancora un certo sapore di assimilazione. A questo riguardo bisogna notare come, anche negli anni successivi, il credente di altra religione resti generalmente associato all’immigrato, e diverse annotazioni sul dialogo compaiano in documenti inerenti l’azione caritativa, facendo perdurare l’impressione che si tratti di uno degli atteggiamenti di chi intende occuparsi degli ultimi. La realtà dell’Islam in Italia viene infatti trattata per la prima volta in modo sistematico ai nn. 2019-2024 degli Orientamenti Pastorali del 1993 dedicati all’immigrazione. Il testo ricalca sostanzialmente quanto già detto da Martini, con in più delle attenzioni alla questione dei matrimoni misti e alle inevitabili difficoltà che questi presentano. La riflessione del cardinal Martini apre comunque alla Chiesa italiana una situazione nuova, che va oltre l’ambito prettamente caritativo: la sfida della prossimità quotidiana ed ordinaria con persone di religione musulmana intenzionate a vivere coerentemente con la propria fede e a manifestarla in forma pubblica. Alle parole del Vescovo di Milano farà eco due anni dopo la Conferenza Episcopale Triveneta. La CET parte dalle reciproche ferite che Musulmani e Cristiani si sono inferte, chiedendo la disponibilità a perdonare e dimenticare per costruire una nuova relazione fatta di reciproca conoscenza, onestà e rispetto. Dopo aver brevemente presentato gli elementi fondamentali della religione islamica, i Vescovi affermano che il dialogo interreligioso «non scaturisce da opportunismi tattici, ma dalla fedeltà a Dio e all’uomo», riferendosi in nota a Nostra Aetate. I punti di contatto con l’Islam sono identificati nell’atteggiamento di fede ed obbedienza a Dio riconosciuto come unico, mentre fra le differenze teologiche ha un posto importante la questione della separazione tra società civile e comunità religiosa, sulla linea degli ammonimenti di Martini. Tra i contributi più interessanti del documento l’invito a tutti i Cristiani ed alle comunità parrocchiali in particolare di fare la propria parte nel dialogo, affiancando il livello istituzionale già da tempo impegnato. Si vede quindi come le affermazioni del Concilio e la prima presa di posizione del Vescovo di Milano trovino nel Triveneto un’ulteriore precisazione pastorale e dei passi, sia pure incerti, di applicazione concreta attraverso un breve elenco di direttive accluso in conclusione. Solo un anno dopo gli Orientamenti Pastorali della CEI si concentrano sulla questione dell’immigrazione e dedicano ampio spazio al dialogo interreligioso, menzionando l’Islam come presenza più evidente e luogo privilegiato per questa buona pratica. Al numero 20, in particolare, la questione si pone in termini squisitamente teologici: «nel piano della Provvidenza quale significato per noi cristiani cattolici può avere questo mondo musulmano con il quale entriamo in contatto?», mentre i numeri 33 e 34 sono specificamente dedicati ai rapporti con l’Islam. Le coordinate della riflessione sono date da Nostra Aetate, dal magistero di Giovanni Paolo II e dal documento “Dialogo e annuncio”. La CEI, oltre ad osservazioni ed indicazioni già evidenziate nei testi precedenti, insiste marcatamente sulla questione della reciprocità nel rispetto e nella stima, interpellando sia i Musulmani residenti in Italia che le comunità nazionali di legge islamica da cui essi provengono. Frattanto la dimensione quotidiana e pastorale, che chiama in causa la vita ordinaria di tutti i Cristiani, diventerà gradualmente sempre più centrale nelle pubblicazioni nazionali sul dialogo islamo-cristiano, ed uno dei luoghi teologici e pastorali più predisposti a considerazioni positive e ragionevoli speranze: «Le persone possono prescindere dai contrasti, dai conflitti e dalle differenze dottrinali, vivendo nello sforzo di mutua comprensione, conoscendo e accettando i punti comuni e le differenze». È pressoché unanime il rilievo grato dell’assoluta apertura e disponibilità delle comunità cristiane nell’assistenza ai musulmani, che da parte loro hanno imparato immediatamente a non disdegnare le porte delle canoniche se si tratta di chiedere un aiuto materiale. Al contempo, col crescere delle nuove generazioni, i musulmani sono una presenza sempre più marcata nei luoghi di aggregazione e di svago offerti dalla parrocchia, ed essendo questi spazi disponibili gratuitamente non è raro che i giovani figli di immigrati li abitino volentieri, mentre i coetanei italiani e cattolici tendono sempre più a disertarli e preferire altre proposte. Di qui l’urgenza, già evidenziata nel documento della CET del 1992, della formazione di operatori pastorali specificamente attrezzati per l’incontro con persone musulmane, e la necessità di preparare anche i normali fedeli a vivere questa convivenza in modo consapevole, fraterno, e capace di testimoniare apertamente la propria fede in Cristo. È interessante notare come la stessa CEI maturi il deciso rifiuto della “conversione” dei musulmani come obiettivo diretto del suo rivolgersi a loro. La solidarietà della Chiesa italiana risulta così veramente gratuita e libera da ogni sorta di preoccupazione di “conquista”, e questo viene puntualmente riconosciuto dai musulmani. Non sarebbe onesto, però, tacere dei movimenti di opinione contraria che emergono sia da parte della società civile che in seno alla stessa Chiesa, e rivendicano come condizione all’accoglienza una perfetta ed assoluta reciprocità, non di rado confondendo il piano delle relazioni interpersonali privati con quelli dei rapporti tra enti religiosi e tra stati sovrani. Sebbene la Chiesa Cattolica non abbia mai mancato di chiedere esplicitamente la stessa cosa, il fatto che tale reciprocità non sia comunque considerata un prerequisito necessario per ogni ulteriore gesto caritativo rimane a tutt’oggi motivo di scontri e critiche tra persone ed istituzioni, specie quando le comunità islamiche chiedono di poter aprire dei centri culturali e di preghiera. Evidentemente gli attentati dell’11/09/01 hanno gettato altra benzina sul fuoco. Partecipe dei mutamenti della politica mondiale e dal diffondersi di paure e pregiudizi, la Chiesa italiana torna sulla questione islamica sia localmente che a livello nazionale. Anzitutto i Vescovi di Sicilia, storicamente e geograficamente più vicini al mondo islamico, cercano di leggere l’immigrazione sempre più massiccia di Musulmani in Italia come un “segno dei tempi”. Per la prima volta le contrapposizioni politiche in tema di immigrazione vengono trattate insieme alle questioni dottrinali ed alla prassi caritativa. Il documento è evidentemente frutto di una complessa gestazione accademica, con approfondimenti teologici, di diritto civile e canonico, di economia, di storia locale e mediorientale, e di confronto interreligioso sullo sfondo del “noachismo”. Più interessato a porre domande che a dare risposte, questo documento si chiude con l’appello ad una sempre più attenta e curata formazione delle comunità cristiane al dialogo con l’Islam. Sempre in conseguenza dell’acuita percezione mondiale nei confronti del terrorismo islamico, la CEI fa sua la preoccupazione di sollecitare e sostenere «quelle persone e quegli organismi che appartengono all’islam ma che non si riconoscono nell’ideologia dello scontro di civiltà e tanto meno nella strategia del terrore», oltre che dare voce alla necessità di distinguere sempre tra terroristi e musulmani. Nel 2006 la CET, che già si era espressa nel 1992, torna a fare il punto sui rapporti tra Musulmani e Cristiani. Decisamente più corposo del predecessore, questo testo approfondisce le motivazioni teologiche e pastorali del dialogo interreligioso ed offre anzitutto dei criteri generali che aiutino i singoli e le comunità locali. La preoccupazione principale è far sì che la Chiesa possa contribuire all’integrazione degli immigrati musulmani ed essere percepita da questi come un partner da stimare e rispettare, alleata nel perseguimento dei diritti civili e della libertà religiosa ma anche esigente nel chiedere reciprocità e gesti concreti di impegno per divenire buoni concittadini. L’inserimento scolastico, il prestito di ambienti per attività sociali e di culto, il contributo alla gestione del tempo libero dei minori sono alcuni degli spazi di confronto e testimonianza sulla base dell’esercizio concreto della carità di Cristo. Altro filone di ricerca e sperimentazione pastorale è la questione dei matrimoni misti. La Chiesa italiana, pur avendo segnalato la questione fin dagli anni ’90, interviene per esteso quando ormai è già maturata un’esperienza diffusa e, purtroppo, non di rado dolorosamente fallimentare. A quel punto è già prassi consolidata per le coppie miste preferire l’unione civile a quella religiosa, con un’ignoranza spesso totale delle possibilità di celebrazione con dispensa e di benedizione della coppia che permetterebbero un riconoscimento religioso da parte della comunità cattolica, oltre ad offrire al coniuge battezzato alcuni preziosi strumenti per coltivare la propria fede e farla crescere proprio grazie all’esperienza della vita coniugale con un partner di altra religione. Va poi rilevato come il matrimonio con musulmani, generalmente nella situazione di moglie cattolica e marito musulmano a causa delle prescrizioni islamiche, suscita nelle comunità reazioni di diffidenza ed ostilità più marcate che nel caso siano coinvolte altre religioni. La Chiesa è quindi intervenuta su due livelli, da un lato la preoccupazione di informare quanto più possibile i nubendi rispetto alle somiglianze e differenze nel modo di concepire il matrimonio, la famiglia, i ruoli dei coniugi e le scelte educative rispetto ai figli, dall’altro cercando di avviare percorsi di formazione per l’intera comunità, perché prenda atto della presenza di queste famiglie interreligiose e sappia farsi accogliente verso di loro, oltre ad avere cura e sostenere il coniuge cattolico senza giudizi preconcetti o illusori irenismi. È infine doveroso citare la questione della presenza di bambini musulmani nelle scuole cattoliche. Non è raro che i genitori musulmani percepiscano come una ricchezza il riferimento esplicito a Dio nella prassi educativa, guardando invece con preoccupazione alla laicità della scuola pubblica. Ciò però non significa che vi sia da parte della famiglia alcun “cedimento” verso l’adesione al Cristianesimo. La Chiesa italiana ha sviluppato la problematica con attenzione e continua a farlo, cercando il giusto equilibrio tra la fedeltà ai principi educativi cristiani, l’affermazione esplicita della fede in Cristo e l’accoglienza rispettosa del patrimonio religioso musulmano con le pratiche connesse a cui il fedele non può rinunciare. La preoccupazione educativa della Chiesa si estende anche all’ambito civile, arrivando a condividere la richiesta di alcune famiglie musulmane di potersi avvalere anche dell’insegnamento della religione islamica nelle scuole pubbliche con un Comunicato del 2006. Nel 2010 la Chiesa Cattolica Italiana, reagendo alla querelle sollevata sull’esposizione del Crocifisso in luoghi pubblici, esprime in un comunicato l’auspicio che la simbologia religiosa in generale non venga penalizzata negli ordinamenti legislativi, ed anzi sia valorizzata e compresa come occasione di confronto e di proposta, mai di imposizione o discriminazione. In questo modo viene evitata ogni polemica con l’Islam nel suo insieme, e si ribadisce il rifiuto di identificare la comunità musulmana con quei suoi membri che esprimono posizioni estremiste. Anche tra i musulmani italiani, frattanto, emergono figure che chiedono direttamente di essere considerate parte del Paese, come efficacemente rimarcato da Pallavicini: «Il rischio è di continuare a compiere l’equazione: musulmani = poveri immigrati ignoranti», sebbene egli stesso riconosca che ancora oggi circa il 90% dei musulmani presenti in Italia non siano cittadini né italiani né europei. Una preoccupazione, la sua, che non sembra del tutto ingiustificata rispetto all’atteggiamento ufficiale della Chiesa Cattolica Italiana, la quale nei suoi documenti dedicati sembra frequentemente supporre che le persone musulmane presenti in Italia siano per lo più non italiane, e si trovino in situazione di bisogno e povertà tanto economica quanto sociale e culturale. Per contro «la Chiesa italiana, per buona parte, sembra contestare la logica della polarizzazione e si sforza di introdurre elementi di pacatezza nel dibattito [sull’accoglienza degli immigrati musulmani], rifiutando tanto l’integralismo e il fanatismo, quanto gli atteggiamenti rinunciatari o la temuta “omologazione delle differenze”. […] Che questo atteggiamento non significhi, poi, una accettazione debole di prove di forza o la volontà di un dialogo forzato a tutti i costi, lo si può dedurre anche dalla richiesta puntuale di una “controparte”, ovvero di una reciprocità fatta non soltanto di rapporti asimmetrici, ma omogenei.
Sintesi: La Chiesa italiana, in queste prime decadi del XXI secolo, ha mostrato di avere ormai maturato un approccio pastorale originale e peculiare alla presenza dell’Islam nel Paese. Se da un lato si tiene conto delle preoccupazioni manifestate da una nazione che è stata colta di sorpresa da questo evento, dall’altro rimane decisiva la fedeltà alla prassi evangelica dell’accoglienza e del dialogo. Sia pure non sempre in modo ordinato, tanto gli organi nazionali che le realtà regionali, diocesane e parrocchiali hanno fin dagli anni ’90 attivato percorsi di incontro e conoscenza verso le persone musulmane e l’Islam in quanto tale. Ad oggi pare che non vi siano significative incertezze in merito al vissuto quotidiano, quanto piuttosto si avverte la necessità di una fondazione teologica fruibile anche dal comune credente. Per andare oltre l’accoglienza del povero e dello straniero, la Chiesa italiana deve ancora precisare quale lettura di fede faccia della presenza dell’Islam in Italia e del suo essere ormai costitutivamente ed irrevocabilmente parte della realtà nazionale.
Conclusione.
La lunga analisi fin qui condotta ci sembra offrire un’indicazione chiara: pur nell’estrema varietà di rapporti e di soggetti ecclesiali coinvolti, la Chiesa in Italia pare essersi rapportata con l’Islam soprattutto in risposta a puntuali questioni di tipo politico ed economico, oppure nell’ambito della propaganda missionaria, dell’apologia e della confutazione. Sebbene non siano mancate genuine testimonianze di carità pastorale e di seria intenzione di ricerca scientifica, la Chiesa mostra di non avere ancora definito una valutazione teologica del fenomeno islamico, della figura di Maometto e del suo Corano. Questa lacuna rende assai difficile impostare un percorso di relazione sia per la Chiesa gerarchica nell’ambito istituzionale che per le comunità locali ed i singoli fedeli nella quotidianità e nella vita privata. Da parte loro i fedeli dell’Islam in Italia, oggi, sperimentano ancora il sentirsi quasi esclusivamente oggetto di cure caritative, legati al mondo degli stranieri immigrati e della povertà, reclamando un sempre più concreto riconoscimento come interlocutori pienamente inseriti nella realtà italiana ed alla pari. Nel secondo decennio del XXI secolo ci si trova così ad un passaggio di ripensamento radicale dei rapporti e delle prassi, che deve tenere conto di istanze teologiche e sociali in egual misura.
Fonti e Bibl. essenziale
AA.VV., Atti del Simposio su Il Piano per la Rigenerazione dell’Africa e le Regole del 1871, Archivio Madri Nigrizia, Anno XIV n.23, Settembre 2013; AA.VV., Guida all’Islam in Italia, Airplane, Bologna 2005; Accattoli Luigi, Islam, EDB, Bologna 2004; Anawati Georges Chehata, Islam e Cristianesimo: l’incontro tra due culture nell’Occidente medioevale, Vita e Pensiero, Milano 1994; Bausani Alessandro, Cinquant’anni di islamistica, in Pubblicazioni dell’Istituto per l’Oriente 63, Scuola Grafica Don Bosco, Roma 1971, 1-26; Bono Salvatore, Relazioni commerciali fra Italia e paesi arabi dal medioevo al secolo XIX, in S. Bono e A. Tramontana, Italia e paesi arabi nell’economia internazionale, Edizioni Franco Angeli, Milano 1982, 17-35; Branca Paolo, Noi e l’Islam. Dall’accoglienza al dialogo. Vent’anni dopo, EMP, Padova 2010; Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna, Islam e Cristianesimo, in Documenti Chiese locali 99, EDB, Bologna 2000; Conferenza Episcopale Siciliana, Per un discernimento cristiano sull’Islam, Paoline, Torino 2004; Conferenza Episcopale Triveneta, Cristiani e Musulmani in dialogo, in Il Regno-documenti 7, 1992; Conferenza Episcopale Triveneta, Le vie dell’incontro. Quale dialogo con i musulmani?, in Documenti Chiese locali136, EDB, Bologna 2006; Cipollone Giuseppe, Cristianità – Islam: cattività e liberazione in nome di Dio; il tempo di Innocenzo III dopo il 1187, Gregorian University Press2, Roma 2003; D’Ancona Amedeo, La leggenda di Maometto in Occidente, Salerno Ed., Roma 1994; D’Errico Gian Luca (a cura di), Il Corano e il Pontefice, Carocci Editore, Bari 2014; De Liguori Alfonso Maria, Storia delle eresie colle loro confutazioni, in De Liguori Alfonso Maria, Opere, Marietti, Torino, 1857, vol. 8, 5-440; De Liguori Alfonso Maria, Verità della fede, in De Liguori Alfonso Maria, Opere, Marietti, Torino, 1857, vol. 8, 536-786; Feniello Amedeo, Sotto il segno del leone, Laterza, Bari 2011; Ferrari Silvio, Musulmani in Italia, Il Mulino, Rastignano (BO) 2000; Gabrieli Francesco, La colonia saracena di Lucera e la sua fine, in Archivio Storico Pugliese, Anno XXX, fasc. I-IV 1997, 169-175; Giovanni Damasceno, Controversia tra un Saraceno e un Cristiano, Centro Ambrosiano, Milano 1998; Giovanni Damasceno, La centesima eresia, Centro Ambrosiano, Milano 1997; Giovanni Paolo II, Insegnamenti, LEV, Città del Vaticano 1987, vol. IX,2; González Fernández Fidel, Daniele Comboni e la rigenerazione dell’Africa. Piano, postulatum, regole, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2003; Heyberger Bernard, L’islam dei missionari cattolici (Medio Oriente, Seicento), in B. Heyberger, M. Garcia-Arenal, E. Colombo, P. Vismara, L’Islam visto da Occidente: cultura e religione del seicento europeo di fronte all’Islam, Marietti 1820, Genova 2009, 289-314; Hoeberichts Jan, Francesco e l’Islam, Ed. Messaggero, Padova 2002; Ianari Vittorio, Lo stivale nel mare, Guerini e Associati, Milano 2006; Ibn Gubayr, Viaggio in Sicilia e in altri paesi del Mediterraneo, Sellerio, Palermo 1981; Leoni Alberto, La croce e la mezzaluna, Edizioni Ares, Città di Castello (PG) 2002; Mansur Baudo ‘Abd al Hayy, La storia dell’Islam in Italia, in Associazione Italiana Internazionale per l’Informazione sull’Islam (a cura di), L’Islam e l’Italia, La Sintesi Editrice, Milano 1996, 117-124; Martini Carlo Maria, Noi e l’Islam, in Comunicare nella Chiesa e nella società, EDB, Bologna 1991, 609-623; Monaco Massimiliano, Agostino da Traù, Edizioni Terzo Millennio, Foggia 2001. Data la difficoltà di reperire il testo, segnaliamo anche una sua versione online: https://books.google.it/books?id=zpntu9EKdMkC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false; Nanni Stefania, Figure dell’impero turco nella Roma del Seicento, in B. Heyberger, M. Garcia-Arenal, E. Colombo, P. Vismara, L’Islam visto da Occidente: cultura e religione del seicento europeo di fronte all’Islam, Marietti 1820, Genova 2009, 187-213; Negri Augusto Tino, I cristiani e l’islàm in Italia, Elledici Torino 2001; Pacini Andrea, Chiesa e Islam in Italia, Paoline, Milano 2008; Pallavicini Yahya Sergio Yahe, L’Islam in Europa, Il Saggiatore, Milano 2004; Pedani Maria Pia, Oltre la retorica: il pragmatismo veneziano di fronte all’Islam, in B. Heyberger, M. Garcia-Arenal, E. Colombo, P. Vismara, L’Islam visto da Occidente: cultura e religione del seicento europeo di fronte all’Islam, Marietti 1820, Genova 2009, 171-185; Perotti Barra Giancarla, Sposare un musulmano, Effatà Editrice, Grugliasco (TO) 2001; Pizzo Paola e Gutterez Valeria, I Cristiani e l’Islam, rivista Sette e Religioni 8, ESD, Bologna 1996; Romanato Gianpaolo, L’Africa nera fra Cristianesimo e Islam, l’esperienza di Daniele Comboni, Corbaccio, Milano 2003; Romanato Gianpaolo, L’Italia fuori d’Italia: le missioni, in Acerbi Antonio, La Chiesa e l’Italia, Vita e Pensiero, Milano 2003, 341-364; Rizzi Giovanni, Da Lepanto a Passarowitz: echi dello scontro con gli Ottomani sulla religiosità e la cultura popolare in Italia, in B. Heyberger, M. Garcia-Arenal, E. Colombo, P. Vismara, L’Islam visto da Occidente: cultura e religione del seicento europeo di fronte all’Islam, Marietti 1820, Genova 2009, 159-169; Rizzi Massimo, Le prime traduzioni del Corano in Italia: contesto storico e attitudine dei traduttori, L’Harmattan Italia, Torino 2007; Rizzitano Umberto, Gli Arabi in Italia, in Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, L’Occidente e l’Islam nell’Alto Medioevo, Arti Grafiche Panetto & Petrelli, Spoleto 1965; Silvano Carlo, Cristiani e musulmani, Edizioni del noce, Villa del Conte (PD) 2003; Schiapparelli Celestino,‘Al ’Umari: notizie d’Italia, Tipografia della Reale Accademia dei Lincei, Roma 1888; Stasolla Maria Giovanna, Gli Arabi nella penisola italiana, in Accademia Nazionale dei Lincei, Giornata di studio: testimonianze degli Arabi in Italia, A. tip. Eredi dott. G. Bardi S.r.l., Roma 1988, 77-94; Tragella Giovanni Battista, L’impero di Cristo: le missioni cattoliche nel mondo, La Nuova Italia, Firenze 1941; Tramontana Salvatore, Sant’Agata e la religiosità della Catania normanna, in Zito Gaetano (a cura di), Chiesa e società in Sicilia vol. I, Società Editrice Internazionale, Torino 1995, 189-202; Vanni Rovighi Sofia, Introduzione a Tommaso D’Aquino, Laterza2, Bari 1981; Ventura Alberto, Gli Arabi in Italia, in Accademia Nazionale dei Lincei, Convegno sul tema: Fenici e Arabi nel Mediterraneo, La Roccia, Roma 1983,193-207; Vismara Paola, Conoscere l’Islam nella Milano del Sei-Settecento, in B. Heyberger, M. Garcia-Arenal, E. Colombo, P. Vismara, L’Islam visto da Occidente: cultura e religione del seicento europeo di fronte all’Islam, Marietti 1820, Genova 2009, 215-252; Zatti Giuliano, L’Islam d’Italia, racconto di un percorso, in Islamochristiana, 33/2007, 163-197; Zonta Bernardo, I matrimoni tra cattolici e musulmani, in Communio, 147 (1996), 66-81.
LEMMARIO
- Accrocca Felice
- Amarante Alfonso
- Ambiente – vol. II
- Anticlericalismo – vol. I
- Anticlericalismo – vol. II
- Antigesuitismo – vol. I
- Antigesuitismo – vol. II
- Apologetica – vol. I
- Apologetica – vol. II
- Apruzzese Sergio
- Archeologia – vol. I
- Archeologia – vol. II
- Architettura – vol. I
- Architettura – vol. II
- Archivi ecclesiastici – vol. I
- Archivi ecclesiastici – vol. II
- Archivi militari – vol. II
- Arianesimo – vol. I
- Arte cristiana – vol. I
- Arte cristiana – vol. II
- Assemblea Costituente – vol. II
- Assistenza – vol. I
- Assistenza – vol. II
- Associazionismo cattolico – vol. II
- Ateismo – vol. I
- Azione Cattolica – vol. II
- Barbari – vol. I
- Barbierato Federico
- Barocco – vol. I
- Battelli Giuseppe
- Belluomini Flavio
- Benedetti Marina
- Beneficio ecclesiastico – vol. I
- Besostri Fabio
- Bibbia – vol. I
- Bibbia – vol. II
- Biblioteche – vol. I
- Biblioteche – vol. II
- Boaga Emanuele †
- Bocci Maria
- Bonini Francesco
- Bonora Elena
- Brancatelli Stefano
- Brywczynski Michal
- Bua Pasquale
- Buffon Giuseppe
- Cabizzosu Tonino
- Calabrese Gianfranco
- Canonici Regolari – vol. I
- Capitoli cattedrali, Collegiate – vol. I
- Cargnello Giulio
- Cassiani Gennaro
- Castelli Emanuele
- Castelli Francesco
- Casuistica – vol. I
- Catari – vol. I
- Catechesi, Catechismi – vol. I
- Catechesi, Catechismi – vol. II
- Cattolicesimo intransigente – vol. I
- Cattolicesimo intransigente – vol. II
- Cattolicesimo liberale – vol. I
- Cattolicesimo liberale – vol. II
- Cattolicesimo politico – vol. II
- Cattolici del dissenso – vol. II
- Cattolici di rito orientale – vol. II
- Cavallotto Stefano
- Cazzulani Guglielmo
- Censura ecclesiastica – vol. I
- Censura ecclesiastica – vol. II
- Centri culturali – vol. II
- Chierici Regolari – vol. I
- Chiese Ortodosse – vol. I
- Chiese Ortodosse – vol. II
- Ciampani Andrea
- Cipollini Francesco
- Ciriello Caterina
- Cito Davide
- Civiero Tiziano
- Clero secolare – vol. I
- Clero secolare – vol. II
- Coco Giovanni
- Collegi – vol. I
- Colonialismo – vol. II
- Colzani Gianni
- Comunismo – vol. II
- Concili ecumenici – vol. I
- Concili, Sinodi – vol. I
- Concili, Sinodi – vol. II
- Concilio di Trento – vol. I
- Concilio Vaticano I – vol. II
- Concilio Vaticano II – vol. II
- Concilio Vaticano II, Recezione – vol. II
- Concordati – vol. I
- Concordati – vol. II
- Conferenza Episcopale Italiana – vol. II
- Conferenze Episcopali Regionali – vol. II
- Confessione, Penitenza – vol. I
- Confessione, Penitenza – vol. II
- Confraternite laicali – vol. I
- Confraternite laicali – vol. II
- Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari – vol. II
- Congregazione dei Vescovi e Regolari – vol. I
- Congregazione del Sant’Uffizio – vol. I
- Congregazione del Sant’Uffizio – vol. II
- Congregazione dell’Indice – vol. II
- Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica – vol. II
- Congregazione per i Vescovi – vol. II
- Congregazione per il Clero – vol. II
- Congregazioni religiose femminili – vol. I
- Congregazioni religiose femminili – vol. II
- Congregazioni religiose maschili – vol. I
- Congregazioni religiose maschili – vol. II
- Congressi eucaristici – vol. II
- Conservatori – vol. I
- Conversioni – vol. I
- Conversioni – vol. II
- Costanzo Alessandra
- Credo – vol. I
- Crociate – vol. I
- Culto e devozioni – vol. I
- Culto e devozioni – vol. II
- De Giorgi Fulvio
- De Palma Luigi Michele
- Dell’Omo Mariano
- Democrazia – vol. II
- Democrazia Cristiana – vol. II
- Di Carpegna Falconieri Tommaso
- Di Girolamo Luca
- Diaconato – vol. I
- Diaconato – vol. II
- Dibisceglia Angelo Giuseppe
- Dieguez Alejandro M.
- Diocesi – vol. II
- Diritti umani – vol. II
- Diritto Canonico – vol. I
- Diritto Canonico – vol. II
- Dohna Schlobitten Yvonne
- Donato Maria Pia
- Donna – vol. II
- Ebrei – vol. I
- Ebrei – vol. II
- Ecclesiologia – vol. I
- Ecclesiologia – vol. II
- Ecumenismo – vol. I
- Ecumenismo – vol. II
- Editoria – vol. I
- Editoria – vol. II
- Educazione – vol. I
- Educazione – vol. II
- Emigrazione, Immigrazione – vol. I
- Emigrazione, Immigrazione – vol. II
- Episcopato – vol. I
- Episcopato – vol. II
- Eremitismo – vol. I
- Eremitismo – vol. II
- Ernesti Jörg
- Eterodossia, Eresia – vol. I
- Etica economica – vol. II
- Europa – vol. I
- Europa – vol. II
- Evangelizzazione – vol. I
- Evangelizzazione – vol. II
- Falzone Maria Teresa †
- Famiglia – vol. I
- Famiglia – vol. II
- Fantappiè Carlo
- Fascismo (1919-1931) – vol. II
- Feliciani Giorgio
- Ferri Giacomo
- Feudalità ecclesiastica – vol. I
- Filosofia – vol. I
- Filosofia – vol. II
- Finanze ecclesiastiche – vol. II
- Foa Anna
- Folclore – vol. I
- Folclore – vol. II
- Formigoni Guido
- Fosi Irene
- Fragnito Gigliola
- Fumetto – vol. II
- Fusar Imperatore Paolo
- Galleni Ludovico
- Gallo Federico
- Garbellotti Marina
- Geografia ecclesiastica, Diocesi – vol. II
- Giaccardi Chiara
- Giansenismo – vol. I
- Giornali, Riviste cattoliche – vol. I
- Giornali, Riviste cattoliche – vol. II
- Giornalismo – vol. II
- Giurisdizionalismo – vol. I
- Giuspatronato – vol. I
- Giustizia ecclesiastica – vol. II
- Gorla Stefano
- Grande Scisma – vol. I
- Greco Gaetano
- Gregorini Giovanni
- Grignani Mario L.
- Grossi Roberta
- Guasco Alberto
- Guasco Maurilio
- Guelfismo, Ghibellinismo – vol. I
- Illuminismo, Aufklärung cattolica – vol. I
- Industrializzazione – vol. II
- Inquisizione (età medievale) – vol. I
- Inquisizione (età moderna) – vol. I
- Islam – vol. I
- Islam – vol. II
- Istituti di scienze religiose – vol. II
- Istituti secolari – vol. II
- L’Università Cattolica del Sacro Cuore – vol. II
- La Rosa Luigi
- Laicità, Laicismo – vol. I
- Laicità, Laicismo – vol. II
- Laico, Laicato – vol. I
- Laico, Laicato – vol. II
- Lameri Angelo
- Landi Fiorenzo
- Lanfranchi Rachele
- Lentini Giuseppe
- Liberalismo – vol. I
- Liberalismo – vol. II
- Libertà religiosa – vol. II
- Libertinismo – vol. I
- Liccardo Giovanni
- Liturgia (dal I al VIII secolo) – vol. I
- Liturgia (dall’ VIII al XIX secolo) – vol. I
- Liturgia – vol. II
- Lombardi Daniela
- Loparco Grazia
- Lotta per le investiture – vol. I
- Lovison Filippo
- Maggioni Corrado
- Magia e stregoneria – Vol. I
- Majorana Bernadette
- Majorano Sabatino
- Malgeri Giampaolo
- Mancini Lorenzo
- Mancini Massimo
- Manfredi Angelo
- Maria Santissima – vol. I
- Maria Santissima – vol. II
- Mass-media – vol. II
- Massoneria – vol. I
- Massoneria – vol. II
- Mastantuono Antonio
- Medicina – vol. I
- Menniti Ippolito Antonio †
- Migranti – vol. II
- Millenarismo – vol. I
- Millenarismo – vol. II
- Miniatura – vol. I
- Missioni estere – vol. I
- Missioni estere – vol. II
- Missioni interne – vol. I
- Missioni interne – vol. II
- Modernismo – vol. II
- Modernità – vol. II
- Mondo Monica
- Monetazione papale tra XV e XVI secolo. La Zecca di Roma – vol. I
- Monti di Pietà – vol. I
- Morale – vol. I
- Morale – vol. II
- Morandini Simone
- Movimenti ecclesiali – vol. II
- Mutegeki Robert
- Muzzarelli Maria Giuseppina
- Neoguelfismo – vol. I
- Nunziatura – vol. II
- Nunziature – vol. I
- Nuove comunità – vol. II
- Oratori – vol. II
- Oratori e Compagnie – vol. I
- Ordini mendicanti – vol. I
- Ordini mendicanti – vol. II
- Ordini militari – vol. I
- Ordini militari – vol. II
- Ordini monastici – vol. II
- Ordini monastici femminili – vol. I
- Ordini monastici maschili – vol. I
- Ospedali – vol. I
- Ospedali – vol. II
- Padovan Gianluca
- Paganesimo – vol. I
- Paganesimo – vol. II
- Parrocchie – vol. I
- Parrocchie – vol. II
- Partito Popolare – vol. II
- Pataria – vol. I
- Patria, Nazione – vol. I
- Patria, Nazione – vol. II
- Pavone Sabina
- Pelaja Margherita
- Pellegrinaggio – vol. I
- Pellegrinaggio – vol. II
- Pereira Sergio
- Persecuzioni – vol. I
- Persecuzioni – vol. II
- Picardi Paola
- Pietà – vol. II
- Pietà illuminata – vol. I
- Pietroforte Stefania
- Pieve – vol. I
- Pinna Diego
- Pioppi Carlo
- Pittura – vol. I
- Pittura, Scultura – vol. II
- Pizzorusso Giovanni
- Poli Paolo
- Predicazione – vol. I
- Predicazione – vol. II
- Prelatura personale – vol. II
- Prima Guerra Mondiale – vol. II
- Probabilismo – vol. I
- Proprietà ecclesiastica – vol. I
- Proprietà ecclesiastica – vol. II
- Protestantesimo – vol. I
- Protestantesimo – vol. II
- Questione meridionale – vol. II
- Questione romana – vol. II
- Questione sociale – vol. II
- Quietismo – vol. I
- Regoli Roberto
- Religiosità popolare – vol. II
- Reliquie – vol. I
- Reliquie – vol. II
- Resistenza – vol. II
- Riforma cattolica, Controriforma – vol. I
- Riforma gregoriana – vol. I
- Riforma protestante – vol. I
- Rinascimento – vol. I
- Rinascimento carolingio – vol. I
- Rivoluzione francese – vol. I
- Rizzi Giovanni
- Rocca Giancarlo
- Rocciolo Domenico
- Roma, Romanità – vol. I
- Roma, Romanità – vol. II
- Romanato Gianpaolo
- Romanticismo cattolico – vol. I
- Rosa Mario
- Rosminianesimo – vol. I
- Rurale Flavio
- Rusconi Roberto
- Sacro romano impero – vol. I
- Sanfilippo Matteo
- Santità – vol. II
- Santuari – vol. I
- Santuari – vol. II
- Satira – vol. I
- Satire: temi, espressioni, condanne – vol. I
- Saverio Venuto Francesco
- Savigni Raffaele
- Scatena Silvia
- Scienza – vol. I
- Scienza, medicina, biologia – vol. II
- Scismi – vol. II
- Scultura – vol. I
- Scuola – vol. I
- Scuola – vol. II
- Segreteria di Stato – vol. II
- Seminari – vol. I
- Seminari – vol. II
- Sessantotto – vol. II
- Sessualità – vol. I
- Silva Cesare
- Sindacati – vol. II
- Siniscalco Paolo
- Socialismo – vol. II
- Sodi Stefano
- Soler Jaume
- Soppressioni – vol. I
- Soppressioni – vol. II
- Soppressioni, Beni culturali – vol. I
- Soppressioni, Beni culturali – vol. II
- Sostentamento del clero – vol. II
- Spiriti Andrea
- Spiritualità – vol. I
- Spiritualità – vol. II
- Sport – vol. II
- Sportelli Francesco
- Stati preunitari – vol. I
- Stato – vol. II
- Stato della Città del Vaticano – vol. II
- Storia della Pietà (Giuseppe de Luca) – vol. II
- Storiografia (età antica) – vol. I
- Storiografia (età contemporanea) – vol. II
- Storiografia (età medievale) – vol. I
- Storiografia (età moderna) – vol. I
- Tanner Norman
- Tanzarella Sergio
- Teatro – vol. I
- Teatro – vol. II
- Teologia – vol. I
- Teologia – vol. II
- Terrorismo – vol. II
- Terz’ordini – vol. I
- Tessaglia Stefano
- Tolleranza – vol. I
- Tomassoni Roberto
- Tosti Mario
- Tradizionalismo – vol. II
- Trampus Antonio
- Tribunali della Curia romana – vol. I
- Tuninetti Giuseppe
- Turchini Angelo
- Università – vol. I
- Valdesi – vol. I
- Valeri Elena
- Valli Norberto
- Valtellina: Riforma/Riforme – vol. I
- Valvo Paolo
- Vecchio Giorgio
- Venturi Giampaolo
- Visite ad limina – vol. I
- Visite ad limina – vol. II
- Visite apostoliche – vol. I
- Visite apostoliche – vol. II
- Visite pastorali – vol. I
- Visite pastorali – vol. II
- Vitali Dario
- Von Teuffenbach Alexandra
- Web – vol. II
- Xeres Saverio
- Zamboni Lorenzo
- Zingari, Nomadi – vol. I
- Zingari, Nomadi – vol. II
- Zovatto Pietro