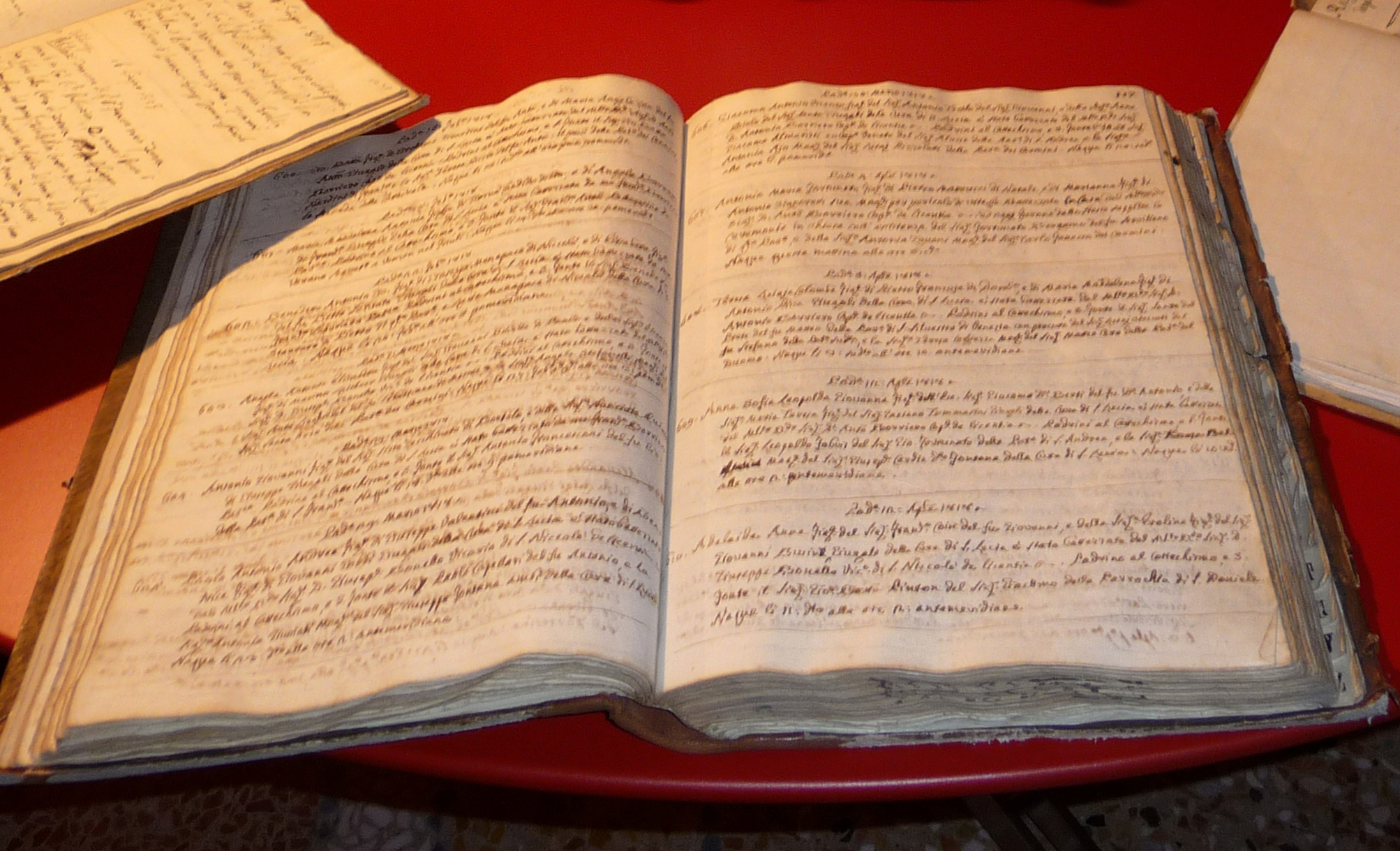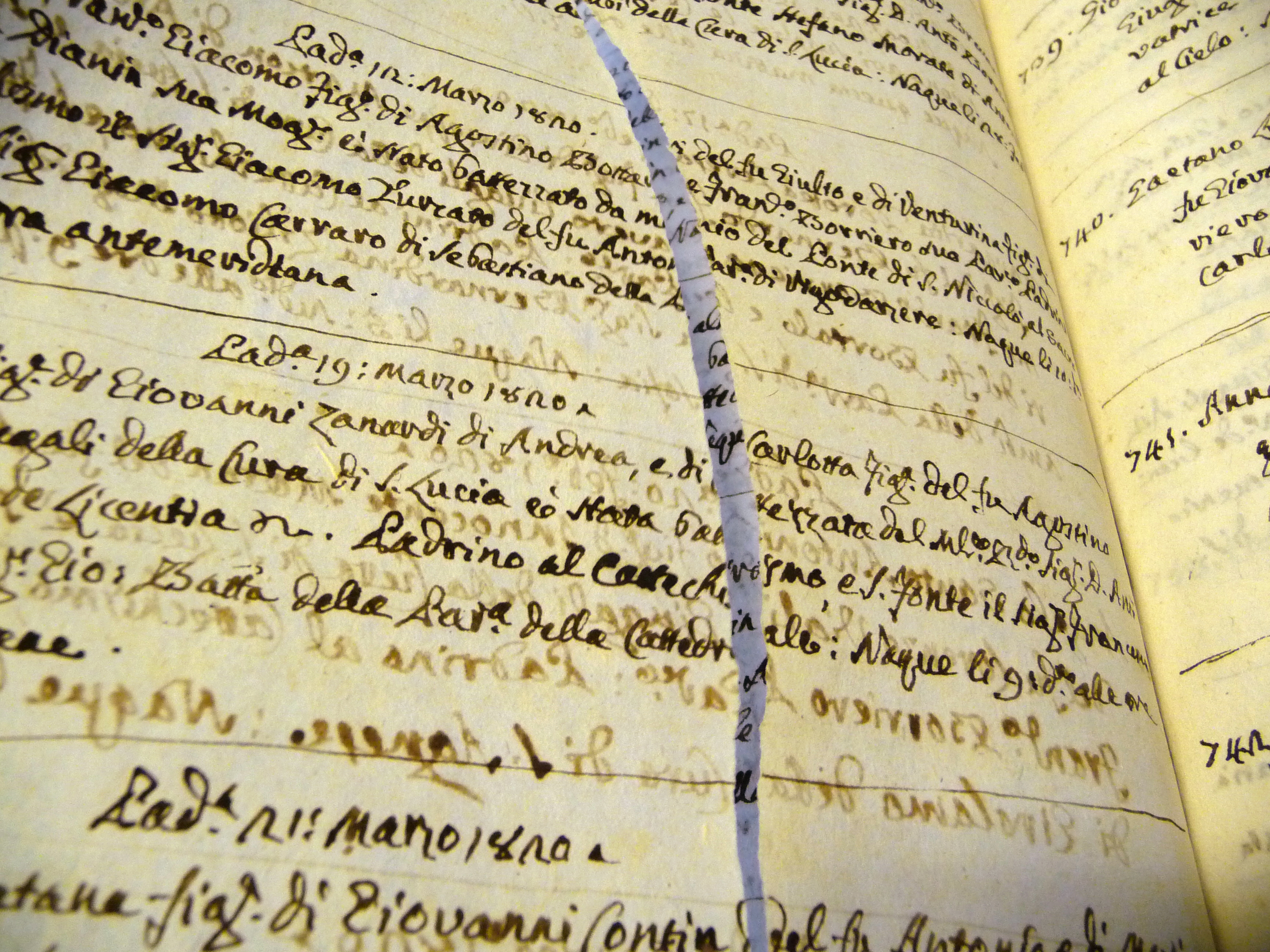Autore: Carlo Fantappiè
Nella storia dei patti, accordi, convenzioni, concordati tra la Santa Sede e gli Stati preunitari italiani si possono distinguere nettamente tre fasi, corrispondenti ad altrettante fasi significative del contesto europeo: a metà del Quattrocento, nella prima metà del Settecento, nella Restaurazione. Il clima di queste tre epoche è ovviamente molto diverso, così come l’andamento, l’oggetto e la portata dei singoli concordati. C’è però una costante, ed è il peso decisamente minore che gli accordi con i piccoli Stati italiani hanno rivestito lungo queste epoche a differenza di quelli conclusi con gli altri Stati dell’Europa. Certamente la presenza del papa e della Corte di Roma nella penisola hanno reso meno frequente, se non inutile, il ricorso ad atti bilaterali con i sovrani per regolare materie o risolvere controversie a motivo dei rapporti diretti del papa e delle fitte relazioni politico-diplomatiche. Ma anche la natura di tali accordi è differente, perché mancano convenzioni destinate a regolare nel suo complesso il regime giuridico della Chiesa di uno Stato. Fino al concordato italiano del 1803, che nell’aspetto formale risente dell’influenza del concordato con la Francia del 1801, non si dovrebbe neppure parlare di una moderna convenzione diplomatica quanto di pattuizioni dirette a regolare l’esercizio di certi diritti di entrambe le parti oppure a comporre un conflitto su una materia determinata nelle relazioni tra esse. Va infine osservato che, mentre nell’antico regime si agiva sul presupposto della superiore e armonica concordia tra le due potestà, dopo Napoleone si stipulano concordati sulla base del principio di uguaglianza tra le parti.
A metà Quattrocento, mentre i «concordati con le nazioni» risentono delle conseguenze della crisi conciliarista che aveva colpito il papato, quelli con gli Stati italiani s’inquadrano nel progressivo inserimento del papato nel sistema politico della penisola e tendono a creare una situazione di equilibrio e di stabilizzazione mediante la regolamentazione delle materie dei benefici e delle immunità ecclesiastiche secondo le forze in campo. Due aree hanno la preminenza sulle altre: il regno di Sicilia, dove Ferdinando I si trova a dover attenuare le prerogative giurisdizionali della casa d’Aragona rispetto al papato, che deteneva sul regno il diritto d’investitura feudale (si vedano i patti di pace del 1486-1492), e il regno di Savoia dove, in compenso della rinuncia spontanea di Amedeo VIII alla tiara, la casa regnante ottiene dalla Santa Sede notevoli concessioni in materia di riserva di benefici e di nomine ecclesiastiche (indulto di Niccolò V del 1452 rinnovato e innovato da diversi papi fino al 1819).
Ben diversa la situazione della prima metà del Settecento, quando la Santa Sede si trova in posizione difensiva e ricerca una «concordia» con gli Stati assoluti. Oggetto centrale delle convenzioni stipulate tra il 1720 e il 1758 da Benedetto XIII, Clemente XII e Benedetto XIV non sono tanto le materie beneficiarie o giurisdizionali quanto le materie immunitarie e disciplinari. Poiché gli abusi della vita clericale erano spesso coperti dal privilegio dell’immunità, gli Stati tendono ad abbinare le due questioni e a presentare le loro richieste come mezzi per ristabilire la disciplina ecclesiastica sancita dal concilio di Trento. Di fatto i governi assoluti tendono a intervenire nella vita della Chiesa ricorrendo agli iura circa sacra per estendere il loro potere politico e rimodellare gli assetti delle chiese nazionali nelle strutture dello Stato (v. Giurisdizionalismo).
Mediante abili trattative diplomatiche, i Savoia, ora re di Sardegna, riescono a strappare a Benedetto XIII nel 1727 due concordati assai vantaggiosi sulle immunità ecclesiastiche e sulle materie beneficiarie. Dopo la dichiarazione di nullità del concordato da parte di Clemente XII, Benedetto XIV apre nuove trattative che conducono a due altre convenzioni nel 1741: una sui feudi pontifici del Piemonte che prevede l’investitura del re di Sardegna in modo che possa conferire benefici, l’altra sulla riserva dei benefici ecclesiastici a «persone ecclesiastiche». Con un’Istruzione ai vescovi del 6 gennaio 1742, pattuita col re di Sardegna e confermata dai papi fino al 1826, Benedetto XIV ottiene che dalla «visione» dei brevi e delle bolle papali da parte dell’autorità governativa siano esclusi gli atti di natura dogmatica, morale e disciplinare emanati dalle Congregazioni romane e dalla Penitenzieria. Tra il 1759 e il 1761 si giunge ad un’altra Istruzione di Clemente XIII che elimina gli abusi che si erano introdotti in materia di immunità e diritto di asilo, nell’ammissione al chiericato e nella disciplina ecclesiastica col fenomeno dei chierici coniugati.
Larghe concessioni vengono fatte da Benedetto XIV anche al regno di Napoli col concordato del 1741. Le trattative per un compromesso sembravano ben iniziate; gli ostacoli frapposti dai funzionari della Curia finiscono però per estendere le prerogative del regalismo borbonico. Su questa linea va letta la previsione del regio exequatur per le bolle e brevi pontifici, l’esclusione dalle immunità reali dei beni ecclesiastici e il conseguente obbligo di contribuzione alla tassazione governativa, la limitazione del diritto di asilo a luoghi predeterminati, la facoltà di reprimere gli abusi del privilegio del fòro compiuti da soggetti che non ne avevano il diritto, la riserva di tutti i benefici e pensioni ecclesiastiche ai soli regnicoli, l’istituzione di un tribunale misto per giudicare le controversie sulle immunità. Ispirati a princìpi di collaborazione tra le due potestà sono altre disposizioni dello stesso concordato: il controllo dei requisiti dei promovendi agli ordini sacri, il diritto di visita episcopale e di controllo dell’amministrazione di chiese, cappelle, confraternite, ospedali conservatori e altri luoghi pii, fatta eccezione di quelli posti sotto la protezione regia, l’introduzione della censura sui libri contrari alla fede e alla morale. Anziché appianare i conflitti giurisdizionali, questo concordato del 1741 spinge la politica del ministro Tanucci dopo il 1761 ad accelerare le riforme in senso anticuriale.
Nel complesso lo sforzo di papa Lambertini di superare l’isolamento politico della Chiesa e la subordinazione dalle potenze cattoliche non ottiene risultati positivi e prelude una radicalizzazione delle politiche statali in materia ecclesiastica dopo gli anni Sessanta Ne è prova il concordato di Pio VI con Giuseppe II del 1784 relativo alle nomine episcopali nella Lombardia austriaca che assegna al Duca di Milano e di Mantova, compresi i loro successori, il diritto di nomina dei principali uffici ecclesiastici delle chiese, abbazie, propositure e collegiate.
Come accennato, il concordato del 1803 tra Pio VII e la Repubblica italiana riveste più un’importanza tecnico-giuridica che storica, considerata la sua sostanziale inapplicazione per motivi connessi ai contrasti di vedute tra il Melzi e Napoleone e alle vicende politiche dell’Italia e dell’impero francese. In linea con la concezione centralizzatrice e amministrativa dello Stato napoleonico, questo concordato mira a riorganizzare, in maniera uniforme e gerarchica, le strutture ecclesiastiche nel territorio nazionale e ad affermare su di esse le prerogative del potere politico. Da qui il riassetto razionale delle circoscrizioni (province e diocesi), l’estensione del diritto di nomina del presidente della Repubblica a tutti i vescovati, il giuramento politico di vescovi e parroci, la composizione mista delle amministrazioni delle opere pie e il diritto presidenziale di nomina degli amministratori. Particolare cura si ha poi nell’estendere al presidente della Repubblica i diritti e le prerogative dell’imperatore e nell’ottenere la condonazione dei beni ecclesiastici alienati.
Al tempo stesso, però, il concordato del 1803 si rivela innovativo perché, nella regolazione delle materie strettamente ecclesiastiche, rinvia al diritto canonico e, sulle materie che potremmo definire miste, prevede una disciplina bilaterale. Da qui la libertà di comunicazione della Santa Sede con i vescovi, la libertà di ordinazione dei chierici, la direzione esclusiva dei seminari, il riconoscimento della potestà coattiva dei vescovi, la tutela penale della religione e dei suoi ministri, l’esenzione del clero dal servizio militare.
Nell’età della Restaurazione il clima politico-culturale muta in senso favorevole alla Santa Sede. L’abbandono di qualsiasi progetto di riforma esterna della Chiesa favorisce un maggiore riconoscimento della sua autonomia. Nonostante ciò, gli Stati difendono le conquiste essenziali del giurisdizionalismo settecentesco per una ragione eminentemente sociale e politica. La mescolanza di princìpi cesaro-papisti e confessionalisti che troviamo nel concordato del 1803 fa da sfondo anche al concordato del 1818 tra Pio VII e Ferdinando I re delle Due Sicilie. Anche qui è affermata la religione cattolica come religione di Stato, si abroga la legislazione precedente per sostituirla con il nuovo concordato e si rinvia alla vigente disciplina della Chiesa nelle materie o oggetti non negoziate. Ma anche qui si prende occasione del concordato per operare una vasta riorganizzazione politica delle strutture ecclesiastiche del regno, la quale investe sia gli aspetti patrimoniali (con la sanazione dei beni alienati, la restituzione parziale dei patrimoni non alienati, lo scorporo di una quota di beni del clero regolare a vantaggio delle istituzioni secolari), sia la rete istituzionale (con la riduzione delle circoscrizioni diocesane e il riordino degli ordini religiosi e delle abbazie), il sostentamento di parte del clero (con il supplemento di congrua a una quota di parroci). Nella sfera propriamente giurisdizionale, oltre ad abolire tutte le immunità, si afferma il regio exequatur e la competenza dei tribunali laici sulle cause degli ecclesiastici, il controllo statale sulle nomine episcopali anche di collazione pontificia mediante rilascio di apposito indulto papale e l’obbligo del giuramento dei vescovi, la riserva della collazione dei benefici semplici ai sudditi del regno, la limitazione delle ordinazioni sacerdotali e dell’ingresso dei novizi in proporzione ai mezzi di sussistenza. Viene invece considerato in netta controtendenza con queste disposizioni l’affidamento alla Chiesa del controllo sull’istruzione, il riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica sulle cause matrimoniali e la reintroduzione della censura religiosa sulla stampa. La compresenza di aspetti confessionalisti, regalisti e giurisdizionalisti ha indotto gli storici a dare valutazioni disparate del concordato del 1818. Forse bisognerebbe distinguere maggiormente tra le affermazioni di principio e l’effettiva prassi amministrativa. Nel dare esecuzione alle norme concordatarie le cancellerie della Restaurazione, a somiglianza dell’amministrazione napoleonica, introducono clausole limitative oppure condizionano l’esercizio delle libertà riconosciute alla Chiesa a verifiche e controlli piuttosto penetranti.
La tradizione giurisdizionalista di Pietro Leopoldo si mantiene ancora forte e radicata nell’amministrazione del Granducato di Toscana. Il concordato del 1815 per il ripristino degli ordini religiosi costituisce un’occasione per attuare una ristrutturazione organica della presenza del clero regolare in funzione delle attività sociali e educative dello Stato. La convenzione del 1851, nata per armonizzare la legislazione statuale con quella canonica in materia di cause civili o criminali del clero e per trovare un accordo, mediante delega a commissioni miste, tanto nella gestione dell’amministrazione delle entrate dei benefici vacanti quanto nel cambio di destinazione dei beni dei legati pii, invece che eliminare le differenze tra i diplomatici romani e gli apparati amministrativi locali, lascia dietro di sé uno strascico di controversie.
Assai diverso il contesto dello Stato sabaudo, dove si era andata consolidando dai primi decenni del Settecento una politica ecclesiastica di accordo con la Santa Sede. Nell’età della Restaurazione l’attività concordataria si restringe a due convenzioni minori relative alla riorganizzazione delle circoscrizioni ecclesiastiche del Piemonte (1817) e alla limitazione dell’immunità personale degli ecclesiastici circa alcuni reati (1841). Un cambiamento radicale si avrà negli anni 1848-1855, allorché si procederà con le leggi Siccardi all’abolizione del privilegio del fòro, del diritto d’asilo, delle decime nonché alla soppressione degli ordini religiosi.
Con l’unità d’Italia l’esigenza di uniformare su tutto il territorio nazionale la legislazione ecclesiastica conduce, nel 1860, all’abolizione dei concordati stipulati dagli ex-Stati con la Santa Sede, anche di quelli che avevano validità per singole regioni (come il concordato austriaco del 1855 per il Lombardo-Veneto) oppure all’introduzione di norme che rendessero inapplicabili gli impegni pattizi preesistenti.
Fonti e Bibl. essenziale
F. Ruffini, Relazioni tra Stato e Chiesa, Bologna 19742; A. Mercati, Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili, vol. I, 1098-1914, Città del Vaticano 19542; Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l’Italia, vol. I, Studi storici, Milano 1939; W. Maturi, Il concordato del 1818 tra la Santa Sede e le Due Sicilie, Firenze 1929; A.M. Bettanini, Il concordato di Toscana 25 aprile 1851, Milano 1933; D. Arru, Il concordato italiano del 1803, Milano 2003; F. Vecchi, Gli accordi tra potestà civili ed autorità episcopali, Napoli 2006; G. Paolini, Il concordato toscano del 1815 sugli ordini religiosi. Documenti inediti, Firenze 2006; M. Pignotti, Potestà laica e religiosa autorità. Il concordato del 1851 fra Granducato di Toscana e Santa Sede, Firenze 2007; M. Pellegrini, Il Rinascimento come stagione della politica concordataria, in Papato e politica internazionale nella prima età moderna, a cura di M.A. Visceglia, Roma 2013, 63-102; M. Rosa, Una rilettura della politica dei concordati nel Settecento, ivi, 173-197.