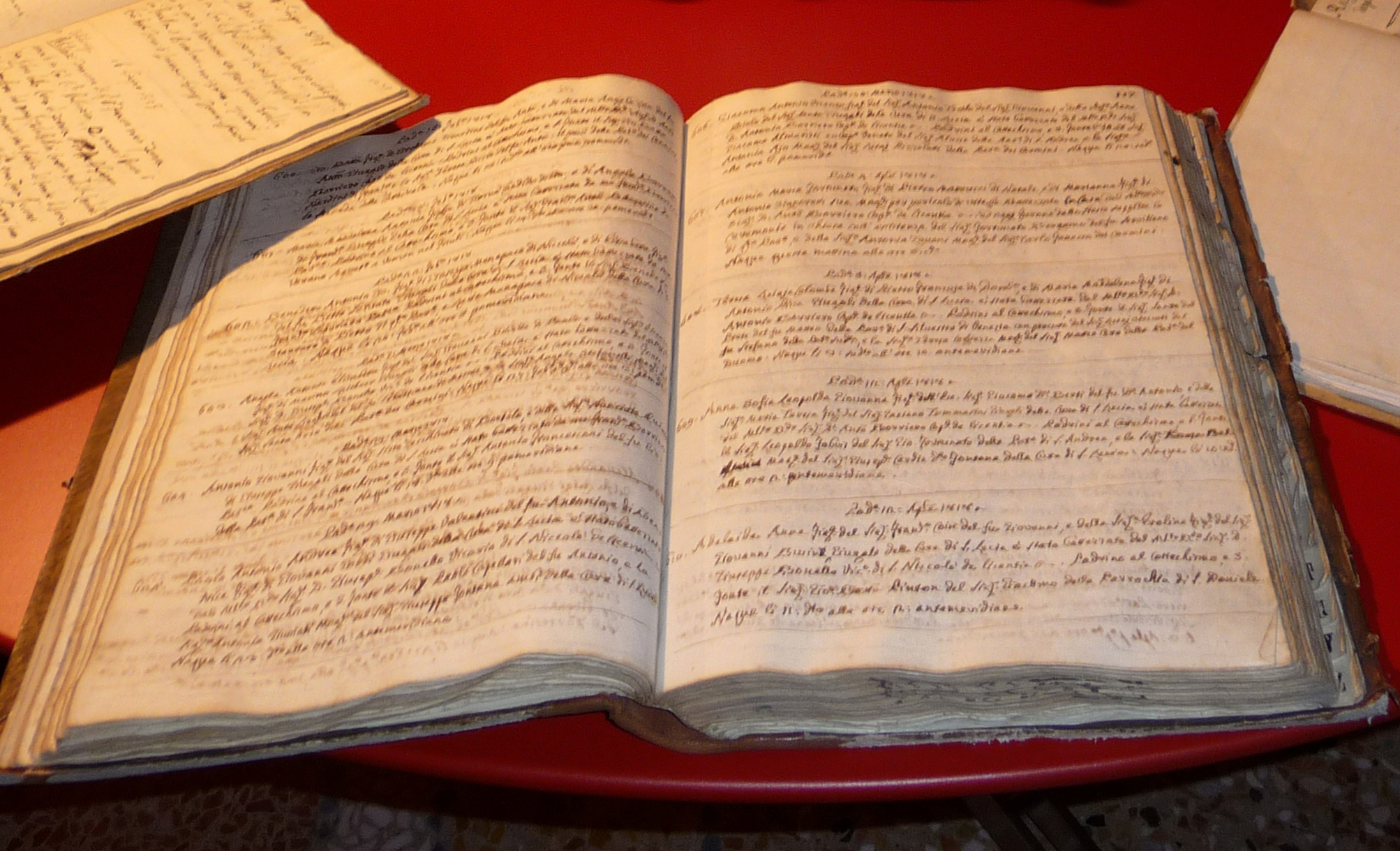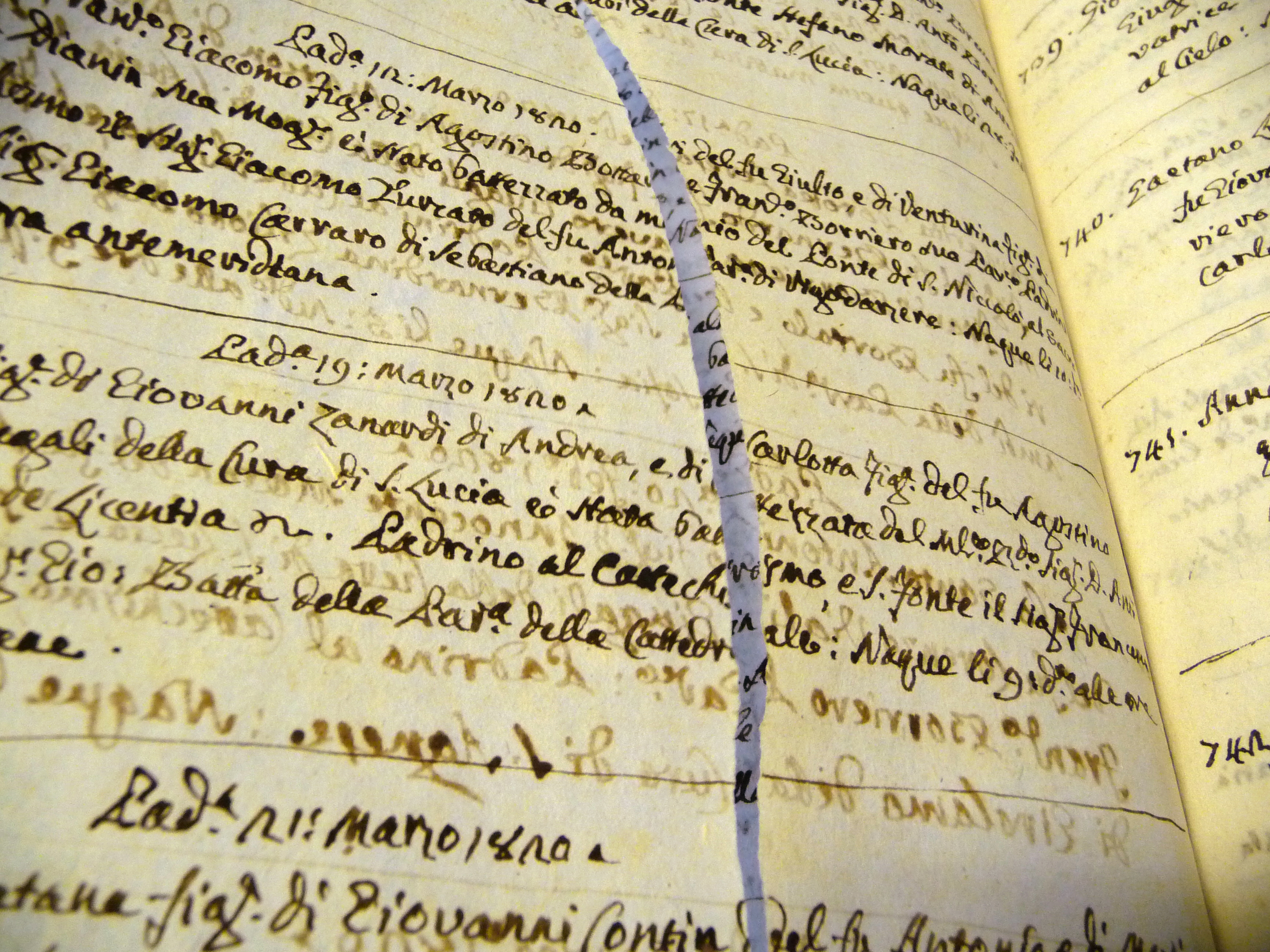Autore: Gaetano Greco
Nei primi secoli di diffusione del Cristianesimo non mancarono in Italia, come altrove, donne che scelsero una vita ascetica, rifiutando il matrimonio e vivendo ritirate nelle proprie case di famiglia nei due gradi di castità: quelle virgines, consacrate pubblicamente a questo stile di vita, e quelle viduae sacrae, la cui presenza, non sempre apprezzata dalla gerarchia ecclesiastica, si è prolungata per due millenni e perdura ancora oggi nella Chiesa cattolica. Le prime notizie certe su forme di vita ascetica organizzata risalgono alla metà del IV secolo d.C., in coincidenza del soggiorno a Roma del vescovo alessandrino Atanasio, e riguardano anche l’universo femminile, che all’inizio del movimento cenobitico assunse un ruolo di rilievo grazie alla partecipazione di donne, vergini o vedove, di estrazione aristocratica e con una discreta diffusione anche fuori Roma, da Verona alla Sicilia. Le donne, che praticavano questo stile di vita, singolarmente o in comunità, moderavano drasticamente il vitto e il vestiario, osservavano l’astinenza sessuale e conducevano una vita assai ritirata, prodromo di quella clausura, che nei secoli successivi caratterizzerà la vita monastica femminile sul piano disciplinare (almeno in via di diritto). Nuovo impulso venne poi dall’affermarsi in Italia del monachesimo benedettino: secondo la tradizione, Scolastica, sorella di Benedetto da Norcia, avrebbe fondato il monastero di Piumarola, nei presi di Montecassino, ma più certi e più importanti furono i monasteri di Sant’Agata a Pavia e di Santa Giulia a Brescia, fondati rispettivamente dai re longobardi Pertarito e Desiderio. Tuttavia, ancora in quell’epoca mancavano “regole” scritte appositamente per le comunità femminili, che forse adottavano quelle già in uso (di Basilio, di Pacomio-Gerolamo, di Benedetto, etc.).
Nell’Alto Medio Evo i monasteri femminili erano fondazioni regie o aristocratiche, con uno scarso numero di monache: in qualche caso si può accertare l’iniziativa o la presenza delle donne appartenenti a casati e clan nobili sconfitti politicamente. Perciò, alla stessa stregua di analoghe fondazioni maschili, talora questi monasteri costituivano un rifugio, voluto o imposto, per le donne in situazioni di violenza, subita o temuta, e per salvaguardare almeno parzialmente i beni di clan gentilizi sconfitti, che si ritiravano dentro queste istituzioni ecclesiastiche. In seguito, anche per questo monachesimo femminile si riscontra una lenta influenza del movimento cluniacense. Nell’XI secolo vi fu una ripresa delle fondazioni monastiche su base gentilizia, anche dentro le città comunali, con la dotazione di beni familiari comuni e conservando il patronato familiare nell’elezione della «badessa», spesso eletta a vita: come già in età longobarda e franca, in questi monasteri si ebbero vere e proprie dinastie di badesse appartenenti alle stirpi dei fondatori. La rinascita monastica del XII secolo portò alla nascita di nuove famiglie femminili, rami degli ordini maschili esenti: dalle Camaldolesi (1085) alle Vallombrosiane (1145), dalle Certosine (1228) alle Olivetane. In questo contesto di ripresa sono importanti le fondazioni femminili legate all’ordine dei Cistercensi: i monasteri di questo tipo si sottoponevano al governo spirituale del ramo maschile, che provvedeva tramite propri monaci all’amministrazione dei sacramenti alle monache.
Con lo sviluppo di una specifica religiosità cittadina e con l’affermazione degli Ordini Mendicanti nacquero, sul loro esempio e sotto la loro guida, monasteri del ramo femminile, come le Domenicane, la cui istituzione, intorno al 1206, si deve allo stesso s. Domenico in Provenza, a Prouille nei pressi di Tolosa, recuperando donne sottratte all’eresia catara. A Roma, poi, nel dicembre del 1219 papa Onorio III affidò a Domenico la cura delle monache confluite nel monastero istituito, per volontà di Innocenzo III, presso la basilica di S. Sisto. Le «sorelle povere» o «povere donne» (o Secondo Ordine di s. Francesco, più note con il nome di Clarisse) furono fondate da Chiara di Favarone di Offreduccio, cugina di s. Francesco, che nel 1212 prima si fece monaca benedettina e poi si stabilì presso la chiesa rurale di S. Damiano, vicino ad Assisi. La sua Regola fu accettata formalmente da papa Innocenzo IV solo quarant’anni dopo, il 9 agosto del 1253, pochi giorni prima della sua morte; eppure, il successo dell’impresa di Chiara era stato testimoniato dalle decine di conventi femminili sorti ad imitazione del suo nel giro di pochi anni. Agli inizi, Chiara e le sue consorelle si erano ritirate a vivere in ospizi nei pressi delle città, si mantenevano con il proprio lavoro e rifiutavano le donazioni di beni e le offerte; ma già dal 1229 anche alle Povere Donne erano state imposte le due norme tradizionali delle fondazioni monastiche femminili: il possesso dei beni e la clausura. A partire dalla fine del XIII secolo comparvero le Eremitane Agostiniane, che formarono il ramo femminile degli Agostiniani, chiedendo ed ottenendo di porsi sotto il loro governo e la loro assistenza spirituale: il primo monastero italiano fu quello di S. Maria Maddalena di Orvieto, istituito il 16 giugno 1286, al quale seguì nella stessa città il monastero di S. Caterina, ma la vicenda della fondazione a Foligno nel 1230 del monastero femminile di S. Elisabetta secondo la regola agostiniana da parte di una donna tedesca fa pensare a un’iniziativa originariamente tedesca, trasferita poi in Italia. Il primo monastero di Servite, di cui si abbia notizia, nacque a Todi nel 1285 con un gruppo di prostitute convertite da s. Filippo Benizi: le loro fondazioni erano legate al ramo maschile attraverso o il priore generale o il priore provinciale dell’Ordine. Infine, alla metà del XV secolo nacquero anche monasteri di Carmelitane.
Gli ordini monastici femminili conobbero una serie di problemi comuni. Di fatto non ottennero il riconoscimento della loro aspirazione alla povertà evangelica, che pure era fortissima in alcune delle loro ispiratrici: si riteneva, infatti, che una condizione di miseria esponesse le donne alle tentazioni ed ai pericoli della “carne”, cioè a relazioni sessuali libere o a pagamento. Nonostante le loro aspirazioni, Francescane e Domenicane si dovettero limitare a uno stile di vita più austero rispetto agli altri monasteri femminili e anche i loro monasteri furono fondati su una base patrimoniale (ma meno doviziosa rispetto a quella dei monasteri aristocratici), arricchita poi con le doti delle singole monache: un’involuzione favorita anche dal grande successo che le case femminili dei Mendicanti riscossero negli stessi ceti aristocratici. Le monache, poi, in quanto donne erano considerate inabili all’amministrazione dei sacramenti; di conseguenza dovevano ricorrere al servizio sacramentale fornito per l’eucarestia e la confessione da religiosi maschi: questa presenza maschile esponeva le monache a rischi e maldicenze, mentre gli stessi religiosi non di rado provavano fastidio e imbarazzo nell’assolvere a questo compito, soprattutto nel caso dei confessori. Inoltre, con la Decretale Periculoso ac detestabili del 1298 confermata nel 1309 dalla Apostolicae Sedis di Clemente V, papa Bonifacio VIII impose anche a questi monasteri l’obbligo della “clausura”, cioè della segregazione rispetto al mondo esterno; tuttavia, la ricezione della decretale, che pure entrò a far parte del Corpus Iuris Canonici, non fu né generale né costante. Sullo scorcio del Medio Evo e gli inizi dell’età moderna, molti monasteri femminili o cessarono di osservare l’obbligo della clausura, o addirittura non lo avevano mai rispettato sin dalle origini. L’apertura dei monasteri e delle case femminili verso l’esterno poteva avere in qualche caso inferenze sentimentali (come testimonia la novellistica), ma più spesso costituiva una scelta obbligata, determinata da concrete esigenze di sopravvivenza: per i monasteri era necessario mantenere rapporti con chi commissionava alle monache lavori di filatura, tessitura, cucito, etc., e in alcuni mesi dell’anno i monasteri più poveri dovevano mandare fuori dal loro chiostro alcune sorelle, per raccogliere le elemosine indispensabili a sfamare la comunità. Soprattutto, l’apertura verso l’esterno manteneva in costante rapporto le singole monache con il contesto sociale, in primo luogo con le proprie famiglie d’origine, rispondendo a esigenze connesse alla gestione economica dei patrimoni monastici e delle doti monacali. Da tempo molte monache non vivevano più “a vita comune”, con refettori e dormitori collettivi, bensì vivevano in “celle”, organizzate su base familiare e clientelare e composte da uno o più locali: qui le monache dormivano, preparavano e consumavano i loro pasti, e svolgevano tutta una serie di lavori, i cui prodotti erano venduti a beneficio della micro-comunità titolare della cella. Spesso le monache di una medesima cella erano legate fra di loro da vincoli di parentela o da rapporti di clientela: così all’interno del monastero si ricostruiva il microcosmo familiare presente nel mondo esterno, compresa la più complessa rete dei comparatici e dei patronati. Come nel caso dei benefici ecclesiastici secolari di patronato privato, con questo sistema le famiglie dei ceti superiori impegnavano una quota del patrimonio domestico per sostentare le figlie non destinate al matrimonio (alla fine del Medio Evo, per esempio, a Firenze una dote monastica poteva ammontare dal 10 al 30 % di una dote coniugale: Trexler, Le célibat à la fin . Per una conferma si veda anche Molho, “Tamquam vere mortua” , 27).
Agli inizi dell’età moderna, tranne i casi di autentica vocazione volontaria e autonoma, la scelta dello stato monastico delle fanciulle spettava ai maschi delle loro rispettive famiglie e dipendeva da motivazioni esclusivamente connesse con quelle “strategie familiari”, che erano tese, oltre che a sistemare in qualche modo figlie illegittime o inadatte al matrimonio per evidenti difetti fisici, a conservare e accrescere il patrimonio domestico, senza intaccarlo con l’erogazione di ricche doti coniugali o con lasciti testamentari. Eppure, fino quasi alla metà del Cinquecento queste strategie familiari, così condizionate da motivazioni economiche, erano sopportabili per le interessate, poiché non comportavano la recisione dei loro legami affettivi con le famiglie d’origine. La comunità familiare si perpetuava nel chiostro e l’assenza di clausura consentiva alle donne e ai maschi restati nel “secolo” di visitare le parenti monacate, di servirsi delle celle monastiche per conservarvi i denari, i gioielli e i preziosi di casa nei momenti più turbolenti della vita cittadina, di usare la rinomata cucina monastica per organizzare i banchetti delle grandi feste domestiche, come i matrimoni e i battesimi. Né erano troncati i rapporti con il contesto sociale: una circolarità di rapporti, che, se in misura rilevante interessava gli aspetti della vita monastica nella quotidianità delle sue esigenze materiali, coinvolgeva anche la sfera dei bisogni culturali e delle istanze religiose. Tuttavia, in questo quadro monastico femminile, non segregato dal mondo, col tempo si erano consolidate alcune trasformazioni, che avevano suscitato forti preoccupazioni nei ceti dirigenti locali: a causa dell’assenteismo dei vescovi era cresciuta la subordinazione spirituale e gestionale dei monasteri nei confronti delle rispettive case maschili e la formazione di più ampi stati territoriali era stata accompagnata dall’invadenza dei nuovi governi (sovrani e città “dominanti”) anche nei chiostri femminili delle città dominate, sfruttandone le risorse per mantenere le fanciulle delle dominanti. La consapevolezza del disordine economico provocato da questo sfruttamento indusse alcuni governi ad adottare provvedimenti che garantissero una corretta amministrazione economica dei patrimoni monastici. Nel 1521 a Venezia fu istituita la magistratura dei «Provveditori sopra i monasteri»; nel 1524-25 la città di Parma nominò alcuni deputati sulla clausura e commissioni particolari per ogni singolo monastero femminile; nel 1545 il nuovo duca di Firenze Cosimo I de’ Medici Cosimo affidò la gestione economica di ciascun monastero a quattro Operai, eletti dal Duca stesso all’interno di liste approntate dalle magistrature cittadine e composte da parenti stretti delle monache, e istituì una Commissione centrale di tre “Deputati sopra i Monasteri”; sei anni dopo anche la Repubblica di Genova dette forma stabile ad un ufficio governativo di controllo sui monasteri femminili, operativo già da circa un secolo e composto da laici e chierici.
In alcuni di questi provvedimenti politici cominciò anche a prefigurarsi una normalizzazione della disciplina monastica sulla base di un’interpretazione misogina e carceraria del concetto di clausura. Nel frattempo, il Concilio di Trento dedicò solo un fuggevole accenno alla disciplina monastica femminile (Sess. XXV, Decretum de regularibus et monialibus, c. V), puntando soprattutto sul rafforzamento del controllo da parte del vescovo locale a scapito dei superiori regolari, ma la Santa Sede promosse una forte offensiva per introdurre un nuovo stile di vita nei monasteri, minacciando di non riconoscere il carattere religioso alle comunità che non avessero obbedito a questi precetti: il mandato temporaneo dell’ufficio di madre superiora, l’obbligo della vita comune e la realizzazione di un regime di stretta clausura in tutti i monasteri femminili, a qualunque ordine appartenessero e qualunque regola seguissero. Momenti principali di questa strategia disciplinatrice furono alcuni provvedimenti romani. L’8 maggio del 1565 la Congregazione del Concilio, sollecitata da alcuni vescovi, estese la clausura a tutti i monasteri di monache professe e di terziarie; poi, il 29 maggio 1566, con la costituzione Circa Pastoralis officii e due anni dopo con la Lubricum vitae genus, papa Pio V impose l’obbligo della rigida clausura a tutti i monasteri femminili, compresi quelli “aperti” (dalla loro fondazione o da tempo immemorabile); infine con la bolla Deo sacris virginibus del 30 dicembre 1572 Gregorio XIII ribadì gli ordini del suo predecessore, aggiungendovi una minaccia: i monasteri inadempienti sarebbero stati condannati all’estinzione, perché non avrebbero potuto accettare nuove consorelle. L’imposizione dall’alto del rigore disciplinare controriformistico sollevò le proteste generalizzate delle monache e tentativi di resistenza, che si protrassero fino agli inizi del Seicento: con la morte naturale delle monache ribelli, ferme nel rifiuto della nuova disciplina, alcune case monastiche conclusero la loro esistenza plurisecolare. Alla fine, grazie anche al coinvolgimento attivo dei ceti nobiliari e dei patriziati cittadini, ormai alieni dalla cultura umanistica e interessati alla nuova ideologia sottesa alla disciplina della Controriforma, sugli antichi monasteri femminili piombò una pesante cappa claustrale, che solo a partire dalla fine del secolo XVII fu scalfita dagli effetti della rivoluzione scientifica, che riuscì a “medicalizzare”, rendendoli leciti, tutta una serie di comportamenti e consumi (cioccolato, tabacco, soggiorni termali etc.) e poi fu travolta dalla secolarizzazione sette-ottocentesca della società. Le “monacazioni forzate”, intanto, continuarono per tutto l’arco dell’età moderna e, salvo qualche scandalo (come quello della famosa monaca di Monza), i monasteri femminili nascosero quei drammi individuali che provenivano dalle scelte connesse alle strategie familiari tese a consolidare i patrimoni domestici, privilegiando la discendenza maschile nella successione ereditaria.
Come era già avvenuto fra Quattro e Cinquecento, quando il fenomeno dell’“Osservanza” regolare era penetrato anche nei chiostri femminili, non mancarono monache che accolsero con entusiasmo l’inasprimento della vita monastica e ne fecero persino il fondamento di nuovi istituti, come, per l’Italia, nel caso delle Cappuccine, la cui nascita è attribuita alla fondazione del monastero napoletano “delle Trentatré” da parte della nobildonna Maria Lorenza Longo: queste monache adottarono la prima regola di s. Chiara (stretta povertà, penitenza, umiltà) e la più stretta clausura monastica, optando per una vita di preghiera e di privazioni. Fortuna arrise in Italia pure alla riforma rigorista delle Carmelitane, iniziata in Spagna da s. Teresa d’Avila, e alle Visitandine di s. Francesco di Sales, dopo che per volere della gerarchia la loro congregazione, nata con fini assistenziali, fu trasformata in un ordine claustrale dedito alla vita contemplativa. Ancora nel Seicento e nel Settecento nacquero in Italia nuovi istituti religiosi femminili di clausura: a Genova nel 1604 Maria Vittoria Fornari Strada fondò l’Ordine della Santissima Annunziata; ad Avellino nel 1654 sorsero le Oblate Sacramentine, che osservavano la stretta clausura, benché si dedicassero all’educazione delle giovani in un conservatorio interno; e nel secolo successivo ad opera di Maria Antonia Felice Solimani nacquero le Romite di san Giovanni Battista, approvate da Benedetto XIV nel 1744. Anche le monache Redentoriste, fondate nel 1731 da Maria Celeste Crostarosa con l’appoggio di Alfonso Maria Liguori, e quelle Passioniste, fondate da s. Paolo della Croce nel 1771, osservavano una stretta clausura e si dedicavano a una vita di preghiera e di penitenza. E negli anni dell’Impero napoleonico la maremmana Caterina Sordini fondò a Roma l’ordine contemplativo delle Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento.
Negli ultimi decenni del Settecento, alcuni sovrani assoluti (come Pietro Leopoldo e Giuseppe II d’Asburgo) attuarono riforme disciplinari d’impianto rigorista per attribuire un’utilità sociale ai monasteri femminili, che ormai versavano in una fase di lenta decadenza a causa di ben diverse “strategie familiari”: strategie inedite, che si affermavano anche nell’Occidente europeo cattolico col sostegno di una letteratura e di una saggistica improntate a modelli di vita simili a quelli europei nord-occidentali. Contro l’ideale della vita contemplativa riemergeva forte il richiamo alla vita attiva, anche nell’ambito della vita religiosa: un richiamo che peraltro non era stato soffocato neanche nell’età della Controriforma e degli Stati confessionali (cf. voce «Congregazioni religiose femminili»). Così, nel 1785 il granduca di Toscana Pietro Leopoldo impose ai monasteri di clausura di impegnarsi nel campo dell’educazione delle ragazze, obbligando i monasteri femminili e le singole monache a scegliere fra un rinnovato regime di vita rigorosamente comunitaria (con l’abolizione delle celle individuali) e la riconversione in conservatori finalizzati all’istruzione. Quando, dopo le più massicce soppressioni di monasteri e confische dei relativi patrimoni dell’età napoleonica (culminate nei provvedimenti adottati in tutta la Penisola fra il 1806 e il 1810), arrivò la Restaurazione quel modello controriformista di monastero femminile di rigorosa clausura e di vita contemplativa poté recuperare parzialmente le sue posizioni. Il ritorno ai valori e agli stili di vita della tradizione cattolica fu ostacolato non solo dai mutamenti sociali, resi irreversibili di fatto dall’alienazione massiccia dei patrimoni ecclesiastici (acquistati pure da famiglie di sicura fedeltà alla Chiesa e al pontefice), ma anche dalla ripresa dei principi del giurisdizionalismo ecclesiastico, soprattutto in Toscana e nel Settentrione. Per attenuare gli ostacoli frapposti alla vita contemplativa, gli ordini monastici femminili adottarono un atteggiamento di compromesso, facendo coesistere l’osservanza della clausura con l’impegno educativo verso le ragazze. Questa strategia dell’impegno in attività di educazione, d’istruzione e di assistenza si rivelerà utile anche negli anni immediatamente successivi all’Unità per attenuare gli effetti dell’estensione a tutto il Regno d’Italia (legge del 7 luglio 1866) delle leggi piemontesi di soppressione degli enti ecclesiastici non dediti ad attività di utilità sociale (29 maggio 1855). D’altra parte, sia per le vicende generali del nostro paese e delle sue diverse regioni, sia per le situazioni particolari delle singole case monastiche, in Italia è mancata una radicale e generalizzata soppressione di tutti i monasteri femminili osservanti la rigorosa disciplina claustrale: la stessa applicazione delle leggi di soppressione fu più o meno rigorosa a secondo dei luoghi e dei tempi, perché, mentre in alcuni casi le comunità furono del tutto soppresse e le suore disperse, in altri le monache rimasero nei loro istituti anche se a titolo precario e riuscirono persino ad aggirare il divieto di accettare nuove affiliate.
Fonti e Bibl. essenziale
A parte le numerosissime voci dedicate dal Dizionario degli Istituti di Perfezione sia ai singoli ordini monastici femminili, sia a problematiche di carattere generale, si vedano: «De Monialibus» (secoli XVI-XVII-XVIII), in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», XXXIII, 1997, 643-715; M. Campanelli, Monasteri di provincia (Capua secoli XVI-XIX), Milano, Franco Angeli, 2012; M. D’Amelia – L. Sebastiani edd., I monasteri femminili in età moderna: Napoli, Roma, Milano, Roma, Carocci, 2009 («Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2009, fasc. 2); K. Di Rocco, Gli orientamenti storiografici intorno al monachesimo femminile, in «Itinerari di ricerca storica», n. 20-21, 2006-2007, 363-394; Donna, disciplina e creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa, a cura di G. Zarri, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1996; L. Scaraffia – G. Zarri, Donne e fede. Santità e vita religiosa in Italia, Roma-Bari, Laterza (“Storia delle donne in Italia”), 1994; Donne sante sante donne. Esperienza religiosa e storia di genere, Milano, Rosenberg & Sellier, 1996; A. Lirosi ed., Le cronache di Santa Cecilia. Un monastero femminile a Roma in età moderna, Roma, Viella, 2009; M. Modica ed., Esperienza religiosa e scritture femminili tra Medio Evo ed età moderna, Acireale, Bonanno Ed., 1992; F. Medioli, L’«Inferno monacale» di Arcangela Tarabotti, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990; G. Zarri ed., Il monachesimo femminile in Italia dall’alto medioevo al secolo XVII. A confronto con l’oggi, Atti del VI Convegno del «Centro di Studi Farfensi», Santa Vittoria in Matenano 21-24 Settembre 1995, Negarine di San Pietro in Cariano (Verona), Il Segno dei Gabrielli Editori, 1997; G. Pomata e G. Zarri edd., I monasteri femminili come centri di cultura fra Rinascimento e Barocco, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005; E. Novi Chavarria, Monache e gentildonne. Un labile confine. Poteri politici e identità religiose nei monasteri napoletani. Secoli XVI-XVII, Milano, Franco Angeli, 2001; Ead., Sacro, pubblico e privato. Donne nei secoli XV-XVIII, Napoli, Guida, 2009; C. Russo, I monasteri femminili di clausura a Napoli nel secolo XVI, Napoli, Università di Napoli – Istituto di storia medioevale e moderna, 1970; M.I. Sutto, I monasteri benedettini femminili in Italia dopo l’età delle soppressioni, in Il monachesimo in Italia tra vaticano I e Vaticano II, Atti del III Convegno di studi storici sull’Italia benedettina, Badia di Cava dei Tirreni (Salerno), 3-5 settembre 1992, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte, 1995, 291-306; S. Seidel Menchi – A. Jacobson Schutte – Th. Kuehn, Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed Età Moderna, Bologna, Il Mulino, 1999; M. Sensi, «Mulieres in Ecclesia». Storie di monache e bizzoche, Spoleto, Centro Italiano sull’Alto Medioevo, 2010; G. Zarri, Monasteri femminili e città (secoli XV-XVIII), in G. Chittolini – G. Miccoli edd., Storia d’Italia. Annali 9. La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, Torino, Einaudi, 1986, 357-429; Ead, Recinti: donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2000; G. Zarri – G. Festa edd., Il velo, la penna e la parola. Le domenicane: storia, istituzioni e scritture, Firenze, Nerbini, 2009.