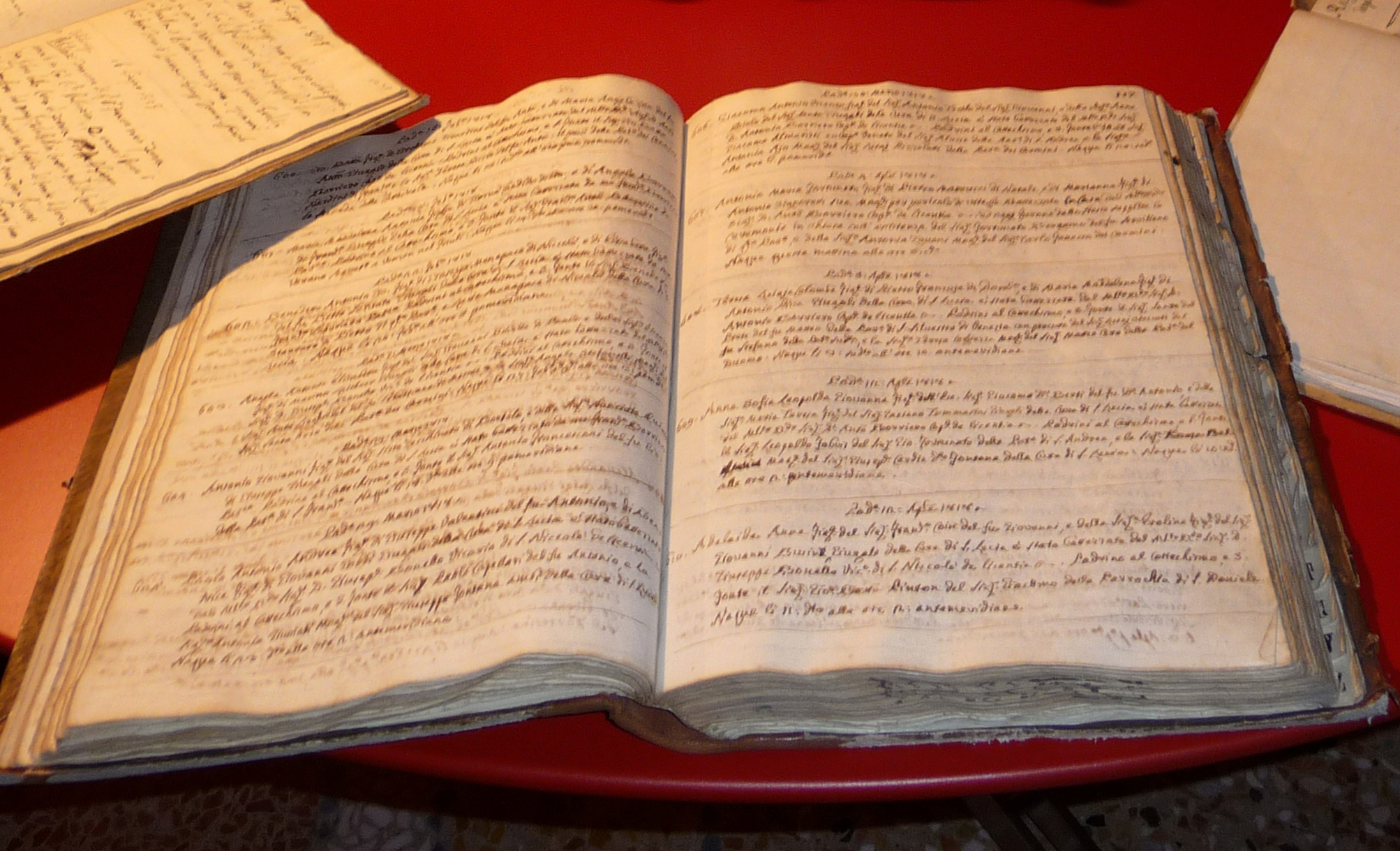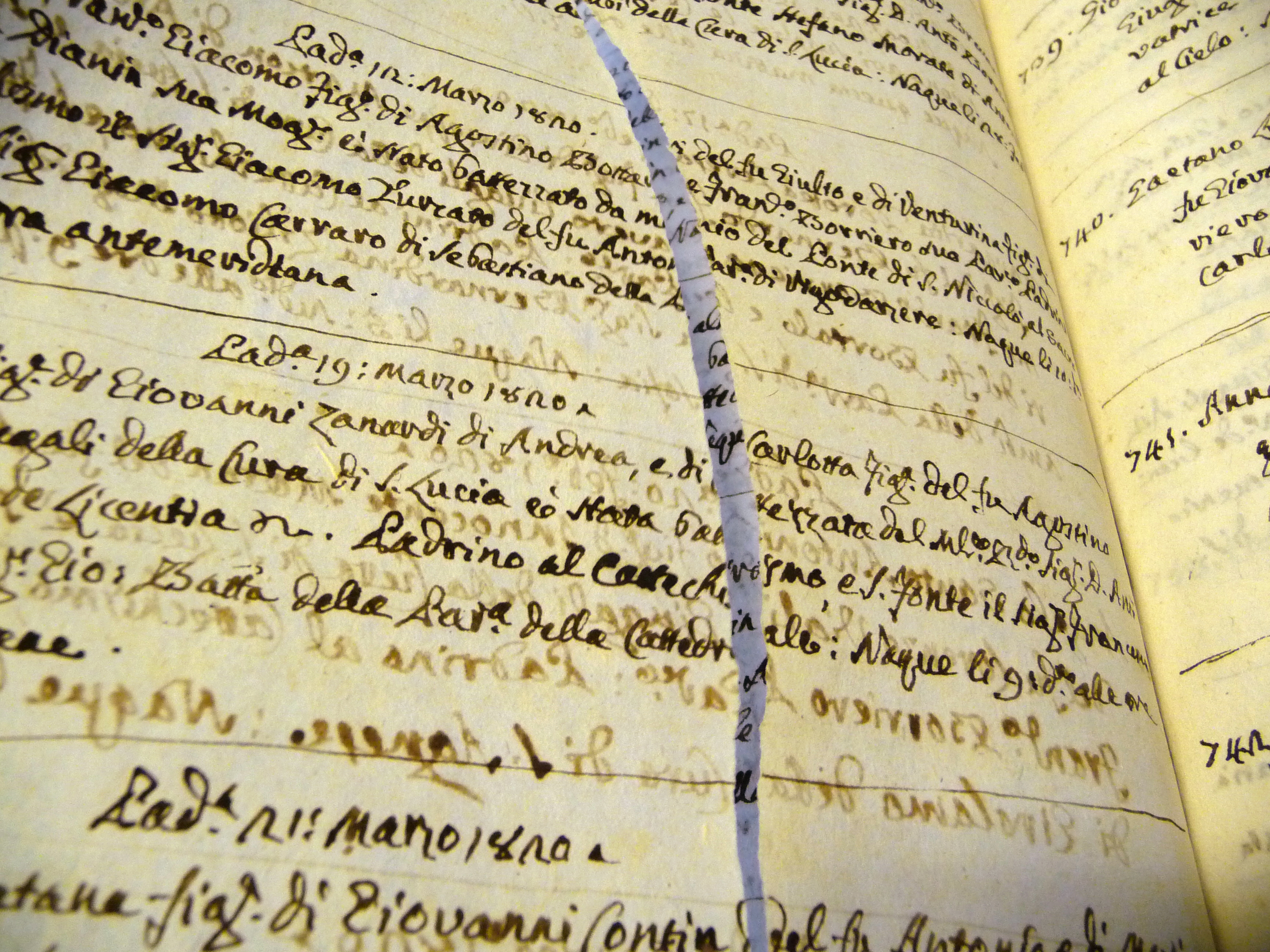Autore: Flavio Rurale
Esperienze di vita solitaria e ascetica nella forma estrema dell’anacoretismo (il cui più noto esponente fu sant’Antonio) o in quella del cenobitismo (caratterizzata da momenti di perfetta solitudine alternati ad altri di vita comune: pasti, preghiera, più tardi anche il lavoro) segnarono fin dalle origini la società cristiana. Sorsero a partire dal IV secolo come risposta ai bisogni di singoli individui o di minoranze di fedeli desiderosi di vivere con radicalità il messaggio evangelico, in luoghi appartati «lontano dalle cure del mondo, a guisa di angeli» (S. Pricoco, Da Costantino, 385-386). Dall’oriente (Egitto, Palestina, Siria), loro terra d’origine, tali esperienze si diffusero in Europa e in Italia, dove maturarono particolarmente nel VI secolo «episodi di […] forte e creativo rinnovamento» con l’opera e le fondazioni sublacensi di s. Benedetto da Norcia (ibid., 424).
La vita monastica introdusse un modello di «appartenenza volontaria […] a regole e voti esclusivi di purità» che comportavano durissime rinunzie – «il rifiuto del sesso, del sangue e del denaro» – destinati a improntare l’organizzazione dei futuri ordini regolari (E. Brambilla, Alle origini, 63-65). Tali “religioni private” o sette, come furono chiamate, ebbero molto spesso carattere di spontaneità (come peraltro tante nuove fondazioni dei secoli successivi), e solo in un secondo momento, seguendo percorsi non sempre lineari, raggiunsero un assetto stabile, venendo riconosciute e istituzionalizzate dalle autorità ecclesiastiche o laiche (papa, vescovi, re, principi). Lo stile di vita dei monaci si presentava dunque come alternativo a quello del clero secolare urbano: «il loro modello non era la chiesa stabile dei vescovi e delle diocesi, […] ma quella degli Atti degli apostoli, l’attività carismatica e profetica di missionari mobili» (ibid., 67-78). Condizione, va detto, che permise loro in congiunture drammatiche di infrangere l’isolamento e di intervenire come veri e propri “sgherri di Dio”, anche saccheggiando, uccidendo e fomentando rivolte, contro le sopravvivenze della religione politeista (P. Chuvin, Cronaca degli ultimi pagani, Paideia Editrice, Brescia 2012, 83). Soggetti a norme sempre più rigide, nello spazio immune dei loro monasteri i monaci sperimentarono un regime di ammende e punizioni che si tradusse in un vero e proprio sistema di giustizia penale, che contribuì a definire pratiche di perdono pubbliche (riti di confessione e di grazia, indulgenze) destinate anche ai fedeli esterni e a diventare più tardi concorrenziali con la giustizia dei tribunali laici ed ecclesiastici (vescovili e inquisitoriali).
Occorre sottolineare, «insieme con la genuina spinta religiosa», il forte significato sociale e politico che l’opera del clero regolare (con gli abati) e di quello secolare (coi vescovi) ebbe nel favorire la riorganizzazione dell’Europa cristiana dopo la caduta dell’impero e le invasione barbariche (G. Sergi, Vescovi, monasteri, 79). L’incontro tra il processo di ricostruzione degli organismi di governo territoriale e le forme organizzative che la Chiesa andò approntando a livello locale e a Roma favorì la progressiva sovrapposizione di funzioni temporali e religiose, tra “regno e sacerdozio”. Ne uscì definito un ceto ecclesiastico con forti connotati politico-militari: nelle comunità abbaziali, non semplici comunità di preghiera ma microcosmi culturali, economici, giurisdizionali, nonché strutture di difesa, «si realizzò una simbiosi di funzioni […] destinata a durare secoli, […] di stretta collaborazione politico-ecclesiastica», con esponenti dell’elite (appartenenti alle casate fondatrici dei monasteri stessi) ivi educati e pronti a occupare poi incarichi di rilievo nelle strutture di governo urbano e rurale (ibid., 75-77; S. Pricoco, Da Costantino, 411, 413).
La storia degli ordini religiosi, a partire dalle originarie esperienze di tipo contemplativo, seguì nel corso del primo e secondo millennio traiettorie dagli esiti molto differenti. Si attenuò il divario tra vita nel secolo ed eremitismo, e riacquistarono centralità sia la vocazione sacerdotale, di per sé inizialmente estranea alla spiritualità monacale, sia l’interesse per la cultura (attraverso l’opera di trasmissione e conservazione della tradizione manoscritta e una fiorente creazione artistica). Si trattò di sviluppi i cui esiti furono del tutto evidenti nelle trasformazioni, per certi aspetti radicali, che attraversarono il variegato mondo dei religiosi: dalle comunità monacali del primo millennio si passò, attraverso l’esperienza dei canonici regolari, a quelle mendicanti del XIII secolo e infine ai chierici regolari (teatini, barnabiti, gesuiti, ecc.) cinquecenteschi.
Molto si è scritto del percorso quasi ciclico di fondazione, crisi, morte e/o rinnovamento proprio di tante comunità periodicamente soggette, dopo l’iniziale fase di affermazione, a processi di decadenza e conseguenti interventi di riforma (quando non addirittura a divisioni o a vere e proprie soppressioni, C. Fantappiè, Les ordres religieux entre histoire, droit et sociologie, Revue historique de droit français et étranger, LXXIII, 1995, 501-520). Fu in effetti proprio delle comunità regolari procedere per «rifondazioni, per separazione volontaria» (E. Brambilla, Alle origini, 64), per filiazione, quasi per partenogenesi, e certamente ciò avvenne in molti casi in conseguenza del bisogno di recuperare la coerenza perduta, la regola originaria, ovvero di sperimentare più originali forme di spiritualità e ascesi.
Ma monasteri e conventi, come detto, non furono mai solo uno spazio religioso (aperti com’erano a interessi di vario genere), né furono sempre capaci i loro superiori di impedire l’ingresso a soggetti inabili alla disciplina o, privi di una sincera vocazione, semplicemente interessati a riciclarsi (ex militari) e a garantirsi una carriera curiale (R.L. Guidi, Il dibattito sull’uomo nel Quattrocento, TielleMedia, Roma 1998, cap. IV). La profonda compenetrazione tra le due dimensioni (temporale e religiosa) fu di nuovo evidente nelle urgenze spirituali e devozionali (all’origine dell’esperienza mendicante) nate in risposta alle trasformazioni economiche e politiche che in Italia segnarono il passaggio prima alle città-stato poi ai principati regionali.
Dunque alle comunità (di cluniacensi, vallombrosiani, certosini, cistercensi, olivetani, camaldolesi, ecc.) che adottarono nelle grandi abbazie italiane ed europee le regole ispirate ai testi di s. Basilio, Pacomio, sant’Agostino, s. Benedetto si affiancarono nel ‘200 francescani e domenicani. Spinti da bisogni personali e collettivi, i frati mendicanti aderirono a un modello di vita comunitaria improntato a nuove regole (di s. Francesco, di s. Domenico), espressione di una diversa concezione dell’impegno religioso e della vita di perfezione: non più lontani dal resto dei fedeli, in una solitudine contemplativa, ma inseriti nella società urbana, secondo uno stile austero e di assoluta povertà. Come predicatori, missionari, confessori, veri e propri mediatori e pacieri nel dirimere liti e querelle di ambito cittadino su materie economico-finanziarie e politiche, i mendicanti, arricchitisi di nuove famiglie (agostiniani, serviti, carmelitani), assunsero funzioni di grande rilevanza sociale. Tra gli impegni di maggiore responsabilità vi fu quello di commissari nei tribunali inquisitoriali sorti per combattere l’eresia, incarico ricoperto anche dopo la riorganizzazione cinquecentesca del Sant’Uffizio. Non meno rilevante fu il loro contributo teorico e pratico nel dibattito emerso sulle nuove pratiche economico finanziarie (prestito a interesse) della società basso-medioevale.
Concomitante con l’affermazione dei mendicanti, la crisi trecentesca delle abbazie benedettine trovò sbocco da un lato nell’istituzione della commenda, vano tentativo di rinnovare materialmente e nello stile di vita i comportamenti dei religiosi, che poco o nulla modificò la situazione di abuso e degrado, finendo unicamente per salvaguardare gli interessi e le rendite dei cardinali romani (abati commendatari); dall’altro nella formazione di reti di raccordo tra comunità originariamente autonome e indipendenti per costituzioni e regole ora invece riunite nell’obbedienza a un’abbazia madre riformata (come nel caso padovano di inizio Quattrocento della congregazione benedettina di santa Giustina, divenuta un secolo più tardi congregazione cassinese).
Anche gli ordini mendicanti conobbero ben presto, sulla scia delle lunghe e violente polemiche sull’obbligo di povertà assoluta dei singoli frati e delle loro comunità, l’esigenza di un ripensamento interno che riportasse a una più rigorosa osservanza della regola stabilita dai fondatori. Nacquero, a fianco dei cosiddetti conventuali, le comunità osservanti, inclini a una maggiore coerenza con la spiritualità, gli impegni e lo stile di vita originari, eppure pronti allo scontro, anche armato, magari supportati da principi e patroni, pur di prevalere sulle comunità contrarie alla riforma e impossessarsi dei loro beni. Nel clima quattrocentesco, impregnato di ostilità verso la presenza degli ebrei nella società cristiana, l’impegno sociale dei frati (francescani osservanti) sfociò nella predicazione antigiudaica, che portò all’istituzione di strumenti finanziari, i Monti di Pietà, alternativi ai banchi ebraici e di sostegno al piccolo credito (monetario e in beni naturali) dei ceti medio bassi.
Né fu quello dell’osservanza l’ultimo esempio del procedere dei mendicanti (e dei regolari) tra crisi e rinascite: nel ‘500 i cappuccini rappresentarono un’ulteriore tappa nella progressiva frammentazione dell’ordine dei minori, non rimanendo peraltro immuni, come del resto avvenne per altre congregazioni vecchie e nuove, da divisioni e conflitti dottrinali, che portarono a fughe, espulsioni e processi, e in alcuni casi all’adesione alla riforma luterana (il generale Bernardino Ochino decise di lasciar l’Italia per Ginevra). Tale sviluppo accompagnò una fase di sperimentazione interna al mondo regolare molto complessa, in cui agli aspetti propriamente religiosi (per esempio la ricerca di nuove forme di spiritualità da parte dei laici e tra questi la presenza di figure femminili – si pensi a Paola Antonia Negri – poi direttamente coinvolte sia nella riforma dei vecchi istituti sia nell’istituzione dei nuovi) si sovrapposero gli interessi economici e politici delle grandi casate principesche e di facoltosi patroni.
Nell’ambito della polemica verso il clero regolare che segnò la cultura umanistica (erasmiana) e fu fatta propria non solo dalla riforma luterana ma anche da alcuni ambienti curiali romani (Consilium de emendanda ecclesia, 1537) divampando poi nel concilio di Trento (dove gli ordini religiosi vennero additati come la causa delle deviazioni eretiche), ampio interesse suscitò la discussione sulla necessità di rivedere ruolo e privilegi di monaci e frati, a favore della centralità del clero vescovile e parrocchiale: ma alla fine non produsse i risultati da molti sperati.
Gli ordini mendicanti, al pari delle congregazioni da poco istituite dei chierici regolari, continuarono infatti a conservare per tutta l’età moderna una funzione insostituibile nella Chiesa e nella società cristiana, godendo di ampie autonomie a livello locale (non erano soggetti alla giurisdizione vescovile) e talora anche nei confronti di Roma. Importante fu l’impegno profuso in ambito pastorale (non senza peraltro suscitare preoccupazioni, proteste e interventi censori da parte del clero diocesano): venne infatti spesso loro affidata la stessa cura d’anime, oltre alla semplice amministrazione del sacramento della confessione, alla direzione spirituale e alla predicazione dentro e fuori le loro chiese durante i cicli quaresimali e dell’avvento.
Particolarmente efficace fu il loro intervento anche nell’organizzare la popolazione laica, tanto in città come nelle campagne, attraverso le confraternite dedicate al culto del santissimo sacramento, della vergine, dei santi protettori, spazi non solo di devozione religiosa e di commissione artistica, ma anche di mutuo soccorso e, nelle aree economicamente meno avanzate, occasione per mettere a disposizione del ceto contadino piccole quote di credito. Insostituibile fu il ruolo degli Ordini sia contro l’ignoranza delle plebi e la sopravvivenza di forme cultuali paganeggianti, sia nella ricattolicizzazione delle popolazioni convertite alle fedi riformate, sia nell’attività missionaria nel continente americano, in Africa e in Asia. La loro opera rimase centrale anche in ambito culturale, dove soddisfecero il bisogno di formazione dell’antica aristocrazia e della nuova nobiltà, dei ceti medio-bassi e del clero (con l’insegnamento impartito nei collegi dagli ordini cosiddetti insegnanti: gesuiti, barnabiti, somaschi e scolopi, e con la gestione loro affidata dei seminari vescovili), continuando nel contempo a fare parte, coi loro membri più in vista, della repubblica delle lettere e rimanendo dunque protagonisti del dibattito filosofico e scientifico sei-settecentesco.
Irrisolti, sul lungo periodo, rimasero alcuni aspetti della loro organizzazione: iterati abusi (incapacità di controllo degli ingressi, mobilità indisciplinata, inosservanza delle regole, eccessiva mondanità) e nuovi problemi, come quelli connessi a quell’elite religiosa (confessori, precettori, teologi di corte) sottratta al controllo romano, fortemente dipendente da principi e sovrani, capace di operare in larga autonomia sul palcoscenico della politica europea nella fase di costruzione della moderna statualità. La curia papale, consapevole di dover arginare l’autonomia dei regolari già sottratti all’autorità vescovile, cercò di esercitare uno stretto controllo sulle singole comunità e i loro superiori generali: costoro vennero affiancati nel governo dai cardinali protettori (e dalle congregazioni cardinalizie deputate a risolvere i problemi legati alla vita regolare), furono chiamati a risiedere a Roma con la loro curia generalizia (questione che suscitò non poche polemiche in ordine geograficamente più connotati, come i “milanesi” barnabiti), e periodicamente videro minacciate le loro comunità da interventi di modifica di regole e costituzioni (per imporre ad esempio il generalato temporaneo o una convocazione più frequente dei capitoli generali). Furono in parte questi i contenuti del decreto papale di cui si vociferò a Parigi nel 1642, con il quale Urbano VIII comandava «che per l’avenire tutti li generali di qualunque religione siano per un triennio solo et che la perpetuità sia abrogata». Il papa aveva toccato con mano «che li generali di S. Domenico e dei gesuiti, per la longa durata, vogliono essere padroni assoluti delle religioni, et che pretendono di non riconoscere in una certa misura né il papa né i cardinali» (R. P. Mortier, Histoire des maîtres généraux de l’ordre de frères précheurs, VI, 1589-1650, Alfons Picard et Fils, Paris 1913, 464).
Se durante l’interdetto su Venezia del 1606 l’espulsione dei gesuiti dalla Serenissima per circa mezzo secolo costituì un esempio di dedizione al papato, in molti altri casi i religiosi, come confessori e teologi dei sovrani cattolici e dei loro ministri, si dimostrarono ben disponibili a difendere la giurisdizione secolare mettendo a rischio autorità e interessi della curia papale: occorreva, questa ormai era la convinzione di molti a metà Seicento, assicurare la loro fedeltà alla causa romana con gli stessi strumenti utilizzati dai principi, attraverso cioè una vera e propria opera di reclutamento che riconoscesse ai singoli padri coinvolti (e ai loro parenti) stipendi, rendite, cattedre universitarie, uffici curiali (anche le mense vescovili se necessario).
Pontefici e curie generalizie intervennero a più riprese nel tentativo di ristabilire obbedienza, disciplina e più adeguati processi di selezione e formazione, ma con risultati poco soddisfacenti. L’inchiesta sullo stato dei regolari di metà ‘600, peraltro motivata da preoccupazioni di carattere materiale (patrimoniali e giuridiche), indicò nella soppressione dei cosiddetti conventini la via da seguire per uscire dalla condizione di decadenza: eppure dovette scontrarsi (e di fatto ne uscì ridimensionata) con le esigenze di vescovi e principi contrari a privarsi dell’opera pastorale delle pur piccole e inadeguate (al di sotto delle 12 unità) residenze regolari presenti sul loro territorio.
Il clima culturale di fine Seicento, attraversato da nuove sensibilità religiose, dall’affermazione di nuovi ordini dediti all’opera missionaria (come i lazzaristi, la congregazione delle missioni apostoliche, più tardi i redentoristi di Alfonso Maria de Liguori) e pronto ad accogliere le sollecitazioni anticuriali del radicalismo illuminista e del giurisdizionalismo politico, aprì infine la strada alla tempesta che colpì gli Ordini religiosi nel Settecento, nel passaggio dalle riforme asburgiche, alla rivoluzione francese e infine alla conquista napoleonica dell’Italia.
La penisola, ancora divisa nei suo Antichi Stati, accolse allora, erano gli anni Cinquanta del Settecento, gli inviti provenienti da Portogallo, Spagna, Francia e Impero: un moto anticuriale (e anti-gesuitico) convogliò “le terre italiane […] nella polemica sui beni della Chiesa, […] sulla doverosa povertà degli ecclesiastici, […] sull’autorità del clero, […] sulle scuole, le università” (Venturi, Settecento riformatore, 65). Non mancarono intellettuali di spicco, come Carlantonio Pilati (Di una riforma d’Italia, 1767) e Cosimo Amidei (La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti, 1768), a indicare la necessità di porre finalmente confini precisi nei rapporti tra stato e chiesa, mettendo fine al potere temporale del papa e limitando la presenza di quel clero regolare “mal diretto e regolato”, causa dei malanni “onde l’Italia viene da gran tempo travagliata” (Venturi, Settecento riformatore, 261). La svolta non fu radicale, il “processo di declericalizzazione” non produsse affatto in Italia risultati sotto questo profilo “irreversibili” (Venturi, Settecento riformatore, xi, 342). Ma gli esiti immediati furono drammatici: espulsione della Compagnia di Gesù dagli stati borbonici (seguita nel 1773 dalla sua abolizione addirittura per decisione del pontefice Clemente XIV, il frate Giovanni Vincenzo Ganganelli), soppressione dei piccoli conventi e degli ordini contemplativi, incameramento dei beni, controllo degli stati sulle modalità di reclutamento, infine soppressione generale di tutti gli ordini regolari per ordine di Napoleone nel 1810 (R. Rusconi, Gli ordini religiosi, 270-272).
La ricostituzione delle comunità colpite dalla bufera settecentesca e rivoluzionaria dovette fare inevitabilmente i conti a inizio ’800 con le esigenze delle autorità secolari, disposte a riconoscere gli istituti caratterizzati da attività utili alla società (istruzione, assistenza, interventi di carattere sociale), ma nello stesso tempo consapevoli di non dover rinunciare alle conquiste settecentesche. Ovviamente le strategie adottate variarono a seconda delle realtà geografiche e dei governi – la storiografia ha individuato percorsi e modelli diversi, da quello “separatista” piemontese-italiano a quello giurisdizionalista lombardo-veneto, a quello “sanfedista” meridionale (il più lontano dalle conquiste settecentesche) – ma è possibile delineare tratti comuni nelle decisioni prese all’indomani della restaurazione, significativamente contrassegnata dalla rifondazione papale dell’ordine ignaziano (1814, caso unico nella storia della Chiesa), sopravvissuto fino allora, proprio contro gli ordini romani, nella Russia di Caterina (Pavone, Una strana alleanza) e destinato a essere protagonista nell’Otto-Novecento della battaglia contro i processi di laicizzazione e secolarizzazione della civiltà moderna. La scelta di Pio VII non mancò di suscitare anche nel clero reazioni contrastanti: a Milano, per esempio, l’arcivescovo Karl Gaetan Gaysruck ne impedì il rientro privilegiando i barnabiti (De Giorgi, Cattolici ed educazione, 41).
Il caso toscano, con il primo concordato (1815) firmato dalla santa sede dopo le traumatiche vicende napoleoniche (quando vennero chiusi 214 conventi maschili, venduti i loro beni e mandati in pensione i singoli religiosi), può essere preso a esempio delle questioni allora oggetto di negoziazione, perlomeno per quella parte d’Italia incline ad atteggiamenti più concilianti verso Roma, come saranno del resto, nonostante il radicalismo iniziale, le disposizioni piemontesi (De Giorgi, Cattolici ed educazione, 39, 55-60). In discussione nel Granducato furono anche i decreti settecenteschi di Pietro Leopoldo (del 1751 e 1769): il controllo giurisdizionale allora imposto alla chiesa, l’incameramento e l’alienazione dei suoi beni e la volontà di “livellare” le terre rimaste invendute pur assicurando entrate certe ai religiosi. Il prevalere delle correnti ecclesiologiche che avevano posto al centro della vita dei fedeli il clero secolare condizionò la discussione e le decisioni, indirizzate a una forte selezione degli ordini da ristabilire (vennero potenziati scolopi e barnabiti per il loro impiego nella pubblica istruzione), alla loro subordinazione ai vescovi (la dipendenza dai superiori generali rischiava di pregiudicare l’autorità principesca), alla diminuzione in ogni caso dei loro insediamenti, alla regolamentazione degli ingressi per limitarne il numero (essendo ancora appetita la vita monastica da uomini di condizione vile con il solo scopo di una “vita comoda”). Quanto ai loro beni, Ferdinando III e i suoi ministri, attenti a una più razionale organizzazione del settore agrario, auspicavano la concessione in enfiteusi delle terre non ancora alienate assicurando ai religiosi il solo dominio diretto e una rendita fissa e sicura: ma dovettero venire a patti con Pio VII rinunciando di fatto a questo obiettivo. Modello anche per gli accordi tra Roma e il regno delle Due Sicilie del 1818, quello toscano fu l’unico concordato riguardante gli ordini religiosi: “il loro ristabilimento avvenne nella maggioranza degli stati attraverso singoli provvedimenti dei sovrani e fu molto più lento e meno sistematico” (G. Paolini, Il concordato toscano del 1815 sugli ordini religiosi, 40).
Le difficoltà a ripristinare dal nulla le antiche strutture organizzative comportarono scelte talora affrettate e contraddittorie, facendo riemergere abusi e incoerenze ben prima della seconda tempesta, quella che a partire dagli anni Quaranta fino all’unità d’Italia portò alle cosiddette leggi eversive (con nuove soppressioni e abolizioni). L’elenco dei motivi della crisi, ricordati da Giuseppe Martina accanto a vicende esemplari per dedizione e impegno pastorale (“una persistente crisi degli istituti nel loro complesso” si affiancò a “una fioritura di iniziative costruttive”: sintesi efficace di un “contrasto abituale” nella storia della chiesa, Martina, La situazione degli istituti religiosi, 194, 196), riproduce in maniera emblematica molti dei nodi già emersi e rimasti insoluti nel corso del Sei-Settecento, su cui i governi avevano tentato di intervenire dopo il fallimento di iterati provvedimenti pontifici: mancanza di una severa selezione e di un’accurata formazione teologica dei candidati, ricercata indipendenza non solo nei confronti degli ordinari diocesani («non senza provocare i sospetti e le opposizioni di alcuni fra essi, come capitò a don Giovanni Bosco con due arcivescovi di Torino», G. Martina, La situazione degli istituti religiosi, p. 198), ma anche dalla curia papale (opponendosi, come nel caso del ramo napoletano della congregazione del SS. Redentore, al trasferimento a Roma della curia generalizia), persistenza di comunità ridotte a un numero esiguo di membri, discordie dovute al prevalere di fazioni su base familiare e clientelare, dissensi interni anche a causa di differenze regionali e contrapposizioni politiche (soprattutto dopo che i moti liberali del 1848 posero una di fronte all’altra la parte intransigente e quella filo-liberale, ora spalleggiate ora combattute dai poteri politici), abbandono degli istituti senza dispensa proprio in seguito al nuovo fervore risorgimentale. Fino a rendere necessario “il drastico provvedimento” della Congregazione dei vescovi e regolari del novembre 1849, che proibì “a tutti gli istituti esistenti in Sicilia di ammettere novizi alla professione” (Ibidem, 202-209).
Il processo di unificazione dell’Italia introdusse, a partire dal regno sabaudo, misure sempre più restrittive – i gesuiti, già espulsi nel 1848, vennero nuovamente soppressi nel 1855 – e provvedimenti intesi a privare le congregazioni religiose del riconoscimento giuridico necessario per il loro operare (G. Rocca, Istituti religiosi, 225-226) e a incamerarne i beni a favore dello stato. Ciò avvenne in assenza di un’uniformità legislativa – di difficile realizzazione anche nel passaggio al Regno d’Italia – e dunque in condizioni di forte discriminazione «fra ordini colpiti e tollerati» (G. Martina, La situazione degli istituti religiosi, 221). L’obiettivo, di nuovo, fu la riduzione delle comunità contemplative e di quelle ancora improntate a un regime economico basato sulla questua, ritenuta anacronistica e «contraria allo spirito del tempo» (G. Rocca, Istituti religiosi, 229), salvaguardando le corporazioni dedite alla predicazione, all’istruzione e all’assistenza e non coinvolte con i poteri assolutistici pre-unitari. Infine arrivò la legge del 1866, che «non faceva alcuna distinzione” tra congregazioni utili e inutili “e colpiva tutti gli istituti» indistintamente (G. Martina, La situazione degli istituti religiosi, 223). La sua applicazione, tuttavia, elastica e benevola, favorì negli ultimi decenni del secolo il superamento della crisi e “un generale sviluppo degli istituti religiosi in termini di vocazioni e di fondazioni” (De Giorgi, Cattolici ed educazione, 52).
Il confronto con gli apparati dello Stato e con i mutamenti socio-culturali dell’epoca caratterizzò, tra scontri e polemiche, arroccamenti e adattamenti, anche l’azione delle congregazioni fondate nel corso dell’Ottocento. Ben 23 furono i nuovi sodalizi maschili: molti rimasero a lungo non formalizzati canonicamente e furono riconosciuti dalla Chiesa entro lo status regolare solo agli inizi del Novecento (De Giorgi, Cattolici ed educazione, 10-11, 22). Di fronte a cambiamenti epocali e a urgenze sempre più pressanti, fiorirono nel XIX secolo istituzioni dedite soprattutto all’istruzione e all’assistenza (nel 1855 nacquero i salesiani) e caratterizzate da “un’acuta sensibilità pastorale e caritativa verso le nuove piaghe sociali prodotte dalla rivoluzione industriale”. Nel confronto con i problemi della modernizzazione, al cospetto di esiti non sempre felici e sovente contraddittori, fu il loro forse il lascito più significativo, capace sul lungo periodo di rendere disponibili forze e strumenti (ospedali, mense, ricoveri) per la quotidiana battaglia contro le nuove povertà. La conferma ulteriore della “obiettiva importanza” delle congregazioni religiose quale struttura organizzativa e culturale che ha attraversato “con influenza durevole le pieghe della società italiana” (Rosa, Introduzione, 8).
Fonti e Bibl. essenziale
G. Penco, Storia del monachesimo in Italia nell’epoca moderna, Edizioni Paoline, Roma 1968; G. Martina, La situazione degli istituti religiosi in Italia intorno al 1870, in Chiesa e religiosità in Italia dopo l’Unità (1861-1878), Atti del quarto Convegno di Storia della Chiesa, La Mendola 31 agosto – 5 settembre 1971, 4 voll., Vita e Pensiero, Milano 1973, I, Relazioni, 194-335; F. Venturi, Settecento riformatore. La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti, Einaudi, Torino, 1976; G. Sergi, Vescovi, monasteri, aristocrazia militare, in G. Chittolini – G. Miccoli (edd.), Storia d’Italia, Annali, 9, La Chiesa e il potere politico, Einaudi, Torino 1986, 73-98; L. Châtellier, L’Europa dei devoti, Garzanti, Milano 1988; M. Pacaut, Monaci e religiosi nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 1989; M. Rosa, Introduzione, in Idem, Clero e società nell’Italia contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 1992, 5-41; G. Fragnito, Gli ordini religiosi tra riforma e controriforma, in M. Rosa (ed.), Clero e società nell’Italia moderna, Laterza, Roma-Bari 1992, 115-205; R. Rusconi, Gli ordini religiosi maschili dalla controriforma alle soppressioni settecentesche. Cultura, predicazione, missioni, in M. Rosa (ed.), Clero e società nell’Italia moderna, Laterza, Roma-Bari 1992, 207-274; G. Rocca, Istituti religiosi in Italia tra Otto e Novecento, in M. Rosa (ed.), Clero e società nell’Italia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1992, 207-256; S. Pricoco, Da Costantino a Gregorio Magno, in G. Filoramo – D. Menozzi (edd.), Storia del cristianesimo. L’antichità, Laterza, Roma-Bari 1997, 273-442; F. De Giorgi, Cattolici ed educazione fra restaurazione e risorgimento. Ordini religiosi, antigesuitismo e pedagogia nei processi di modernizzazione, Università Cattolica, Milano, 1999; G.G. Merlo, Nel nome di san Francesco: storia dei frati minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo, EFR, Padova 2003; A. Barzazi, Gli affanni dell’erudizione. Studi e organizzazione culturale degli ordini religiosi a Venezia tra Sei e Settecento, Istituto veneto di scienze lettere ed arti, Venezia 2004; F. Landi, Storia economica del clero in Europa. Secoli XV-XIX, Carocci, Roma 2005; G. Pizzorusso, La Congregazione de Propaganda fide e gli ordini religiosi: conflittualità nel mondo delle missioni del XVII secolo, “Cheiron”, 43-44 (2006), 197-240; Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell’Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell’Indice, a cura di R.M. Borraccini e R. Rusconi, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2006; G. Paolini, Il concordato toscano del 1815 sugli ordini religiosi. Documenti inediti, Le Monnier, Firenze, 2006; S. Pavone, Una strana alleanza. La Compagnia di Gesù in Russia dal 1772 al 1820, Bibliopolis, Napoli, 2008.