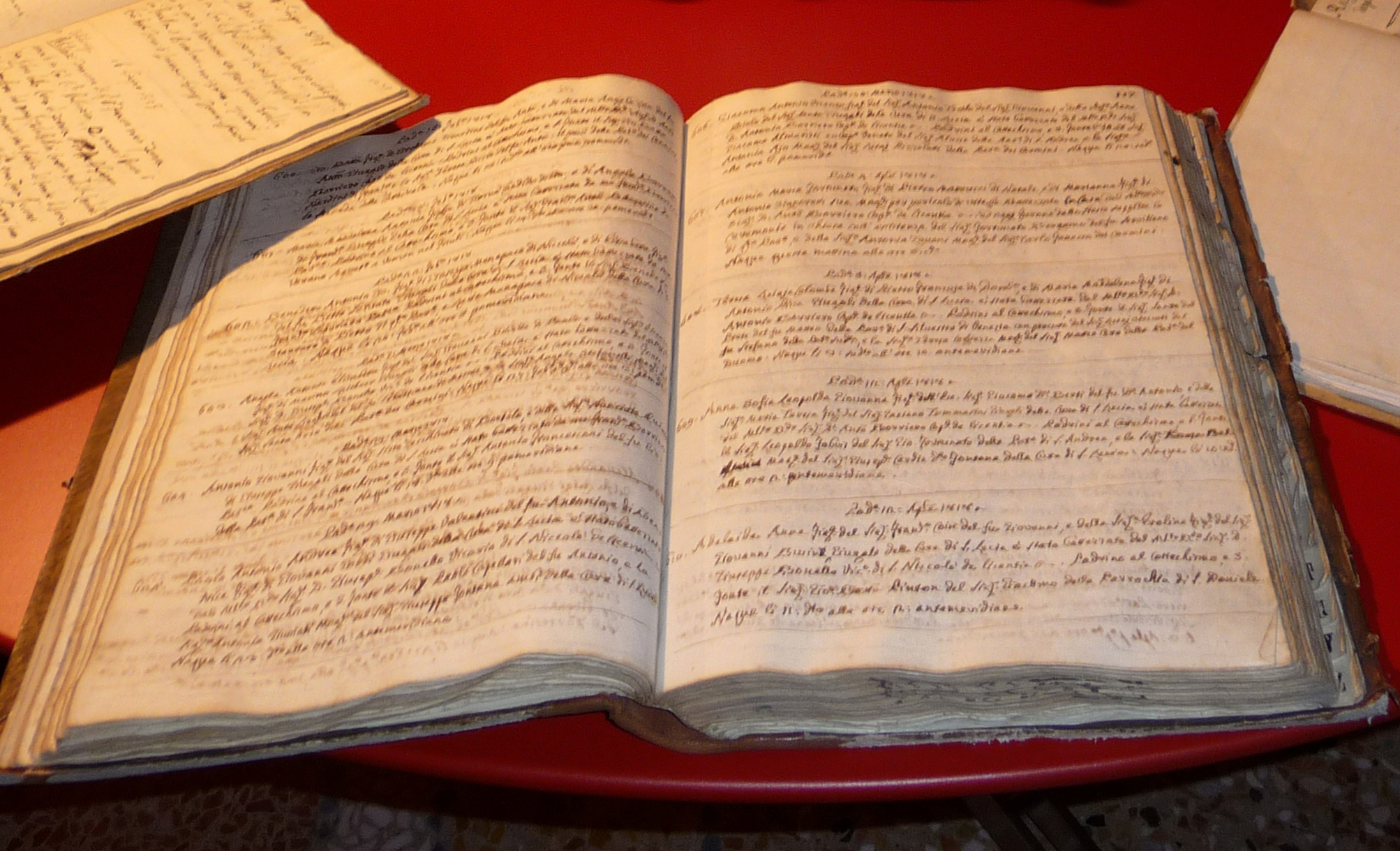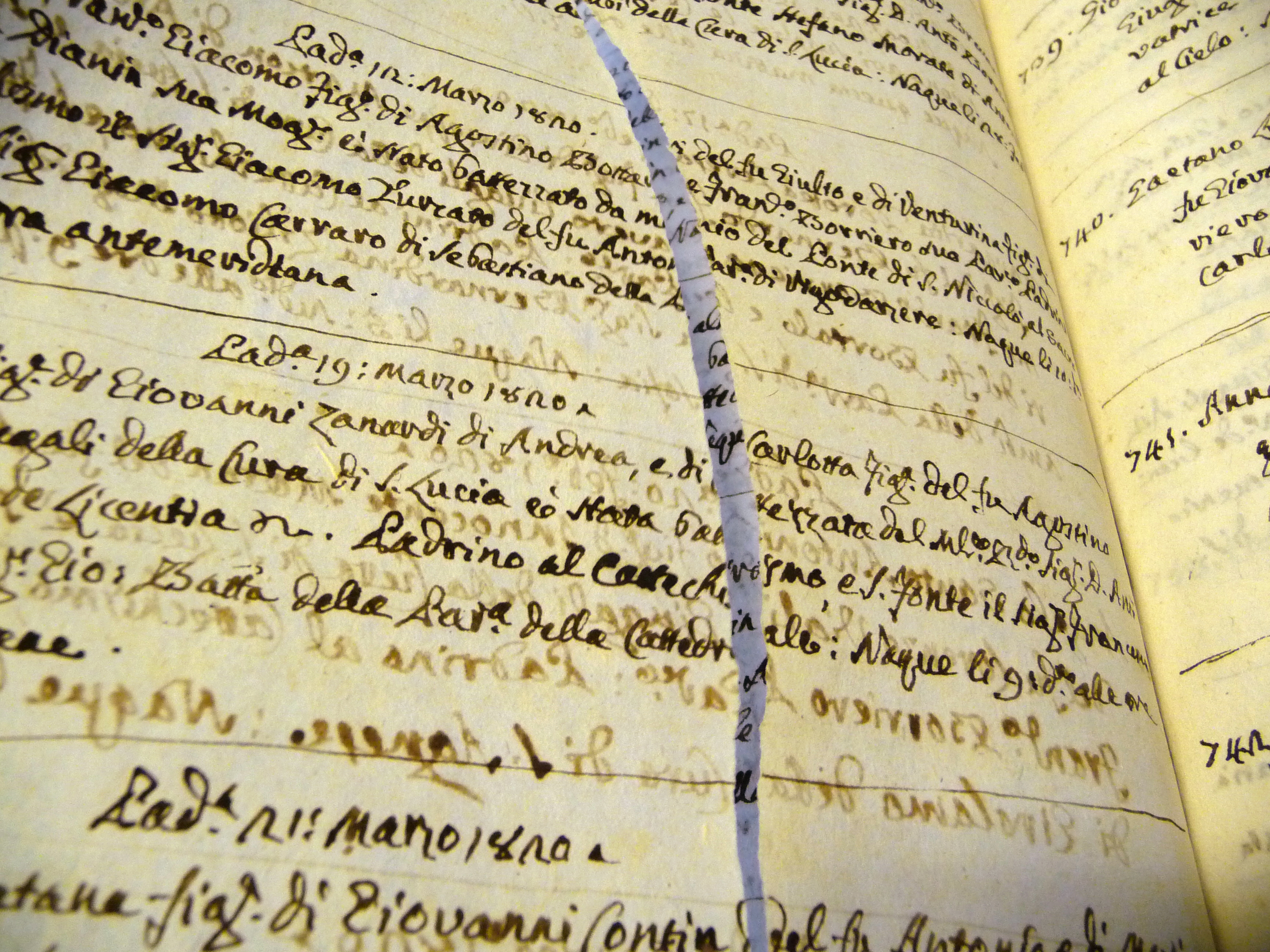Autore: Gaetano Greco
Con «clero secolare» s’intende l’insieme di tutti quei chierici, dai semplici tonsurati fino agli stessi vescovi, che, vivendo nel «secolo» (nella società, a contatto diretto e quotidiano con i laici), sono incardinati in una diocesi o in una chiesa particolare, senza l’obbligo di seguire la regola di un ordine regolare e professare i voti di povertà, obbedienza e castità. Nella storia del clero diocesano, il Concilio di Trento costituisce uno spartiacque fra il Rinascimento e il periodo successivo, fino alle soglie della Rivoluzione francese, benché non siano mancate trasformazioni anche fra gli inizi del XVII secolo e la fine del XVIII; tuttavia questi processi non costituirono una vera novità, ma furono lo svolgimento di una svolta iniziata già nella seconda metà del Cinquecento. Nel corso del basso Medio Evo all’interno della Chiesa cattolica le istituzioni ecclesiastiche diocesane, al cui servizio erano addetto prevalentemente questi chierici, si erano andate conformando con ritmi e modi diversi da regione a regione al modello del «beneficio», ma il sistema beneficiale parve crollare durante l’età rinascimentale. Nel secolo e mezzo precedente il Concilio di Trento, la Chiesa cattolica aveva attraversato una stagione di anarchia istituzionale vissuta all’insegna della caccia ai benefici ecclesiastici, per accumulare rendite sacre e per usare i poteri ecclesiastici secondo finalità politiche. Un simile disordine aveva prodotto danni gravissimi nell’amministrazione dei sacramenti, nella cura d’anime e nella giurisdizione spirituale, precipitati in una condizione di confusione generalizzata, con ampie aree caratterizzate dal vuoto istituzionale in ambito ecclesiastico e dall’assenza di sacerdoti. Mentre nel Basso Medio Evo gli uffici ecclesiastici territoriali erano stati tenuti e gestiti da un clero secolare in grande prevalenza di estrazione locale, in età rinascimentale questi uffici furono occupati da un gran numero di forestieri o di chierici cittadini, che, detenendo la titolarità formale dei benefici, ne consumavano le rendite e i beni dotali, facendosi sostituire solo raramente da preti mercenari di dubbie qualità morali e intellettuali. Questa situazione era legittimata dalla Curia romana, che dispensava, a pagamento, dall’osservanza delle norme canoniche: divieto di cumulo degli uffici, residenza, possesso degli ordini sacri maggiori (irrinunciabili), rispetto dei diritti di collazione e patronato.
Proprio da questo periodo emerge un’incipiente divaricazione nelle fortune dei chierici delle due grandi aree italiane: poiché presso la Curia romana erano attive le succursali dei banchieri del Centro-Nord, i chierici di quest’area erano facilitati nell’affrontare le pratiche finanziarie per impadronirsi dei benefici. Inoltre, alcuni stati territoriali delle medesime regioni cominciarono a istituire uffici pubblici per controllare l’accesso agli uffici ecclesiastici. All’inizio si trattò di misure adottate per finalità politiche: impedire ai propri avversari di accedere agli uffici e favorire partigiani, clienti e familiari. Tuttavia, per stati territoriali centralizzati e autocefali questa prassi governativa poteva accrescere le occasioni occupazionali del clero locale, che ricorreva al potere politico per ostacolare le nomine in favore di concorrenti stranieri. Infine, un altro segnale è offerto dalla presenza di sacerdoti corsi, sardi e siciliani nelle regioni tirreniche: un personale che, pur possedendo un livello culturale al limite dell’analfabetismo, era impiegato nella cura d’anime e nell’amministrazione dei sacramenti in sostituzione dei rettori cumulatori e assenteisti. La disoccupazione cronica dei sacerdoti sardi dipendeva non tanto da una miseria congenita delle loro terre, bensì dall’usurpazione degli uffici cittadini da parte dei chierici d’origine iberica e dall’«ammensamento» dei benefici rurali a favore dei più forti corpi ecclesiastici urbani. Anche se fra il XV e il XVI secolo questo fenomeno interessò tutte le diocesi italiane, e non solo quelle sarde, probabilmente i suoi effetti furono meno gravi nell’Italia continentale. Qui, era più difficile legittimare su larga scala simili operazioni, a causa delle stesse caratteristiche degli insediamenti umani e dei rapporti di produzione esistenti sul territorio, e il reticolo più fitto dei centri urbanizzati favorì la persistenza dei benefici curati negli edifici religiosi dislocati sul territorio.
La nascita di associazioni di ecclesiastici diocesani, come i Preti Secolari di Genova, sul finire del Quattrocento, e, nella prima metà del secolo successivo, i Preti del Buon Gesù di Ravenna, i Preti Contemplativi di Parma o i Preti Riformati di Tortona testimonia la presenza anche nel clero secolare d’istanze di autoriforma ecclesiale testimonia . Dediti all’attività sacramentale e all’istruzione religiosa di chierici e laici, questi sacerdoti diocesani costituirono il primo esempio di un fenomeno che si ripresentò anche altre volte nell’età moderna, almeno alla fine del Cinquecento e poi ancora un secolo dopo. Nell’età della Controriforma l’iniziativa più nota e fortunata fu intrapresa a Milano dall’arcivescovo Carlo Borromeo con i suoi Oblati di S. Ambrogio, dai quali agli inizi del XVIII secolo germinarono gli Oblati missionari di Rho; ma vanno ricordate pure le associazioni ecclesiastiche secolari sorte a Novara e a Pescia, e soprattutto la società dei Pii Operai, fondata a Napoli dal sacerdote Carlo Carafa. Nell’età innocenziana i vescovi manifestarono un visibile sostegno a questi istituti: così, per esempio, su stimolo degli stessi Pii Operai e con il favore degli ordinari, anche a Capua nacque una congregazione di sacerdoti diocesani dediti alla predicazione delle missioni popolari.
Nonostante questi fermenti di autoriforma, il quadro del clero secolare che emerse ancora alla fine del Cinquecento in occasione delle visite pastorali e apostoliche era assai negativo. Il clero appariva culturalmente inadeguato al proprio ruolo, per la diffusa incapacità a comprendere e tradurre in volgare i testi scritti in lingua latina e per la presenza di sacche di analfabetismo. Spesso le celebrazioni liturgiche erano ufficiate senza la lettura del messale (assente in molte chiese), pronunciando formule incomplete e prive di significato, secondo schemi memorizzati nell’apprendistato presso qualche sacerdote, senza aver frequentato le lezioni di un maestro, oppure una vera scuola ecclesiastica. Fra i sacerdoti più assidui nella residenza non pochi erano coinvolti nelle forme meno ortodosse della religiosità popolare: preti disposti a seguire i fedeli nelle pratiche considerate superstiziose, ad assisterli in riti non ammessi dalla gerarchia, a offrire la stessa materia dei sacramenti per funzioni religiose intrise di superstizioni. Sul piano dei comportamenti morali i chierici si differenziavano poco dai laici: gli uni come gli altri erano violenti sia nei rapporti sociali, sia negli affetti e nella sessualità fondata sulla prepotenza: i fedeli, infatti, apprezzavano i parroci conviventi more uxorio con una sola donna, secondo il modello tradizionale latino dell’uomo onesto e ben costumato, mentre criticavano i chierici che, con gli atteggiamenti prevaricatori e disordinati tipici di nobili e facinorosi, turbavano la quiete domestica altrui. Il programma disciplinatore della Controriforma cattolica impose al clero secolare un forte elevamento culturale: la trasmissione orale del sapere religioso e della pratica liturgica doveva essere sostituita da una preparazione teologica e letteraria codificata, fondata sulla pratica della lettura-scrittura e sulla conoscenza della lingua latina, pena la bocciatura agli esami imposti per accedere per gli uffici ecclesiastici con cura d’anime davanti alle commissioni diocesane composte da canonici laureati in utroque iure e da monaci e frati esperti in teologia (gli «esaminatori sinodali»). A tal fine in ogni diocesi doveva sorgere un seminario vescovile, nel quale gli aspiranti all’ordine sacro avrebbero ricevuto l’istruzione letteraria di base e la preparazione teologica e liturgica, ma questo precetto ebbe una scarsa applicazione nel Cinquecento perché i vescovi italiani erano privi dei mezzi finanziari sufficienti per fondare, dotare e mantenere le scuole-convitto capaci di preparare una quota consistente del clero secolare. Solo tardivamente, nella seconda metà del Settecento, fu realizzata la costruzione di una rete di seminari diocesani: fallito il progetto di utilizzare i patrimoni dei cosiddetti «conventini» per dotare i seminari alla metà del Seicento, questo successo del riformismo settecentesco fu reso possibile dalla scelta politica di impiegare in questo delicato settore una parte delle risorse rastrellate con la soppressione di molte case degli ordini regolari. L’attenzione alla qualità nella formazione del clero diocesano interessò i governi illuminati degli stati italiani, ma assunse un aspetto particolare nel ducato di Milano, dove Giuseppe II dette vita nel 1787 a un’istituzione centralizzata: il Seminario Generale di Pavia, sottoposto direttamente al governo e finalizzato a una rigorosa uniformizzazione della preparazione spirituale del clero lombardo. Eppure, già dal Seicento si nota una crescita del livello culturale del clero diocesano impegnato nella cura d’anime e dei membri dei capitoli cattedrali. Mentre la generazione in servizio all’atto del Concilio riuscì in un modo o in un altro a salvaguardare la propria condizione precedente per lungo tempo, le nuove generazioni s’industriarono per trovare a proprie spese i mezzi per imparare a leggere e scrivere in volgare e in latino. In questo processo di elevazione culturale un ruolo fondamentale fu svolto non solo dalle nuove congregazioni regolari, nate proprio con queste finalità e operanti prevalentemente nelle città, ma anche dalla rete distesa a maglie strette su tutta la Chiesa italiana dagli ordini regolari tradizionali. Sono fenomeni complessi, difficili da decifrare prima ancora di quantificarli, ma certamente la presenza di piccoli insediamenti di frati mendicanti nelle campagne ebbe un effetto positivo anche sul versante della formazione del clero secolare rurale: anche in questo ambito intervenne la diffusa presenza dei Regolari, che già supplivano alle deficienze del clero diocesano sul pulpito, sulla cattedra e nel confessionale.
Quanto ai comportamenti morali, il programma cattolico di disciplinamento dei chierici si caratterizzò per la netta distinzione nei confronti dei laici per evidenziare la sacralità insita nella persona ecclesiastica. Alla distinzione nei costumi esteriori (vesti, attività manuali e intellettuali, ecc.) si doveva accompagnare una più rigorosa separazione dai laici, astenendosi dai luoghi e dalle occasioni della socialità umana (piazze, osterie, locande, teatri, «veglie», banchetti, balli, feste nuziali, serenate), «praticando» solo altri ecclesiastici ed evitando le «pericolose conversazioni» con i laici. Questo ideale clericale di stampo monastico non si adattava alle effettive condizioni materiali di vita dei maschi. A parte chi era necessitato a ricorrere alla manodopera femminile per i servizi domestici, molti sacerdoti dovevano e volevano adempiere alle responsabilità di ogni maschio italiano, prendendosi cura di madri, sorelle, cugine, cognate e nipoti: nei casi di parentela stretta, la nostra tradizione imponeva la solidarietà e la convivenza sotto il medesimo tetto. Anche il risultato effettivo della repressione della sessualità degli ecclesiastici è opinabile: l’insistenza delle autorità ecclesiastiche nei confronti della sollicitatio ad turpia da parte dei confessori fa pensare che i chierici abbiano avuto gli stessi comportamenti dei loro coetanei laici. Maggior successo ebbe la lotta contro il concubinato del clero: nonostante la tradizione giuridica e sociale favorevole alle relazioni stabili fra le persone non coniugate con altri, grazie all’accordo fra la gerarchia ecclesiastica e i poteri politici i sacerdoti dovettero rinunciare alle convivenze pubbliche more uxorio, limitandosi a relazioni segrete, possibilmente con donne residenti in altre località, tranne in alcune aree periferiche (Alpi, dorsale appenninica, Maremma) e nelle isole, dove la vigilanza delle gerarchie era meno efficace. Tuttavia, pur marginale è rimasto un elemento di contraddizione, destinato a crescere nei nostri giorni in virtù della massiccia presenza d’immigrati euro-orientali di rito cattolico-unito: nelle comunità grecaniche e albanesi della Sicilia, della Calabria, della Puglia e di Cargese in Corsica il culto sacro era officiato secondo l’antico rito greco-cattolico da sacerdoti che conservavano dell’antica disciplina ecclesiastica orientale il diritto di sposarsi prima di assumere gli ordini sacri maggiori. La latinizzazione delle comunità grecaniche, perseguita dalla gerarchia episcopale per eliminare lo «scandalo» della differenza di disciplina, riuscì nelle zone dove maggiore era la contiguità con le popolazioni latine, come in Puglia, ma fallì dove la Chiesa di rito greco era arroccata in paesi più isolati o dove, come nella stessa Venezia o nei domini genovesi e nella Livorno medicea, i governi avevano adottato politiche protettive nei confronti di chi manteneva relazioni con i popoli delle coste orientali del Mediterraneo.
Per quanto riguarda l’obbligo della residenza nella sede d’ufficio, mentre ai chierici secolari di estrazione urbana fu concesso lo sfruttamento dei benefici posti nelle chiese cittadine e di molti benefici rurali ridotti a cappellanie semplici e privati della cura d’anime, nelle campagne si liberarono numerosi uffici curati, ormai divenuti scarsamente appetibili da parte dei chierici cittadini, poiché richiedevano la residenza personale sul luogo dell’ufficio. A questo punto la professione ecclesiastica tornò a offrire prospettive valide sia per i giovani, sia per le loro famiglie, disponibili a investire mezzi finanziari ed energie nella professione sacerdotale, facendo affidamento sul godimento dei diritti di patronato privato e comunitario. Nel contempo, anche le comunità rurali, che non avevano mai cessato di vigilare con attenzione sulla qualità dei servizi religiosi ritenuti essenziali, ripresero a investire nel sacro con la sicurezza che le risorse impiegate non sarebbero state asportate da chierici forestieri residenti altrove. Il flusso d’investimenti da parte degli enti pii e delle comunità andò a vantaggio sia del mantenimento di un personale ecclesiastico locale, sia di un livello più elevato di funzioni religiose, come la celebrazione di una seconda messa nei giorni festivi, la presenza di un secondo sacerdote nel confessionale, la predica durante la Quaresima e l’Avvento, o il suono dell’organo a canne per accompagnare la liturgia sacra. L’esistenza di una massa di legati pii si tradusse nella crescita del cumulo delle messe: la loro celebrazione era ricompensata con l’«elemosina manuale» o «tassa», stabilita periodicamente dall’ordinario diocesano locale, per adeguarla al costo della vita. D’altronde, questo ingombrante numero di oneri sacri alimentava la crescita del personale ecclesiastico, creando una ragionevole aspettativa di lavoro nel sacro: grazie alla celebrazione di queste messe non sarebbe mancato il mezzo per procacciarsi il pane quotidiano esercitando il mestiere di sacerdote. Infine, nelle regioni centro-settentrionali borghi e comunità rurali istituirono «condotte» di cappellani-maestri di scuola: furono stipendiati sacerdoti che insegnavano ai bambini i rudimenti della lettura, della scrittura e dell’aritmetica e celebravano la seconda messa domenicale nella chiesa parrocchiale, oltre ad assistere il parroco nel ministero della confessione e nell’istruzione della dottrina cristiana.
Questa situazione in movimento trovava il suo fondamento in due presupposti: da un lato, una forte difesa delle «pertinenze laicali» da parte del potere politico statale, indipendentemente dal vantaggio immediato per gli alleati, i clienti, i familiari, i partigiani e via dicendo (e proprio in ciò si potrebbe constatare il salto di qualità rispetto allo stato rinascimentale); dall’altro lato, un’incidenza assai ridotta dell’immunità fiscale e personale dei chierici, tale da poter escludere o minimizzare la rilevanza di questo specifico incentivo per coloro che intraprendevano la carriera ecclesiastica. Questi fenomeni si saldarono con i risultati conseguiti dal programma di disciplinamento del clero secolare nelle regioni centro-settentrionali: senza diventare casti e pii e senza abbandonare del tutto le «pericolose conversazioni» con i laici, i sacerdoti assunsero, comportamenti più riservati e non «scandalosi». Sullo sfondo si stagliano nettamente quelle «strategie familiari» e comunitarie, nelle quali le finalità economiche s’intrecciavano con motivazioni di prestigio e onorabilità sociali, cumulando eredità patrimoniali con non meno importanti «eredità immateriali». Ideare e perseguire simili strategie, nelle quali il sacerdozio si presentava sotto il profilo della «professione», richiedeva la presenza di regimi politici stabili, intenti a salvaguardare l’ordine sociale interno all’interno delle garanzie del diritto tradizionale, sufficientemente autonomi dalle pressioni della Curia romana e privi di reali interessi a favorire forestieri o sudditi provenienti da altre regioni o nazioni: proprio il contrario di quanto avveniva nei domini spagnoli.
Questo sistema, infatti, non ebbe successo nell’Italia centro-meridionale e insulare, per la quale si può parlare di sacerdozio come «condizione». Qui continuarono a trovare applicazione le cosiddette «regole di Cancelleria» della Curia romana, comprese la provvisione apostolica ai benefici ecclesiastici locali e l’imposizione di pesanti pensioni sulle rendite beneficiali a favore di forestieri, a danno dei chierici del posto e dei loro patroni, disincentivati a finanziare le Chiese locali . Una maggiore impermeabilità alle ingerenze esterne fu dimostrata dalle chiese «ricettizie» a massa comune indivisa, quando riuscivano a impedire che l’ordinario diocesano locale s’intromettesse nel controllo dei patrimoni, nella gestione degli uffici, nella nomina dei chierici «partecipanti». Ancora nel Settecento la difesa dell’autonomia del clero ricettizio nei confronti della giurisdizione vescovile costituì un caposaldo della politica giurisdizionalistica dei Borboni nell’alveo della tradizione anticuriale, perché chiudere la porta all’intrusione dei vescovi significava anche sbarrare l’accesso alle provvisioni apostoliche nei mesi «riservati» alle nomine della Curia romana. A differenza del Centro-Nord, nel Mezzogiorno i chierici in minoribus costituirono sempre un’ampia aliquota del clero secolare, al quale si aggiungevano i «chierici coniugati» o «salvatici», i «diaconi selvaggi», i «varas», i «monazillos» e altri ancora, che godevano i privilegi clericali con il matrimonio e la famiglia. Allo stesso modo degli oblati delle congregazioni regolari e delle «bizzoche», in cambio dei loro servizi come sagrestani, come «procuratori» delle chiese, come «cursori» vescovili, come guardie armate, questi tonsurati chiedevano alla Chiesa solo la duplice protezione del privilegio clericale: l’esenzione dai tributi fiscali e l’immunità personale nei confronti delle corti giudiziarie civili. Nella Chiesa meridionale, la pratica dell’ordinazione a titolo di patrimonio personale e l’uso di attribuire ai figli chierici la titolarità del patrimonio domestico raggiunsero dimensioni altrove sconosciute, scatenando una forte conflittualità sociale all’interno di ogni comunità, nonché la reazione dei baroni, allarmati dalla diminuzione dei soggetti fiscali. Infatti, poiché il regime fiscale d’antico regime si basava sulla ripartizione delle imposte fra le comunità e i feudi, l’assegnazione legale di patrimoni privati ai chierici consentiva alle loro famiglie di eludere l’imposizione fiscale civile, con la conseguenza di accrescere il carico dei tributi gravante sulle famiglie prive di chierici. D’altronde, nel Meridione e in Sicilia sin dalla prima metà del Seicento – quindi assai prima dell’esplosione di un fenomeno analogo negli stati centro-settentrionali – era imponente anche il numero dei chierici che permanevano negli ordini sacri minori, senza ascendere al sacerdozio: chierici inutili per il servizio sacro, non impiegabili in alcuna funzione religiosa e pronti a tornare allo stato laicale con il semplice consenso di un vescovo compiacente.
L’emigrazione dei preti dalle campagne verso le città e da una regione all’altra d’Italia è un altro capitolo fondamentale nella storia del clero secolare. Accanto ai due modelli indicati, con le loro varianti (la «coloniale» sarda e l’«indisciplinata» còrsa), vi era tutta una molteplicità di aree, geograficamente assai diverse ma assimilabili sotto la categoria di «periferia». Qui, dove i poteri politici erano frammentati e non vi era una precisa coincidenza fra le circoscrizioni diocesane e i distretti civili o addirittura gli stati, i vescovi non riuscivano a controllare i propri chierici, né potevano verificare il conferimento degli ordini sacri maggiori, ottenuto non a titolo di beneficio, bensì a titolo di patrimonio personale: un patrimonio spesso fittizio, perché concesso all’ordinando solo temporaneamente da parenti compiacenti. Questa finzione favoriva la crescita di un clero secolare composto da sacerdoti pronti a emigrare per guadagnarsi la vita nelle regioni più ricche con gli strumenti del mestiere: la celebrazione della messa e, ottenuta la licenza da parte degli ordinari locali, l’amministrazione di altri sacramenti, come la confessione. Dopo un rallentamento nei decenni del post-Tridentino, questo flusso di mercenari del sacro si riattivò nel Seicento a causa della persistenza degli uffici di vicari amovibili e della ripresa di fondazioni sacre. Fra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento la richiesta di manodopera sacramentale fu alimentata dall’accentuarsi del fenomeno di «non-sacerdotalizzazione» dei chierici titolari di benefici semplici e fruitori di rendite ecclesiastiche secondo modalità meramente parassitarie, proprio mentre esplodeva la «clericalizzazione» della società italiana con conseguenze disastrose per la disciplina di un corpo ecclesiastico divenuto pletorico. La crescita del numero dei chierici secolari rese chimerico il progetto di un clero secolare differenziato e separato dal suo contesto sociale, impedì ai vescovi la gestione della preparazione culturale dei chierici e fece riemergere costumi e comportamenti tipicamente laicali. Sullo scorcio del secolo, nell’«età innocenziana», spinta dalle congregazioni romane e dai pontefici, la gerarchia episcopale rinnovò la sua attenzione nei confronti della formazione e dei costumi del clero diocesano. Inasprite le verifiche al momento delle ordinazioni sacre e degli esami sinodali per la collazione dei benefici, furono imposte a tutti i chierici la frequenza alle conferenze sui «casi di coscienza» e agli «esercizi spirituali»; furono incoraggiate le attività delle congregazioni regolari e secolari dedite all’istruzione del clero e la nascita di nuove associazioni sacerdotali; fu intensificata l’attività ispettiva delle visite pastorali, rivolta soprattutto al controllo delle funzioni sacramentali e amministrative degli ecclesiastici, furono favorite le missioni popolari che intervenivano con particolare attenzione sui costumi e sui comportamenti dei chierici. Il rinnovato impegno di alcuni vescovi si protrasse per alcuni decenni, grazie anche all’intervento propulsivo delle congregazioni romane e di pontefici come Benedetto XIV, e confluì nell’alveo del riformismo cattolico di stampo muratoriano. Più incisivi, però, furono gli interventi governativi, ancorché non omogenei fra stato e stato. Per esempio, nel Sud borbonico e nel Piemonte sabaudo si puntò a frenare la crescita del clero aggravando i requisiti per le ordinazioni ecclesiastiche, mentre nella Lombardia e nella Toscana lorenesi si mirò prima a disincentivare le fondazioni di nuovi benefici non curati e a incardinare tutto il clero nelle chiese curate, ponendolo al servizio dei parroci. Nell’insieme si avviò così un processo di «sacerdotalizzazione» del clero secolare, che, sospinto a procedere nell’ordinazione sacra, fu obbligato a lavorare «nella vigna del Signore», impegnandosi nelle funzioni religiose e nell’assistenza alla cura d’anime. Nel complesso, anche per il clero secolare iniziò una fase discendente sul piano dei numeri: come per i regolari, a questo fenomeno contribuì la diffusione di una cultura secolarizzata, in larga misura di provenienza ultramontana ma non estranea alla nostra tradizione umanistica.
La sacerdotalizzazione del clero secolare superò i drammi della Rivoluzione e le illusioni passatiste della Restaurazione, diventando un fatto acquisito. Lo scontro frontale tra i nuovi ideali, e la dottrina della Chiesa cattolica relegò in secondo piano le antiche «strategie familiari» e le antiche forme di composizione sociale, con il ruolo essenziale assunto dal parente prete e/o dai patrimoni degli uffici sacri. In ambito ecclesiastico la rivoluzione sostituì a questo sistema nuove motivazioni ideologiche e con esse una nuova «vocazione» sacerdotale, basata sulla scelta individuale fra «il rosso» e «il nero».
Fonti e Bibl. essenziale
G. Battelli, Clero secolare e società italiana tra decennio napoleonico e primo Novecento. Alcune ipotesi di rilettura, in Clero e società nell’età contemporanea, a cura di M. Rosa, Roma-Bari, Laterza, 1992, 43-123; E. Brambilla, Società ecclesiastica e società civile: aspetti della formazione del clero dal cinquecento alla Restaurazione, in «Società e Storia», IV, 1981, n. 12, 299-366; G. Chittolini, Note sui benefici rurali nell’Italia padana alla fine del Medioevo, in Pievi e parrocchie in Italia nel Basso medioevo, Atti del VI Convegno di Storia della Chiesa in Italia, Roma, Herder, 1984, 149-193; F. De Giorgi, La parrucca dei preti. Limiti interiori all’esteriorità barocca e sacralità sacerdotale nell’«Ancien Régime», in Le carte e gli uomini. Storia della cultura e delle istituzioni (secoli XVIII-XX), Studi in onore di N. Raponi, Milano, Vita e Pensiero, 2004, 3-42; T. di Carpegna Falconieri, Il clero secolare nel basso medioevo: acquisizioni e proposte di ricerca, in «Archivio della società romana di storia patria», CXXXII, 2009, 23-40; C. Dionisotti, Chierici e laici, ora in Id., Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967, 55-88; C. Fantappiè, Istituzioni ecclesiastiche e istruzione secondaria nell’Italia moderna: i seminari-collegi vescovili, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», XV, 1989, pp. 189-240; G. Greco, Ecclesiastici e benefici in Pisa alla fine dell’antico regime, in «Società e storia», III, 1980, n. 8, 299-338; Id., Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana dal Cinquecento al Settecento, in Clero e società nell’Italia moderna, a cura di M. Rosa, Roma-Bari, 1992, 45-113; M. Guasco, Storia del clero in Italia dall’Ottocento a oggi, Roma-Bari, Laterza, 1997; L. Mezzadri, La spiritualità dell’ecclesiastico seicentesco in alcune fonti letterarie, in Problemi di storia della Chiesa nei secoli XVII-XVIII, Atti del V Convegno di aggiornamento, Bologna 3-7 settembre 1979, Napoli, Dehoniane, 1982, 45-89; G. Miccoli, «Vescovo e re del suo popolo». La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria, in Storia d’Italia. Annali 9. La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino, Einaudi, 1986, 881-928; Preti nel medioevo, «Quaderni di storia religiosa», IV, 1997, Venezia, Cierre Ed.; M. Rosa, Clero cattolico e società europea nell’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2006; P. Stella, Strategie familiari e celibato sacro in Italia tra ’600 e ’700, in «Salesianum», XLI, 1979, 73-109; X. Toscani, Il reclutamento del clero (secoli XVI-XIX), in Storia d’Italia. Annali 9, cit., 573-628; A. Turchini, La nascita del sacerdozio come professione, in Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, a cura di P. Prodi, con la collaborazione di C. Penuti, Bologna, Il Mulino, 1994, 225-256; M. Turrini, La riforma del clero secolare durante il pontificato di Innocenzo XII, in «Cristianesimo nella Storia», XIII/2, 1992, 329-358; P. Vismara, Il sacerdozio come “professione”. Considerazioni sull’epoca moderna, in “Una strana gioia di vivere”. A Grado Giovanni Merlo, a cura di M. Benedetti e M.L. Betri, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2010, 229-238.