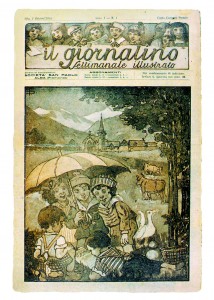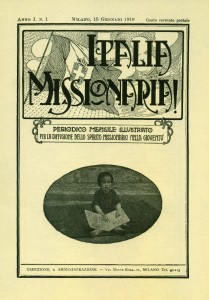Autore: Stefania Pietroforte
L’identità di un popolo è spesso incarnata da personaggi della storia politica o culturale che esprimono caratteri salienti della sua vicenda. Dante Alighieri è probabilmente la figura di intellettuale che meglio risponde al bisogno di rappresentare le origini e le radici della cultura italiana: l’altezza dell’ingegno poetico e la sventurata sorte politica sembrano riassumere il contrasto frequente nella nostra storia tra superba capacità creativa e miseria delle condizioni politiche e sociali. Difficile, quindi, non citare Dante anche a proposito della filosofia italiana, tanto più che il suo lavoro poetico e letterario si sostanzia di materia filosofica elaborata in maniera originale sia nella Divina Commedia, dove esplicita è la questione del ruolo della filosofia nella vita dell’uomo e nella missione della sua salvazione, sia nella Monarchia, con la teoria dei due soli, dove egli mette a tema il problema della autonomia della ragione rispetto alla Rivelazione e alla fede. Non a caso nella prima metà del Novecento storici della filosofia di prima grandezza come Bruno Nardi si sono impegnati a mettere in luce la ricchezza delle fonti filosofiche di Dante e ne hanno rimarcato l’originalità, scoprendo una figura non assorbita, come si era creduto a lungo, nell’orizzonte categoriale del tomismo, ma sensibile invece a correnti spirituali che avevano percorso gli ultimi secoli del Medioevo e facevano sentire la loro voce ancora nella Firenze del Trecento.
Tuttavia la concezione filosofica di Dante restava saldamente inquadrata in una visione teologica che fu di fatto scalzata dall’Umanesimo, il movimento di idee che fra Trecento e Quattrocento irruppe con forza nei principali paesi europei. Nell’Italia dei comuni e del particolarismo politico esso diede vita a un rinnovamento culturale e concettuale di vastissima portata che è stato, per certi versi, uno dei motivi peculiari dell’età moderna. Nota dominante dell’Umanesimo era appunto la centralità dell’uomo nel mondo e il conseguente convergere dell’attenzione filosofica su questo soggetto ora diversamente considerato. Questo fatto è sembrato spesso un rovesciamento del sentiment medievale, un capovolgimento da cielo a terra, da Dio all’uomo, dalla teologia alla letteratura. Ma i personaggi che lo hanno rappresentato in maniera eminente dimostrano che la questione era più complessa. Petrarca, Bruni, Salutati, Bracciolini,Valla guardavano all’antichità greco-romana come riferimento fondamentale. Il richiamo al mondo antico non era fuga dalla realtà, ma attingimento di una vita più vera, di una forma umana originaria che accomunava gli spiriti al di là del tempo. L’individuo si ritraeva dal mondo naturale che lo circondava, “moriva” al mondo per trovare, in un discorso interiore dell’anima, il legame con la comunità spirituale di tutti i tempi e fruire, grazie alle opere di uomini di elevato sentire, del pregio dell’essere umano, della sua più vera natura. Quel richiamo, che assumeva accenti anche assai diversi, non era allontanamento ascetico dal mondo, ma ricerca di una dimensione culturale più aderente all’uomo, più in contatto con la sua esperienza di vita, individuale e sociale, anche dolorosa, anche difficile, ma tanto più ricca di valore morale quanto più essenzialmente ed esclusivamente sua. L’anelito di Petrarca a fuggire il sentiero e le orme di altri era non solo desiderio di solitudine ma anche interiorizzazione, dialogo dell’anima con se stessa e, in questo discorrere, ritrovamento di un motivo comune fondamentale con tutti gli uomini. Era distacco necessario per rintracciare quell’identica natura umana che l’antichità aveva espresso quasi in una purezza ideale. E se Petrarca viveva ancora con tensione tormentosa l’affermazione di questo bisogno, perché avvertiva come irrisolto il contrasto tra l’ideale cristiano e quello pagano degli antichi, Bruni non lo sentì come un problema. Traduttore dal greco di Platone e soprattutto dell’Etica Nicomachea e della Politica di Aristotele, Bruni ne prendeva forza per sostenere che propriamente umana è solo la vita civile, la vita della polis e che l’individuo dispiega la sua natura solo nel concerto civile. Non c’era dissidio tra pensiero classico e Cristianesimo: se per i cristiani il fine era in un’altra vita mentre per gli antichi la virtù era il fine supremo della vita terrena, gli uni e gli altri sostenevano però le stesse cose sulla giustizia, la temperanza, la fortezza, la liberalità e le altre virtù e vizi ad esse contrari. Negli antichi e nei moderni, secondo Bruni, parlava la stessa verità, lo stesso Dio; per questo bisognava ascoltarli e andare a scuola da loro. Ecco allora che la traduzione degli autori latini e greci assumeva il significato di mettere in auge la verità e non di proiettarla nel passato, di portare la cultura fuori dalla panne della logica disancorata dalla sostanza della vita reale. La polemica con l’assetto scientifico medievale si faceva, per questo aspetto, molto sentita: è l’universo delle lettere, che indaga il mondo morale dell’uomo, l’ambito in cui la verità va ricercata; è per il tramite della parola poetica e letteraria che si scopre l’esperienza intima e spirituale dell’uomo; è grazie allo studio di queste opere che si risale alle scaturigini del pensiero che un animo incrudelito ha costretto nei termini sterili della logica aristotelica. La grammatica si sostituiva così alla logica come strumento con cui entrare in contatto con la vera essenza della vita umana. In questo modo l’Umanesimo si configurava come contestazione e rifiuto di una razionalità fuorviante e senza esito e come ricerca di nuovi modi e nuovi contenuti di sapere. Con decisione perciò Valla polemizzò con il metodo dei dialettici e lo spirito sistematico, per affermare invece che la valenza grammaticale del linguaggio era la chiave di volta per lo studio del pensiero.
Le critiche degli Umanisti, per quanto radicali fossero, anche quando accolsero motivi filosofici ritenuti irreligiosi come l’epicureismo non abbandonarono il convincimento della sostanziale spiritualità del reale e di una vita universale che circola nel tutto, dove Dio è presente e l’uomo trova il suo posto. Proprio il forte accento sulla spiritualità e l’idea di una umanità unita come in blocco metafisico che attraversa il tempo e lo spazio dovevano servire d’appoggio al più grande filosofo del Quattrocento, quel Ficino, stimato dai dotti di tutto il mondo, che fece di Firenze il polo di riferimento dell’universo umanistico.
Se una era l’umanità, uno doveva essere il suo spirito, unica e antichissima la sapienza, che Ficino rintracciava nei Libri ermetici e negli scritti di Platone, documenti di una pia philosophia appartenente ai saggi di tutti i tempi. Il rapporto con l’antico aveva, in questo caso, una valenza spiccatamente religiosa: quella sapienza era infatti frutto di una eterna rivelazione che la docta religio scopriva quando, rientrata l’anima dentro di sé allontanandosi dai sensi, si lasciava investire dalla luce divina. La mens riceveva così la verità che poteva essere comunicata ad altri. La conoscenza si configurava come esperienza religiosa di cui i grandi pensatori della storia erano stati protagonisti, primo fra tutti Platone che Ficino indicava come un profeta. Questo il significato dei testi platonici e neoplatonici che Ficino tradusse rendendoli accessibili come fonti della vera filosofia. Se ad un capo di essa si trovava Platone, al termine c’era il Cristianesimo, di cui il filosofo greco era precursore. Lui per primo aveva indicato la via del distacco dalle cose del mondo, scoprendo in quest’autonomia il carattere fondamentale della conoscenza umana. Aristotele era, per questo verso, lontano dal vero. Ma Ficino (e dopo di lui anche Pico della Mirandola con l’ideale della concordia dei filosofi) lo recuperava con la teoria dell’anima. Infatti, come l’intelletto agente aristotelico, l’anima era attività ma, diversamente che in Aristotele, era anche sostanza separata e moltiplicabile per ciascun individuo, immortale. Così, però, l’anima non era più forma del corpo: di Aristotele Ficino recuperava in realtà l’elemento platonico.
I motivi dell’aristotelismo erano invece tutt’altro che dimenticati a Padova, dove il più importante aristotelico del Cinquecento, Pietro Pomponazzi, indagando la natura umana la concepiva come punto mediano tra mortalità e immortalità. Egli però intendeva l’immortalità solo come un’ aspirazione, un’ansia. L’uomo in effetti era un grado della natura e questa a sua volta era un continuum. La conoscenza, quindi, non poteva prescindere dal fantasma. La filosofia di Pomponazzi era scaturita dalle dispute sull’anima; essa si presentava come la risoluzione della lacerazione tra intelletto trascendente e separato e intelletto mortale a favore di quest’ultimo. Senza alcun timore, il filosofo aristotelico sosteneva che l’anima era legata al corpo e moriva con esso, che la religione non aveva valore conoscitivo ma pratico, infine che la teologia inficiava i rapporti tra fede e scienza. Questa doveva conoscere la natura iuxta propria principia. Dall’identità di religione e filosofia di Ficino si passava qui alla loro netta separazione, negando ogni trascendenza. Era l’aristotelismo declinato seguendo la sua vena più antiplatonica. Un forte senso dell’autonomia della scienza esprimeva pure Bernardino Telesio che criticava la filosofia aristotelica come ricettacolo nascosto della trascendenza platonica: la sua polemica contro “forme” colpiva l’incapacità di questa filosofia di dar conto del mutamento. Il sapere doveva seguire il processo naturale senza sfigurarlo con la creazione di entità immaginarie. Indagare la natura iuxta propria principia era il motto anche del naturalismo telesiano.
Ma il Cinquecento fu ricco anche di altre esigenze, metafisiche, di riforma morale e politica. Una potenza infinita non può produrre un effetto finito; dunque il mondo creato da Dio è un universo infinito. Così per esempio Giordano Bruno si poneva in rotta di collisione sia con la fede cristiana che con la fisica aristotelica, e si incontrava invece con la teoria di Copernico che, infrante le barriere del mondo, consentiva di concepire infiniti spazi e quindi una visione di Dio e delle cose più elevata. Ma Bruno faceva poi fatica a distinguere Dio dal mondo e sconfinava in un panteismo non privo di contraddizioni e risucchiante ogni rilevanza dell’individuo. Fortissima fu la spinta riformatrice, sia religiosa che politica, di Campanella. Ma il pensiero che più sconvolse e lasciò un segno profondo fu quello di Machiavelli, per il quale l’uomo, che nella sua essenza è natura, era stretto nella morsa di fortuna e virtù. La virtù non era che la capacità di accettare la necessità che ci circonda, quella espressa appunto dalla fortuna. Nell’Italia delle signorie e dei conflitti sanguinosi, il primo bene era la pace. Per ottenerla occorreva conoscere senza pregiudizi la natura umana. L’analisi di Machiavelli la vide dibattersi nelle spire di una sorte già assegnata, come già segnato era pure l’andamento della storia civile. Naturalismo arricchito di cultura umanistica fu quello di Machiavelli, nel quale la trascendenza non aveva alcun ruolo. Giudicato immorale e condannato, costituì un riferimento imprescindibile per il pensiero politico dei secoli a venire.
La spinta dell’Umanesimo, la ripresa di Platone e lo sviluppo in senso naturalistico di una parte della filosofia peripatetica rappresentavano gli elementi del panorama filosofico italiano che non si era confrontato con la Riforma protestante. Essi ebbero effetti importanti sul Concilio di Trento che, chiamato a rispondere soprattutto al problema dell’antitesi tra grazia divina e libertà umana, mostrò di non essere insensibile al portato dell’Umanesimo. Infatti il compromesso che si trovò per la soluzione del problema riconosceva la collaborazione umana con l’opera di Dio: la grazia restava dono gratuito, ma l’uomo era libero di aderirvi o meno. Era l’ammissione dell’importanza dell’uomo, del suo protagonismo, forse impensabile senza l’esperienza umanistica che andava ad arricchire un aspetto della teologia cristiana. Ma il Concilio non fu solo questo. Fu anche deciso richiamo alla tradizione e all’autorità, spesso interpretato come autoritarismo. E’ ben noto che questo fatto portò la Chiesa a un conflitto con i risultati di quel sapere naturalistico-scientifico di cui Galilei era figura emblematica e la cui condanna (1616) assunse valore altamente simbolico.
Anche per Galilei la conoscenza cominciava con l’esperienza e la natura doveva essere indagata iuxta propria principia. Il mondo, però, era scritto in caratteri matematici, gli stessi con i quali Dio lo aveva creato, e che erano conosciuti propriamente dalla ragione. Dal mondo sensibile si passava quindi all’indagine razionale, per tornare solo dopo alla verifica sperimentale. Matematica e ragione erano perfettamente affini e della stessa natura era pure la mente divina. La verità era l’incontro della mente umana con quella divina sul piano della matematica esperita nel mondo. La differenza tra il sapere divino e quello umano era solo di grado. L’intero sistema dell’universo creato e increato era il luogo in cui si rispecchiava una assoluta razionalità. La fiducia nella divinità della mente umana, nella struttura matematica del reale, nella creazione di un simile mondo ad opera di Dio erano evidentemente presupposti filosofici di chiara ascendenza rinascimentale, e da quel ceppo discendeva il robusto platonismo che ora costituiva l’intelaiatura della scienza naturale. Le propaggini del platonismo messo in auge dal ritorno agli antichi dettato dall’Umanesimo toccavano qui una meta impensabile per Ficino, mentre il richiamo all’esperienza, che tanto doveva ad Aristotele, si svolgeva in funzione della distruzione definitiva della sua visione del mondo. L’impostazione filosofica di Galilei, condivisa da molti scienziati dell’epoca, era una concezione metafisica che non poteva essere derubricata a ipotesi senza perderne il valore. La condanna, malgrado l’abiura, non valse a scalfirla.
Il timore di un ritorno alla tradizione fu uno dei motivi che, nel Seicento, favorì l’ingresso in Italia della filosofia di Cartesio. Il filosofo francese fu visto come campione dell’antiautoritarismo. Il suo metodo sollecitava una indagine sgombra dai pregiudizi. La sua concezione scientifica poteva facilmente essere accostata a quella di Galilei, andando così a rafforzare la schiera di coloro che perseguivano l’ideale di una conoscenza scientifica del tutto indipendente da interferenze religiose. Cartesio venne associato anche a Gassendi e alla dottrina atomistica, con la quale sembrava che il meccanicismo potesse declinarsi, con il risultato di spingere alcuni pensatori (Borrelli, Valletta, Grimaldi) a posizioni ritenute del tutto in contrasto con la fede e quindi condannate. Questo uso di Cartesio era possibile, però, solo se si scindeva la sua fisica dalla metafisica. Vi fu chi invece, come Fardella, potenziò quel legame e non solo negò l’esito atomistico ma, tenendo fermo alla centralità della matematica, mise in questione la sostanza materiale, l’evidenza delle cose, la natura matematica del punto come struttura della realtà; dubbi che rafforzavano il bisogno della veracità divina, perché fosse scongiurato lo scetticismo. Insomma il cartesianesimo era tirato da due parti: per un verso per giustificare una scienza che tendeva al materialismo, per l’altro era utile per indagare più a fondo gli esiti di un platonismo cresciuto e trasformato nei secoli che, risolvendo importanti problemi, non di meno gravi ne mostrava. In entrambi i casi la filosofia di Cartesio era accolta come un baluardo contro tentazioni retrive. Era l’arma in più che consentiva di contrastare l’autoritarismo della Chiesa, spesso in difficoltà di fronte al nuovo. Lo disse senza più alcun timore Giannone che nella sua Istoria civile condannò il potere temporale della Chiesa, con argomenti e sentimento ormai illuministici.
I problemi irrisolti della filosofia cartesiana erano però molti e grandi: anzitutto quello che si annidava nel divario tra mente divina e mente umana, rimarcato proprio dal cogito, che era certezza, sì, ma non atto creativo. Come era possibile allora la conoscenza se, come dimostrava la matematica, vero è solo ciò che l’uomo fa, ciò che la mente umana costruisce da sé? Una risposta originale venne offerta da Vico. Tenendo fermo al principio che il vero e il fatto convertuntur e che questo è propriamente scire per causas, scoprì nella storia e nel linguaggio il regno nel quale davvero l’uomo era creatore. All’origine delle parole vi erano forme spirituali, non concetti. Esse si sono manifestate e determinate storicamente. Quei valori, immanenti alle loro stesse manifestazioni, costituivano la mappa dello spirito umano ricostruibile solo a partire dalla storia che le aveva viste svolgersi e attuarsi. La storia, dunque, rivelava la natura creativa dell’uomo e il ripetersi secondo modalità che ne facevano un ciclo eterno. L’essenza che la filosofia aveva cercato nella trascendenza doveva ora essere rintracciata nelle creazioni della fantasia, del linguaggio, del pensiero. La verità non era un’idea separata ma qualcosa che si era fatto e doveva ancora farsi. Gli uomini vivevano e progredivano fino al punto in cui questo perfezionamento tornava indietro per riprendere circolarmente il suo andamento. Nessuna età dell’oro, perché eternità e storia coincidevano. Questa ciclicità infinita era vista da Vico come il segnale che una Sapienza più alta governava l’ordine del mondo: la Provvidenza divina era l’anima del processo universale. Ma questa idea era difficilmente compatibile con quella di una religione rivelata. La risposta di Vico a Cartesio raccoglieva la potenza creativa del razionalismo trasformandola completamente, ma non andava d’accordo, però, con la fede cristiana.
L’influenza del pensiero francese in Italia non si limitò a Cartesio. Nel Settecento furono letti e apprezzati gli Enciclopedisti (Voltaire, d’Holbac, Maupertuis, Montesquieu) e Condillac insegnò a Piacenza lasciando un’impronta indelebile nel collegio Alberoni (Gioia, Romagnosi). Rafforzato ulteriormente dalla filosofia di Locke, l’Illuminismo promuoveva l’idea di una ragione universale, appartenente a tutti gli uomini, fondamento di diritto naturale; insisteva non solo sul valore dell’esperienza, ma sul fatto che scopo della filosofia dovesse essere ciò che è utile alla vita umana e alla felicità. Proprio per questo la filosofia illuministica era particolarmente interessante per un popolo che soffriva di arretratezza sociale, economica e culturale e che, soprattutto nel meridione, sentiva la mancanza di educazione alla vita civile. Così, malgrado la contraddittorietà di dottrine che si basavano su un concetto di ragione e natura eterne e professavano poi la necessità del progresso, filosofie come quella di Filangeri a Napoli poterono rappresentare un vessillo di emancipazione umana e sociale per genti dispoticamente assoggettate, mentre a Milano i fratelli Verri e Beccaria esaltarono la cultura e il progresso e proclamarono che anche il patto sociale trovava un limite nel diritto umano al rispetto della persona. Forte strumento di emancipazione sociale e politica, debole invece sul piano gnoseologico, l’Illuminismo trovò un critico di valore in Gerdil, che ne confutò con decisione la tendenza materialistica. La materia non attinge l’universale, diceva Gerdil. L’anima lo conosce direttamente nella sua assolutezza. Ma quella prima essenza che essa conosce, non è altro che l’azione diretta di Dio sull’uomo. Questa azione è il vero fondamento della conoscenza. In questo modo, in pieno Settecento, il Platonismo saliva ancora in cattedra e mostrava il suo valore: l’idea separata era ciò a cui bisognava ricorrere per spiegare il nostro stesso pensiero. Ma insieme al suo valore il Platonismo portava con sé una seria difficoltà: il contatto diretto con Dio, oggetto immediato dell’intelletto, era questione spinosissima per una filosofia che volesse osservare i dettami del Cristianesimo rivelato. Fu il problema che si sarebbe trovato ad affrontare anche Rosmini.
Le dispute sull’intelletto, la natura matematica dell’universo, le tendenze materialistiche, l’innatismo e il sensismo, tutto sembrò rifluire in quel pensiero di prima grandezza rappresentato dal criticismo di Kant, di cui ai primi dell’Ottocento si ebbe notizia in Italia. Il più importante filosofo italiano di quel secolo, definito da Spaventa “il Kant italiano”, ne accolse l’istanza principale. Prima di considerare qualunque altra domanda filosofica, era necessario anzitutto rispondere a quella che chiedeva come fosse possibile la conoscenza; questo riteneva Rosmini in perfetto accordo con Kant. Ma la sua soluzione si discostava a tal punto da quella del filosofo di Koenigsberg, che mentre questi rinunciava a ogni metafisica dichiarandola impossibile, Rosmini fece della sua dottrina gnoseologica la base d’appoggio di una nuova ontologia. Punto di gravitazione di tutto il sistema era l’idea dell’essere, oggetto ideale assoluto il cui intuito era la potenza stesso del pensiero umano che da quel contatto traeva ogni forza e garanzia. Questa idea, rivendicata dal filosofo di Rovereto come antitetica ai concetti apriori del trascendentalismo che Rosmini riteneva psicologici e soggettivi, era il modello stesso con cui Dio aveva creato il mondo. Proprio perciò essa rappresentava il punto di contatto tra Dio, uomo e mondo. Proprio in quanto l’idea dell’essere era il fulcro del suo pensiero, essa costituì il bersaglio di due grandi polemiche, con Gioberti e con i Neotomisti, i quali ultimi ebbero nel Roveretano un avversario anche sul piano politico. Mentre in campo filosofico i Neotomisti italiani puntavano sulla riproposizione del pensiero di S. Tommaso, quasi scudo ideologico per la Chiesa, rimarcando una posizione difensiva di reazione alle vicende connesse con la rivoluzione dell’89 e con le idee anticlericali che l’avevano accompagnata; sul piano politico si scontravano con un Rosmini che concepiva riforma della Chiesa e riforma politica come strettamente connesse e sosteneva vivacemente il progetto dell’unificazione nazionale. La diatriba portò infine alla condanna di Rosmini e alla sua messa all’Indice, ma il suo pensiero attraversò il secolo incontrandosi, tra l’altro, con quello di Gentile, autore insieme a Croce della più importante rinascita filosofica del Novecento. Intanto, a pochi anni dalla morte di Rosmini, si sarebbe realizzata l’unità d’Italia che avrebbe inferto un colpo definitivo al potere secolare della Chiesa, problema che unì coscienze tra di loro molto distanti e che era destinato a lasciare un segno duraturo nella storia del Paese e della sua cultura.
Fonti e Bibl. essenziale
E. Garin, Storia della filosofia italiana, voll. I-III, Torino 1966; E. Garin, Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo, Roma-Bari 1975; B. Nardi, Dante e la cultura medievale, Roma-Bari 1985 2° ed; B. Nardi, Saggi di filosofia dantesca, Firenze 1967 2° ed; J. Hankins, Plato in the Italian Renaissance, Leiden 1990; C. Vasoli, Quid sit Deus. Studi su Marsilio Ficino, Lecce 1999; C. Vasoli, Filosofia e religione nella cultura del Rinascimento, Napoli 1988; Canone E., Il dorso e il grembo dell’eterno. Percorsi della filosofia di Giordano Bruno, Pisa 2003; G. Ernst, Il carcere, il politico, il profeta. Saggi su Tommaso Campanella, Pisa 2003; Enciclopedia bruniana e campanelliana, a cura di E. Canone e G. Ernst, vol. I Pisa-Roma 2006; vol. II Pisa-Roma 2010; G. Sasso, Niccolò Machiavelli, Bologna 1993, voll. 2, nuova edizione; G. Sasso, Machiavelli e gli antichi e altri saggi, Milano-Napoli 1987-88; G. Belgioioso, Cultura a Napoli e cartesianesimo. Scritti su G. Gimma, P. M. Doria, C. Corminale, Galatina 1992; G. De Liguori, La reazione a Cartesio nella Napoli del Seicento. Giovambattista De Benedictis, “Giornale critico della filosofia italiana”, a LXXVIII, 1996; Badaloni N., Introduzione a Vico, 2° ed. aggiornata Roma-Bari 1988; W. Rother, La maggiore felicità possibile. Untersuchungen zur Philosophie der Aufklärung in Nord- und Mittelitalien, Basel 2005; L. Malusa, Neotomismo e intransigentismo cattolico, 2 voll, Milano 1986-1989; P. Prini, Introduzione a Rosmini, Roma-Bari, 1997; AA.VV., Sulla ragione. Rosmini e la filosofia tedesca, a cura di M. Krienke, Soveria Mannelli 2008; M. Mustè, La scienza ideale. Filosofia e politica in Vincenzo Gioberti, Soveria Mannelli 2000.