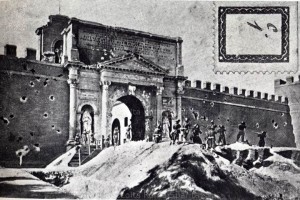Giurisdizionalismo dello Stato assoluto. L’assolutismo statale che caratterizza l’età moderna assume nei paesi cattolici i connotati di un potere monarchico sacrale, derivato direttamente da Dio (“re per grazia di Dio”), senza la mediazione della Chiesa e del papato. Diversi diritti in materia ecclesiastica che i sovrani medievali già esercitavano al fine della doverosa attuazione del Regno di Dio, nell’epoca moderna vengono considerati come poteri propri di ciascun sovrano, spettanti a chi è legittimato a governare il popolo in nome di Dio. Secondo questa visione, si riduce sempre più il potere della Chiesa sulla vita religiosa all’interno dello Stato, rivendicando come appartenente al potere temporale un sempre maggior numero di prerogative, prima invece riconosciute a chi deteneva il potere spirituale.
Anche sotto l’influenza di quanto avvenuto nei paesi passati al protestantesimo, i sovrani cattolici tendono a rivendicare per sé diritti sempre più ampi in materia ecclesiastica. Tra il XVI e il XVIII secolo si sviluppa ovunque un sistema politico-ecclesiastico che, con nomi differenti nei differenti paesi, afferma che la Chiesa, pur essendo una istituzione universale, in ciascuno Stato deve essere soggetta alla superiore autorità statale, la quale esercita sulla Chiesa determinati diritti, detti iura circa sacra.
Dal punto di vista politico ogni sovrano assoluto si ritiene indipendente da qualsiasi altro potere, mentre nei riguardi della religione il monarca si attribuisce il diritto e il dovere di tutelare la Chiesa; ma tale protezione tende spesso a trasformarla in instrumentum regni. I vescovi, in molti casi scelti proprio dal sovrano, di solito favoriscono l’intervento statale, anche perché ciò li aiuta a distanziarsi dal controllo del papa. Ma anche dove non vi un è un monarca assoluto, come nelle antiche Repubbliche italiane, nel rapporto con la Chiesa lo Stato cerca di orientarsi nello stesso modo.
Tale sistema viene diversamente denominato nei diversi paesi: gallicanesimo (in senso politico) in Francia e regalismo in Spagna e in Portogallo, là dove il forte potere monarchico, pur dichiarandosi devoto alla religione cattolica, in realtà ha il pieno controllo sulla vita ecclesiastica; giuseppinismo nell’Austria governata nel Settecento da Giuseppe II e negli altri paesi sotto la casa degli Asburgo-Lorena; febronianesimo in Germania, nome derivato da Febronio (pseudonimo del vescovo Nikolaus von Hontheim), autore del libro De statu ecclesiae (1763) in cui egli sostiene forti limiti al primato pontificio; giurisdizionalismo in vari Stati dell’Italia.
Durante il secolo XVIII, la S. Sede riscontra sempre più l’inefficacia dei tradizionali mezzi d’intervento verso gli stati: esortazioni, minacce e scomuniche non servono a cambiare l’indirizzo della politica statale verso la Chiesa. I numerosi concordati sottoscritti in quel secolo sono ormai il segno del diminuito prestigio del papato, perché essi concedono agli stati facoltà e spazi sempre più ampi a scapito dell’autorità ecclesiastica.
I diritti, mai riconosciuti dai pontefici, che lo Stato giurisdizionalista rivendica in campo ecclesiastico nell’Antico Regime, si possono riassumere come segue.
Per la difesa della Chiesa: ius advocatitiae o protectionis, con cui lo Stato protegge la Chiesa da eresie e scismi e quindi esclude i non cattolici dagli incarichi civili; ius reformandi, cioè diritto di imporre riforme per evitare abusi da parte della Chiesa, di ammettere o rifiutare nuove società religiose e di concedere o meno il culto privato o pubblico ai non cattolici.
Per difendere lo Stato dalle iniziative ecclesiastiche, lo ius cavendi si attua attraverso alcuni speciali istituti giuridici: placet ed exequatur, cioè l’assenso preventivo statale alla pubblicazione rispettivamente di atti pontifici o di autorità locali; e appellatio ab abusu, con cui clero e laici possono fare ricorso all’autorità statale contro gli atti ecclesiastici, che sono perciò annullabili dallo Stato. Vi sono inoltre altre prerogative con cui lo Stato si difende dall’azione della Chiesa: ius supremae inspectionis, cioè di limitare i rapporti tra gli enti ecclesiastici e la Sede romana, di controllare sinodi e missioni, di sopprimere gli enti considerati inutili, di controllare l’emissione delle professioni religiose e l’insegnamento in seminari e scuole ecclesiastiche, nonché l’acquisto e l’amministrazione dei beni della Chiesa; ius nominandi, cioè di presentare o nominare direttamente il candidato all’episcopato; ius exclusivae, diritto di veto o rifiuto del candidato sgradito; ius circa temporalia officia, che consente di sequestrare le rendite di uffici occupati da persone non gradite o incapaci; ius dominii eminentis, limitante il diritto di proprietà ecclesiastica, in modo da imporre imposte, distribuire diversamente le proprietà tra vari enti e appropriarsi dei frutti economici quando la sede è vacante; ius patronatus, diritto di nomina dei superiori di abbazie e conventi.
Stati italiani dell’Antico Regime. Stati Sabaudi. La dinastia dei Savoia fin dal Medio Evo è stata quasi sempre vicina all’autorità pontificia, ricevendo da essa numerosi privilegi e attribuendo spesso ad ecclesiastici importanti uffici nei propri Stati. Il più rilevante atto pontificio verso casa Savoia è l’indulto di Nicolò V del 1451: in cambio della rinuncia dell’antipapa Felice V (il duca Amedeo VIII), il papa concede che nei territori sabaudi si possa accedere alle più elevate cariche ecclesiastiche soltanto se ciò corrisponde alla volontà e al consenso espresso del duca di Savoia; nei secoli seguenti, l’interpretazione di quest’indulto sarà causa di forti tensioni tra Torino e Roma. Nel Cinquecento la dominazione francese sulle terre dei Savoia vi introduce gli usi gallicani, fra cui l’appel comme d’abus, cioè la possibilità di ricorrere ai tribunali statali contro provvedimenti ecclesiastici: Emanuele Filiberto, rientrato in possesso del suo territorio, conferma questo diritto a favore dello Stato. Gli usi gallicani rimarranno vivi in Valle d’Aosta fino al secolo XX.
Mentre si afferma l’uso del placet e dell’exequatur, nel Seicento la Chiesa cerca di contestare l’indulto di Niccolò V, accettandolo al massimo per la sola Savoia, ma senza ottenere cambiamenti significativi. Il re Vittorio Amedeo II conserva la legislazione spagnola per la Sardegna e cerca di estendere le prerogative statali in Piemonte. Soltanto a partire dal 1727 si riesce a trovare un accordo tra il papato e i Savoia: mentre altrove si afferma un giurisdizionalismo sempre più invasivo, da quell’anno fino all’invasione francese Stati Sabaudi e Chiesa instaurano fra loro un lungo rapporto di pacifica collaborazione (compreso l’arresto di Pietro Giannone), firmando in meno di settant’anni ben diciassette concordati. In Sardegna, già soggetta alla legislazione spagnola, i sovrani, in accordo con il papa, cercano di impedire l’abuso del regime di immunità dalla giurisdizione statale; Carlo Emanuele III vieta l’esecuzione degli ordini dell’Inquisizione spagnola e l’erezione di nuove case di religiosi e impone l’exequatur; ma tali misure vengono comunque attuate debolmente, evitando contrasti con Roma.
Repubblica di Genova. Fra gli Stati italiani, la Repubblica genovese è probabilmente quello che ha più facilmente gestito le relazioni con la Chiesa romana. Negli ultimi tre secoli della sua storia, lo Stato di Genova, che nel 1637 dichiara sua regina la Vergine Maria, generalmente senza difficoltà accoglie le iniziative dei pontefici e accetta al suo interno l’azione di vescovi e inquisitori. Nel Settecento Genova ottiene da Benedetto XIV la possibilità di tassare i beni del clero e di propria iniziativa proibisce la vendita e la locazione di immobili ad enti ecclesiastici, se non con il permesso degli organi statali. Unica occasione di conflitto, l’invio nel 1760, senza alcuna consultazione, di un visitatore apostolico da Roma nella Corsica genovese, già in piena ribellione: dura reazione del governo di Genova con conseguente arresto del prelato giunto in Corsica e lunga situazione di tensione tra la Repubblica e la Chiesa.
Milano. Dopo le tumultuose vicende dell’inizio del Cinquecento, con il passaggio dagli Sforza alla Francia e infine alla Spagna, Milano e il suo Ducato vedono instaurarsi un attento controllo statale sulla vita ecclesiastica, secondo l’orientamento generalmente attuato nei domini spagnoli. Carlo V decide nel 1540 di sottoporre a gravame i beni acquistati dal clero e vieta la vendita di immobili agli enti ecclesiastici. Con s. Carlo Borromeo come arcivescovo metropolita inizia un periodo in cui si applica efficacemente la riforma tridentina ma anche cominciano i contrasti con i governatori spagnoli: le autorità civili vedono infatti minacciata la giurisdizione statale dalle misure con cui il vescovo attua il suo programma di totale disciplinamento della società. Nel 1569 il governatore Albuquerque emana un editto per tutelare la giurisdizione dello Stato: seguono le scomuniche dei governatori che in poco tempo si succedono fino all’intervento di Filippo II re di Spagna, che infine accetta le richieste di s. Carlo. Con l’arcivescovo Federico Borromeo le tensioni continuano fino alla stipulazione di una “concordia giurisdizionale” nel 1615: è così possibile far convenire i laici presso il tribunale ecclesiastico, facendo eseguire le sentenze non solo dal braccio secolare ma anche dalle guardie dell’autorità episcopale.
Nel Settecento, terminato il dominio spagnolo, anche nella Lombardia austriaca si applica la riforma realizzata nell’Impero da Maria Teresa e da Giuseppe II. Un concordato con la S. Sede per il Ducato di Milano viene stipulato nel 1757. Alcune nuove norme speciali per Milano riguardano ancora il divieto di vendita di beni immobili a enti ecclesiastici, la cui dispensa viene ora riservata al sovrano, la censura dei libri ora sottratta all’Inquisizione romana, un più ampio uso dello strumento dell’exequatur. Decreti di Giuseppe II, confermati dal concordato del 1784, allargano la necessità del placet e soprattutto attribuiscono all’imperatore la nomina dei vescovi delle diocesi lombarde.
Valtellina sotto i Grigioni. Un’esperienza storica unica in Italia è quella della Valtellina e della Valchiavenna, dal 1512 sono sotto il dominio dei Grigioni, cioè della Repubblica delle Tre Leghe; tale dominio continua fino al 1797, quando i territori passano alla nuova Repubblica Cisalpina. Il governo dei Grigioni, la cui popolazione già nel Cinquecento è a maggioranza protestante, attua una forma di tolleranza religiosa che tuttavia non riesce ad evitare forti conflitti. La cattolica Valtellina è da molti secoli territorio della diocesi di Como, legata al patriarcato di Aquileia; ma i vescovi non possono svolgervi la visita pastorale fino al 1615, escluse tre eccezioni. Nel 1557 l’editto di Ilanz concede chiese cattoliche al culto protestante.
Dopo la tortura e l’uccisione dell’arciprete cattolico Nicolò Rusca, nel 1620 scoppia una ribellione guidata da nobili cattolici, sotto l’impulso della Spagna: i valtellinesi uccidono 400 protestanti nel cosiddetto “Sacro macello”. Dopo quasi vent’anni di guerra, pestilenze, uccisioni di streghe e l’intervento del papa, della Spagna e della Francia, nel 1639 il capitolato di Milano restituisce Valtellina e Valchiavenna ai Grigioni, ma vi ammette soltanto la confessione cattolica e vi proibisce la residenza stabile dei protestanti.
Repubblica di Venezia. La Repubblica Veneta attua costantemente per diversi secoli una politica di controllo della Chiesa e di limitazione della sua influenza; a questo scopo si costituisce il collegio dei Consultori in iure, teologi e canonisti di cui il governo richiede la consulenza. Il diritto ecclesiastico veneto risulta quindi particolarmente stabile e privo di grandi modificazioni nel corso dei secoli, fino alla caduta della Repubblica nel 1797. Per motivi di commercio, Venezia tollera la presenza di appartenti ad altre confessioni religiose, riconoscendo loro una limitata libertà di culto.
Quanto alle persone ecclesiastiche, già nel secolo XV esse sono escluse da qualsiasi incarico pubblico; mentre con una serie di leggi si vieta di ricevere dignità e benefici ecclesiastici ai familiari del doge, ai membri del governo veneziano, agli ambasciatori e ai loro rispettivi congiunti. La Serenissima Repubblica non concede alcun favore ai diversi pontefici di origine veneziana; anzi, dopo alcuni problemi con Gregorio XII, nel 1411 stabilisce che i “papalisti”, cioè i parenti dei membri della curia pontificia, siano espulsi dalle sedute degli organi costituzionali, allorché essi trattano materie ecclesiastiche e deliberano su di esse. Il divieto viene confermato ed esteso con altre leggi successive; inoltre i papalisti possono partecipare ai vari consigli solo in numero limitato e vengono esclusi per legge da alcuni incarichi pubblici, come dal 1574 quello di Savio all’Eresia.
Lo Stato veneto non riconosce in linea di principio privilegi di giurisdizione agli ecclesiastici, concedendo solo che ai processi contro di essi debba assistere il vicario del patriarca di Venezia. Il tribunale dell’Inquisizione può agire solo contro i cattolici e con il permesso dell’autorità statale, la quale controlla ogni seduta e vigila contro gli abusi per mezzo di tre magistrati statali: tre senatori detti Savi all’Eresia. Altre norme stabiliscono criteri severi per limitare l’attribuzione a vario titolo di proprietà di immobili agli enti ecclesiastici e per impedire la questua per indulgenze, se non con autorizzazione del governo. Un magistrato dello Stato, il Revisore dei Brevi, è addetto al controllo degli atti pontifici, che sono considerati inefficaci senza il placet governativo. Per diverse sedi vescovili, il governo si considera detentore del diritto di nomina del vescovo o almeno di proporre una terna di nomi.
Un periodo di speciale tensione fra Stato veneto e Chiesa è quello legato alla questione dell’interdetto: nel 1606 due sacerdoti, colpevoli di delitti comuni, secondo la legge veneta vengono arrestati e sottoposti al giudizio del tribunale statale. Il papa Paolo V chiede l’abolizione della norma che prevede tale disciplina, insieme al divieto di costruire chiese senza il permesso del governo. La Repubblica, guidata dal doge Leonardo Donà e influenzata dalle idee di Paolo Sarpi, frate servita e consultore in iure, rifiuta la richiesta pontificia: il papa risponde con la scomunica, l’interdetto e l’annullamento di propria autorità delle leggi contestate. I religiosi che, in obbedienza al pontefice, si rifiutano di celebrare e amministrare i sacramenti, vengono espulsi dallo Stato; ciò vale soprattutto per i Gesuiti, che potranno tornare solo dopo cinquant’anni, a seguito degli accordi con cui il papa favorirà Venezia nella guerra di Candia contro i Turchi. La controversia dell’interdetto si risolve nel 1607 soltanto grazie alla mediazione del re di Francia, senza che la Repubblica abbia rinunciato a far valere le proprie ragioni.
Altri motivi di tensione si hanno nel Settecento. Nel 1751, in seguito alle pressioni di Maria Teresa d’Austria, Benedetto XIV sopprime il patriarcato di Aquileia e attribuisce i suoi territori austriaci alla nuova arcidiocesi di Gorizia: ne deriva una difficile vertenza con ritorsioni tra Venezia e Roma, terminata solo nel 1758 con l’elezione del papa veneziano Clemente XIII.
Nel 1766 si istituisce la Deputazione ad pias causas, organo statale che interviene nell’organizzazione ecclesiastica, in particolare negli Ordini religiosi: forti limitazioni all’ingresso di nuovi candidati, soppressione dei conventi con meno di dodici religiosi o privi di rendite sufficienti per mantenerli, obbedienza solo a superiori che non risiedano fuori dello Stato. Questa politica provoca una rapida diminuzione del clero regolare, quasi dimezzato già nel 1790.
Ducati di Parma e di Modena. Nel Ducato di Parma e Piacenza il tradizionale favore verso l’autorità ecclesiastica che caratterizzava la dinastia dei Farnese si trasforma in politica giurisdizionalista sotto il governo dei Borboni. Guillaume du Tillot, dal 1759 primo ministro del duca Filippo di Borbone, realizza un piano di limitazione dei privilegi e dei diritti della Chiesa: fra l’altro, impedisce le ingerenze dei vescovi e la fondazione di nuovi conventi, e sottopone i provvedimenti ecclesiastici all’exequatur. Dopo la censura romana, il ministro espelle i Gesuiti e sopprime l’Inquisizione; ma tale politica termina nel 1771 con la deposizione di Guillaume du Tillot da parte dei duchi Ferdinando e Maria Amalia.
Anche nel Ducato di Modena e Reggio il duca Francesco III d’Este interviene energicamente in campo ecclesiastico: nel 1757 egli istituisce un Magistrato per difendere la giurisdizione statale; poi, suscitando le vane proteste di Roma, negli anni seguenti limita l’attribuzione di beni agli ecclesiastici che sottopone anche a tassazione, sopprime conventi e riduce notevolmente il potere del S. Uffizio. Il successore Ercole III regola nel dettaglio le celebrazioni liturgiche e ne disciplina il fasto.
Repubblica di Lucca. Ufficialmente legata alla tradizione cattolica, Lucca si mantiene tuttavia piuttosto indipendente rispetto alle direttive della S. Sede. Nel Cinquecento, quando si diffondono a Lucca le idee della Riforma protestante, lo Stato lucchese, anche se non le favorisce, respinge tuttavia le richieste di intervento che giungono da Roma. Il governo non accetta mai di introdurre l’Inquisizione romana nel proprio Stato e continua ad affidare la repressione dell’eresia al vescovo locale e dal 1545 ad una magistratura statale appositamente istituita, l’Offizio sopra la Religione, mentre diversi cittadini scelgono l’esilio per aderire liberamente al protestantesimo fuori d’Italia. Per impedire intromissioni della Sede romana si crea nel 1562 l’Offizio sopra la Giurisdizione, con competenze sempre più ampie fino al Settecento. Nel 1605 gravi tensioni tra il governo e il vescovo Guidiccioni portano Paolo V a chiedere ancora l’introduzione del S. Uffizio, ma senza significativi risultati. È caratteristico anche il costante rifiuto di Lucca ad accettare la presenza della Compagnia di Gesù.
Toscana. Già nel Quattrocento Firenze aveva realizzato una legislazione molto favorevole alle richieste della Chiesa: orientamento confermato dalla dinastia dei Medici, che vede alcuni suoi membri al vertice della Chiesa, anzitutto il papa Leone X. Per trattare gli affari ecclesiastici, i Medici stabiliscono un apposito ufficio, detto Segreteria del Regio diritto. Se il granduca Cosimo I riesce ad esercitare una certa influenza, arrivando fino alla parziale tassazione del clero, i suoi successori sono più deboli e lasciano spazio all’intervento ecclesiastico, compresa l’istituzione della nunziatura apostolica di Firenze con un’ampia giurisdizione concorrente con quella statale. Il clero possiede gran parte delle proprietà immobiliari nel Granducato.
Con il passaggio della Toscana agli Asburgo-Lorena nel 1737, cambia la politica ecclesiastica. Tra il 1765 e il 1790 il granduca Pietro Leopoldo, come il fratello Giuseppe II nell’Impero, attua una serie di misure che mirano non solo ad affermare i diritti dello Stato, ma anche a riformare la Chiesa. Abolisce il tribunale della nunziatura e quello dell’Inquisizione, il diritto di asilo, il privilegio del foro e l’immunità per i beni ecclesastici; impone exequatur e placet e limita radicalmente la c.d. manomorta. Collaborando con Scipione de‘ Ricci, vescovo di Pistoia, Pietro Leopoldo porta al culmine il giurisdizionalismo cercando di sottrarre la vita della Chiesa al controllo dell’autorità pontificia, considerata straniera. Sono colpiti soprattutto gli Ordini religiosi, con soppressioni di conventi e con la sottomissione delle comunità residue alla giurisdizione del vescovo locale, facilmente controllato dallo Stato. Il culto viene regolato in modo rigoroso, secondo la tendenza giansenista. La Chiesa viene subordinata allo Stato.
L’evento più importante della politica leopoldina è il sinodo diocesano di Pistoia del 1786, presieduto dal Ricci e animato dal canonista Pietro Tamburini: secondo la volontà del granduca e in conformità alle idee gianseniste-febroniane, come anche a quelle del richerismo che esalta il ruolo dei parroci, tale assemblea dovrebbe preparare un’assemblea nazionale dei vescovi toscani; il progetto cade per la reazione negativa dei vescovi e poi per la partenza del granduca, divenuto imperatore e trasferitosi a Vienna. Pio VI condanna 85 proposizioni estratte dal sinodo pistoiese con la bolla Auctorem fidei del 1794: è la fine del giansenismo politico e disciplinare.
Napoli e Sicilia. All’antica dominazione dei Normanni risalgono due fatti che hanno conseguenze fino all’Ottocento. Il primo è l’investitura pontificia dei re di Sicilia e Napoli, i quali, come vassalli, debbono perciò pagare ogni anno un tributo al papa. A tale somma gli Angiò hanno poi aggiunto l’omaggio di un cavallo bianco, detto “chinea”. In età moderna, diversi sovrani cercano con difficoltà di liberarsi di questi obblighi, ritenuti ingiusti e umilianti: solo con Ferdinando II delle Due Sicilie, la S. Sede rinuncia al tributo e alla chinea (già in disuso) in cambio di un’offerta di denaro.
Il secondo fatto è il conferimento della Legazia Apostolica ai sovrani di Sicilia. Il re ha il titolo di legato del pontefice nel proprio Stato, quindi può impedire l’invio da Roma di qualsiasi altro legato: è giudice ecclesiastico in ultima istanza, può assolvere dalle censure e rilasciare dispense matrimoniali, e impedisce qualsiasi appello a Roma da parte dei sudditi. Questa prerogativa prende il nome di Monarchia Sicula e i sovrani esercitano le loro numerose facoltà in campo ecclesiastico mediante il magistrato detto Giudice della Monarchia. I pontefici tentano più volte di revocare la Legazia provocando la resistenza dei sovrani: solo nel 1871, dopo la caduta del Regno delle Due Sicilie, si ha la definitiva rinuncia di Vittorio Emanuele II re d’Italia.
Durante il dominio spagnolo, lo Stato applica in Italia meridionale exequatur e placet, come pure accetta i ricorsi in materia ecclesiastica; tuttavia esercita debolmente tali diritti. Nel Settecento Vittorio Amedeo II di Savoia in Sicilia e gli Austriaci a Napoli si oppongono per anni alle pretese di Roma; ma con i Borboni si arriva presto alla firma del concordato del 1741. Nei decenni seguenti, sotto Carlo III e Ferdinando IV di Borbone, il ministro Bernardo Tanucci, ispirandosi alle idee di Pietro Giannone, conduce una politica giurisdizionalistica simile a quella delle altre monarchie borboniche: abolizione del S. Uffizio, autorizzazione statale richiesta alle associazioni religiose, abolizione del foro ecclesiastico. Espulsi i Gesuiti nel 1767, Clemente XIII reagisce con la scomunica; ma Tanucci fa occupare le città pontificie di Benevento e Pontecorvo, restituite al pontefice solo dopo la soppressione della Compagnia di Gesù.
Periodo napoleonico. Negli ultimi anni del Settecento, la Francia del Direttorio invade quasi tutti gli Stati italiani, sotto la guida di Napoleone Bonaparte; si estinguono antichi Stati e nascono nuove Repubbliche, tutte legate alla Francia: Cispadana e Transpadana (1796), che formano poi la Cisalpina, Ligure (1797), Romana (1798) e Partenopea (1799). La loro politica ecclesiastica non segue sempre il regime di radicale separazione tra Stato e Chiesa, proprio della Francia di quegli anni; anzi alcune di quelle nuove costituzioni dichiarano che il cattolicesimo è la religione della Repubblica, che se ne serve come uno strumento statale. Altre invece sono più fedeli al modello francese: separazione, ma sotto il controllo dello Stato. La successiva Repubblica Italiana, presieduta da Bonaparte, istituisce nel 1802 un nuovo Ministero per il Culto, affidato a Giovanni Bovara, e nel 1803 conclude con Pio VII un concordato che riconosce il cattolicesimo come religione dello Stato, ma attribuisce al governo la nomina dei vescovi, e impone il giuramento di fedeltà del clero. Mentre una notevole parte d’Italia entra nel nuovo Impero francese, il napoleonico Regno d’Italia eredita il concordato, più volte violato a danno della Chiesa: introdotto il codice civile che comprende il divorzio, imposto il catechismo imperiale, soppressi totalmente gli Ordini religiosi nel 1810.
Da Napoleone all’unificazione italiana. La restaurazione, attuata in base alle decisioni del congresso di Vienna, riporta in vigore i rapporti tra Chiesa e Stati secondo lo stile pre-napoleonico. Gli Ordini religiosi riescono con molte difficoltà a ricostituire solo alcune comunità, quasi mai negli spazi occupati prima delle soppressioni napoleoniche. Il Regno Lombardo-Veneto, soggetto all’Austria, continua il giuseppinismo fino al concordato tra Austria e S. Sede del 1855, che invece riconosce ampi diritti alla Chiesa e pone fine alla disciplina iniziata da Giuseppe II. Anche il Granducato di Toscana mantiene la precedente legislazione leopoldina, non toccata neppure dal concordato ottenuto da Leopoldo II nel 1851: esso conserva il controllo statale sui documenti pontifici ma garantisce la libertà delle diocesi; l’anno dopo la scuola assume carattere confessionale.
Il Regno delle Due Sicilie vede Ferdinando I di Borbone ripristinare subito il placet e concludere un concordato nel 1818: con esso la Chiesa rinuncia ai beni già venduti e viene mantenuto il foro ecclesiastico, mentre il re ottiene il diritto di nominare i vescovi, che devono anche giurargli fedeltà. Nelle scuole l’insegnamento deve conformarsi alla dottrina cattolica, mentre lo Stato contribuisce alle necessità economiche della Chiesa.
Il sabaudo Regno di Sardegna in una prima fase favorisce concretamente la S. Sede, che nel concordato del 1817 lascia al re la nomina dei vescovi. Lo statuto di Carlo Alberto del 1848 riconosce il cattolicesimo come sola religione dello Stato, ma garantisce la tolleranza degli altri culti. Gli anni seguenti portano però ad una netta svolta anticlericale, che tende al separatismo fra Chiesa e Stato, spesso in termini di vera ostilità: già nel 1848 si sopprime la Compagnia di Gesù poi, dopo le leggi Siccardi del 1850 che aboliscono il foro ecclesiastico e il diritto d’asilo e limitano gli acquisti degli enti ecclesiastici, viene incarcerato l’arcivescovo Fransoni di Torino e l’arcivescovo Marongiu Nurra di Cagliari è costretto all’esilio.
Durante il governo di Cavour, la legge Rattazzi del 1855 sopprime nuovamente i conventi e toglie la personalità giuridica agli Ordini religiosi, i cui patrimoni vengono incamerati dallo Stato. In seguito a tali scelte legislative, il papa b. Pio IX interrompe le relazioni diplomatiche. Ma ancora nel 1859, un’altra legge, non votata a causa dei poteri di guerra, attribuisce al Consiglio di Stato il controllo statale sugli atti ecclesiastici e il giudizio sui ricorsi contro di essi.
Fonti e Bibl. essenziale
M. Roberti, La legislazione ecclesiastica nel periodo napoleonico, in AA.VV., Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l’Italia, vol. I, Vita e Pensiero, Milano 1939, 253-332; A.C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Einaudi, Torino 1963; P. Chiocchetta (ed.), Dizionario storico religioso, Studium, Roma 1966; F. Ruffini, Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici, a cura di F. Margiotta Broglio, Il Mulino, Bologna 1974; G. Pilati, Chiesa e Stato nell’epoca moderna: profilo dello sviluppo della teoria attraverso le fonti e la bibliografia, Coletti, Roma 1977; F. Venturi, Settecento riformatore, Einaudi, Torino 1984-1991; G. Gullino, Il giurisdizionalismo dello stato veneziano: gli antichi problemi e la nuova cultura, in B. Bertoli (ed.), La Chiesa di Venezia nel Settecento, Studium Cattolico Veneziano, Venezia 1993, 23-38; G. Martina, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, vol. II-III, Morcelliana, Brescia 1994; C. Marongiu Buonaiuti, Chiese e Stati. Dall’età dell’Illuminismo alla Prima guerra mondiale, Carocci, Roma 1998; M. Rosa, Settecento religioso. Politica della religione e religione del cuore, Marsilio, Venezia 1999; C. Zaghi, Napoleone e l’Italia, La Città del Sole, Napoli 2001; I. Pederzani, Un ministero per il culto. Giovanni Bovara e la riforma della Chiesa in età napoleonica, Franco Angeli, Milano 2002; L. Mezzadri – P. Vismara, La Chiesa tra Rinascimento e Illuminismo, Città Nuova, Roma 2006; G. Greco – M. Rosa, Storia degli antichi stati italiani, Laterza, Bari-Roma 2009; M. Meriggi, Gli Stati italiani prima dell’Unità. Una storia istituzionale, Il Mulino, Bologna 2011; G. Scaramellini, voce Valtellina in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 03/07/2013, URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I7135.php.
LEMMARIO
- Accrocca Felice
- Amarante Alfonso
- Ambiente – vol. II
- Anticlericalismo – vol. I
- Anticlericalismo – vol. II
- Antigesuitismo – vol. I
- Antigesuitismo – vol. II
- Apologetica – vol. I
- Apologetica – vol. II
- Apruzzese Sergio
- Archeologia – vol. I
- Archeologia – vol. II
- Architettura – vol. I
- Architettura – vol. II
- Archivi ecclesiastici – vol. I
- Archivi ecclesiastici – vol. II
- Archivi militari – vol. II
- Arianesimo – vol. I
- Arte cristiana – vol. I
- Arte cristiana – vol. II
- Assemblea Costituente – vol. II
- Assistenza – vol. I
- Assistenza – vol. II
- Associazionismo cattolico – vol. II
- Ateismo – vol. I
- Azione Cattolica – vol. II
- Barbari – vol. I
- Barbierato Federico
- Barocco – vol. I
- Battelli Giuseppe
- Belluomini Flavio
- Benedetti Marina
- Beneficio ecclesiastico – vol. I
- Besostri Fabio
- Bibbia – vol. I
- Bibbia – vol. II
- Biblioteche – vol. I
- Biblioteche – vol. II
- Boaga Emanuele †
- Bocci Maria
- Bonini Francesco
- Bonora Elena
- Brancatelli Stefano
- Brywczynski Michal
- Bua Pasquale
- Buffon Giuseppe
- Cabizzosu Tonino
- Calabrese Gianfranco
- Canonici Regolari – vol. I
- Capitoli cattedrali, Collegiate – vol. I
- Cargnello Giulio
- Cassiani Gennaro
- Castelli Emanuele
- Castelli Francesco
- Casuistica – vol. I
- Catari – vol. I
- Catechesi, Catechismi – vol. I
- Catechesi, Catechismi – vol. II
- Cattolicesimo intransigente – vol. I
- Cattolicesimo intransigente – vol. II
- Cattolicesimo liberale – vol. I
- Cattolicesimo liberale – vol. II
- Cattolicesimo politico – vol. II
- Cattolici del dissenso – vol. II
- Cattolici di rito orientale – vol. II
- Cavallotto Stefano
- Cazzulani Guglielmo
- Censura ecclesiastica – vol. I
- Censura ecclesiastica – vol. II
- Centri culturali – vol. II
- Chierici Regolari – vol. I
- Chiese Ortodosse – vol. I
- Chiese Ortodosse – vol. II
- Ciampani Andrea
- Cipollini Francesco
- Ciriello Caterina
- Cito Davide
- Civiero Tiziano
- Clero secolare – vol. I
- Clero secolare – vol. II
- Coco Giovanni
- Collegi – vol. I
- Colonialismo – vol. II
- Colzani Gianni
- Comunismo – vol. II
- Concili ecumenici – vol. I
- Concili, Sinodi – vol. I
- Concili, Sinodi – vol. II
- Concilio di Trento – vol. I
- Concilio Vaticano I – vol. II
- Concilio Vaticano II – vol. II
- Concilio Vaticano II, Recezione – vol. II
- Concordati – vol. I
- Concordati – vol. II
- Conferenza Episcopale Italiana – vol. II
- Conferenze Episcopali Regionali – vol. II
- Confessione, Penitenza – vol. I
- Confessione, Penitenza – vol. II
- Confraternite laicali – vol. I
- Confraternite laicali – vol. II
- Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari – vol. II
- Congregazione dei Vescovi e Regolari – vol. I
- Congregazione del Sant’Uffizio – vol. I
- Congregazione del Sant’Uffizio – vol. II
- Congregazione dell’Indice – vol. II
- Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica – vol. II
- Congregazione per i Vescovi – vol. II
- Congregazione per il Clero – vol. II
- Congregazioni religiose femminili – vol. I
- Congregazioni religiose femminili – vol. II
- Congregazioni religiose maschili – vol. I
- Congregazioni religiose maschili – vol. II
- Congressi eucaristici – vol. II
- Conservatori – vol. I
- Conversioni – vol. I
- Conversioni – vol. II
- Costanzo Alessandra
- Credo – vol. I
- Crociate – vol. I
- Culto e devozioni – vol. I
- Culto e devozioni – vol. II
- De Giorgi Fulvio
- De Palma Luigi Michele
- Dell’Omo Mariano
- Democrazia – vol. II
- Democrazia Cristiana – vol. II
- Di Carpegna Falconieri Tommaso
- Di Girolamo Luca
- Diaconato – vol. I
- Diaconato – vol. II
- Dibisceglia Angelo Giuseppe
- Dieguez Alejandro M.
- Diocesi – vol. II
- Diritti umani – vol. II
- Diritto Canonico – vol. I
- Diritto Canonico – vol. II
- Dohna Schlobitten Yvonne
- Donato Maria Pia
- Donna – vol. II
- Ebrei – vol. I
- Ebrei – vol. II
- Ecclesiologia – vol. I
- Ecclesiologia – vol. II
- Ecumenismo – vol. I
- Ecumenismo – vol. II
- Editoria – vol. I
- Editoria – vol. II
- Educazione – vol. I
- Educazione – vol. II
- Emigrazione, Immigrazione – vol. I
- Emigrazione, Immigrazione – vol. II
- Episcopato – vol. I
- Episcopato – vol. II
- Eremitismo – vol. I
- Eremitismo – vol. II
- Ernesti Jörg
- Eterodossia, Eresia – vol. I
- Etica economica – vol. II
- Europa – vol. I
- Europa – vol. II
- Evangelizzazione – vol. I
- Evangelizzazione – vol. II
- Falzone Maria Teresa †
- Famiglia – vol. I
- Famiglia – vol. II
- Fantappiè Carlo
- Fascismo (1919-1931) – vol. II
- Feliciani Giorgio
- Ferri Giacomo
- Feudalità ecclesiastica – vol. I
- Filosofia – vol. I
- Filosofia – vol. II
- Finanze ecclesiastiche – vol. II
- Foa Anna
- Folclore – vol. I
- Folclore – vol. II
- Formigoni Guido
- Fosi Irene
- Fragnito Gigliola
- Fumetto – vol. II
- Fusar Imperatore Paolo
- Galleni Ludovico
- Gallo Federico
- Garbellotti Marina
- Geografia ecclesiastica, Diocesi – vol. II
- Giaccardi Chiara
- Giansenismo – vol. I
- Giornali, Riviste cattoliche – vol. I
- Giornali, Riviste cattoliche – vol. II
- Giornalismo – vol. II
- Giurisdizionalismo – vol. I
- Giuspatronato – vol. I
- Giustizia ecclesiastica – vol. II
- Gorla Stefano
- Grande Scisma – vol. I
- Greco Gaetano
- Gregorini Giovanni
- Grignani Mario L.
- Grossi Roberta
- Guasco Alberto
- Guasco Maurilio
- Guelfismo, Ghibellinismo – vol. I
- Illuminismo, Aufklärung cattolica – vol. I
- Industrializzazione – vol. II
- Inquisizione (età medievale) – vol. I
- Inquisizione (età moderna) – vol. I
- Islam – vol. I
- Islam – vol. II
- Istituti di scienze religiose – vol. II
- Istituti secolari – vol. II
- L’Università Cattolica del Sacro Cuore – vol. II
- La Rosa Luigi
- Laicità, Laicismo – vol. I
- Laicità, Laicismo – vol. II
- Laico, Laicato – vol. I
- Laico, Laicato – vol. II
- Lameri Angelo
- Landi Fiorenzo
- Lanfranchi Rachele
- Lentini Giuseppe
- Liberalismo – vol. I
- Liberalismo – vol. II
- Libertà religiosa – vol. II
- Libertinismo – vol. I
- Liccardo Giovanni
- Liturgia (dal I al VIII secolo) – vol. I
- Liturgia (dall’ VIII al XIX secolo) – vol. I
- Liturgia – vol. II
- Lombardi Daniela
- Loparco Grazia
- Lotta per le investiture – vol. I
- Lovison Filippo
- Maggioni Corrado
- Magia e stregoneria – Vol. I
- Majorana Bernadette
- Majorano Sabatino
- Malgeri Giampaolo
- Mancini Lorenzo
- Mancini Massimo
- Manfredi Angelo
- Maria Santissima – vol. I
- Maria Santissima – vol. II
- Mass-media – vol. II
- Massoneria – vol. I
- Massoneria – vol. II
- Mastantuono Antonio
- Medicina – vol. I
- Menniti Ippolito Antonio †
- Migranti – vol. II
- Millenarismo – vol. I
- Millenarismo – vol. II
- Miniatura – vol. I
- Missioni estere – vol. I
- Missioni estere – vol. II
- Missioni interne – vol. I
- Missioni interne – vol. II
- Modernismo – vol. II
- Modernità – vol. II
- Mondo Monica
- Monetazione papale tra XV e XVI secolo. La Zecca di Roma – vol. I
- Monti di Pietà – vol. I
- Morale – vol. I
- Morale – vol. II
- Morandini Simone
- Movimenti ecclesiali – vol. II
- Mutegeki Robert
- Muzzarelli Maria Giuseppina
- Neoguelfismo – vol. I
- Nunziatura – vol. II
- Nunziature – vol. I
- Nuove comunità – vol. II
- Oratori – vol. II
- Oratori e Compagnie – vol. I
- Ordini mendicanti – vol. I
- Ordini mendicanti – vol. II
- Ordini militari – vol. I
- Ordini militari – vol. II
- Ordini monastici – vol. II
- Ordini monastici femminili – vol. I
- Ordini monastici maschili – vol. I
- Ospedali – vol. I
- Ospedali – vol. II
- Padovan Gianluca
- Paganesimo – vol. I
- Paganesimo – vol. II
- Parrocchie – vol. I
- Parrocchie – vol. II
- Partito Popolare – vol. II
- Pataria – vol. I
- Patria, Nazione – vol. I
- Patria, Nazione – vol. II
- Pavone Sabina
- Pelaja Margherita
- Pellegrinaggio – vol. I
- Pellegrinaggio – vol. II
- Pereira Sergio
- Persecuzioni – vol. I
- Persecuzioni – vol. II
- Picardi Paola
- Pietà – vol. II
- Pietà illuminata – vol. I
- Pietroforte Stefania
- Pieve – vol. I
- Pinna Diego
- Pioppi Carlo
- Pittura – vol. I
- Pittura, Scultura – vol. II
- Pizzorusso Giovanni
- Poli Paolo
- Predicazione – vol. I
- Predicazione – vol. II
- Prelatura personale – vol. II
- Prima Guerra Mondiale – vol. II
- Probabilismo – vol. I
- Proprietà ecclesiastica – vol. I
- Proprietà ecclesiastica – vol. II
- Protestantesimo – vol. I
- Protestantesimo – vol. II
- Questione meridionale – vol. II
- Questione romana – vol. II
- Questione sociale – vol. II
- Quietismo – vol. I
- Regoli Roberto
- Religiosità popolare – vol. II
- Reliquie – vol. I
- Reliquie – vol. II
- Resistenza – vol. II
- Riforma cattolica, Controriforma – vol. I
- Riforma gregoriana – vol. I
- Riforma protestante – vol. I
- Rinascimento – vol. I
- Rinascimento carolingio – vol. I
- Rivoluzione francese – vol. I
- Rizzi Giovanni
- Rocca Giancarlo
- Rocciolo Domenico
- Roma, Romanità – vol. I
- Roma, Romanità – vol. II
- Romanato Gianpaolo
- Romanticismo cattolico – vol. I
- Rosa Mario
- Rosminianesimo – vol. I
- Rurale Flavio
- Rusconi Roberto
- Sacro romano impero – vol. I
- Sanfilippo Matteo
- Santità – vol. II
- Santuari – vol. I
- Santuari – vol. II
- Satira – vol. I
- Satire: temi, espressioni, condanne – vol. I
- Saverio Venuto Francesco
- Savigni Raffaele
- Scatena Silvia
- Scienza – vol. I
- Scienza, medicina, biologia – vol. II
- Scismi – vol. II
- Scultura – vol. I
- Scuola – vol. I
- Scuola – vol. II
- Segreteria di Stato – vol. II
- Seminari – vol. I
- Seminari – vol. II
- Sessantotto – vol. II
- Sessualità – vol. I
- Silva Cesare
- Sindacati – vol. II
- Siniscalco Paolo
- Socialismo – vol. II
- Sodi Stefano
- Soler Jaume
- Soppressioni – vol. I
- Soppressioni – vol. II
- Soppressioni, Beni culturali – vol. I
- Soppressioni, Beni culturali – vol. II
- Sostentamento del clero – vol. II
- Spiriti Andrea
- Spiritualità – vol. I
- Spiritualità – vol. II
- Sport – vol. II
- Sportelli Francesco
- Stati preunitari – vol. I
- Stato – vol. II
- Stato della Città del Vaticano – vol. II
- Storia della Pietà (Giuseppe de Luca) – vol. II
- Storiografia (età antica) – vol. I
- Storiografia (età contemporanea) – vol. II
- Storiografia (età medievale) – vol. I
- Storiografia (età moderna) – vol. I
- Tanner Norman
- Tanzarella Sergio
- Teatro – vol. I
- Teatro – vol. II
- Teologia – vol. I
- Teologia – vol. II
- Terrorismo – vol. II
- Terz’ordini – vol. I
- Tessaglia Stefano
- Tolleranza – vol. I
- Tomassoni Roberto
- Tosti Mario
- Tradizionalismo – vol. II
- Trampus Antonio
- Tribunali della Curia romana – vol. I
- Tuninetti Giuseppe
- Turchini Angelo
- Università – vol. I
- Valdesi – vol. I
- Valeri Elena
- Valli Norberto
- Valtellina: Riforma/Riforme – vol. I
- Valvo Paolo
- Vecchio Giorgio
- Venturi Giampaolo
- Visite ad limina – vol. I
- Visite ad limina – vol. II
- Visite apostoliche – vol. I
- Visite apostoliche – vol. II
- Visite pastorali – vol. I
- Visite pastorali – vol. II
- Vitali Dario
- Von Teuffenbach Alexandra
- Web – vol. II
- Xeres Saverio
- Zamboni Lorenzo
- Zingari, Nomadi – vol. I
- Zingari, Nomadi – vol. II
- Zovatto Pietro