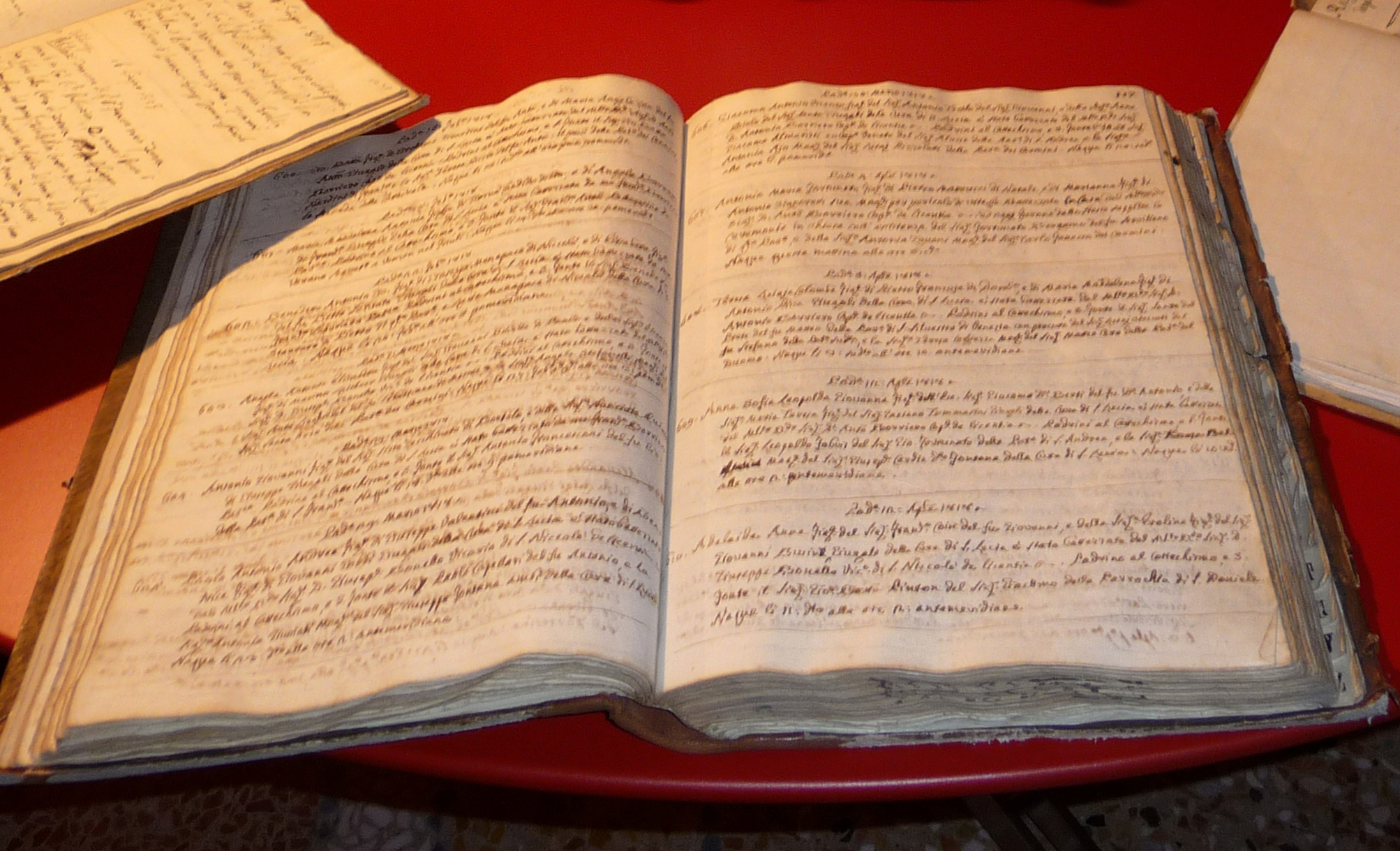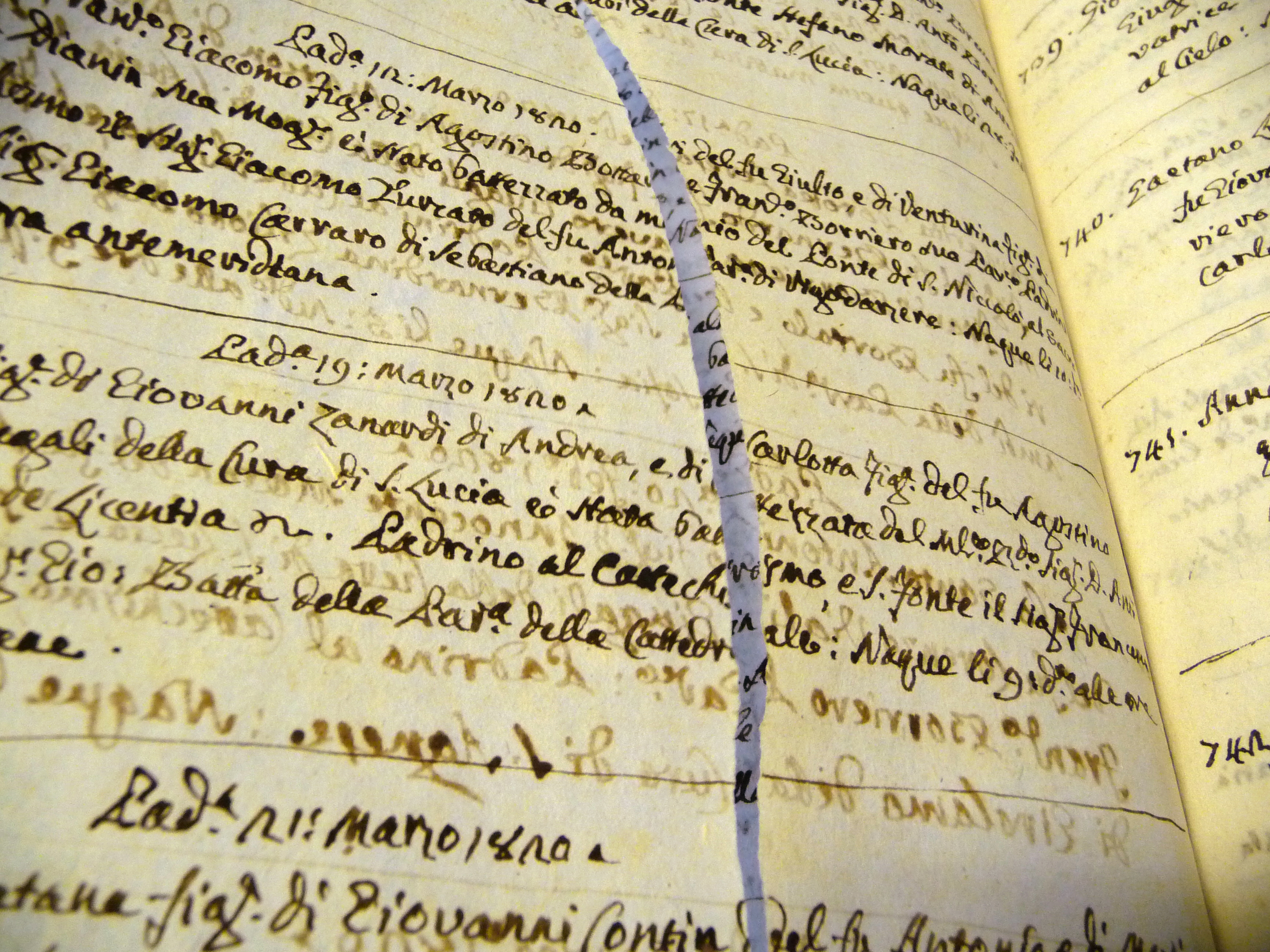Autore: Giuseppe Battelli
 Vescovi e nuovo Stato unitario: l’italianità come riferimento identitario o come questione aperta?
Vescovi e nuovo Stato unitario: l’italianità come riferimento identitario o come questione aperta?
La nascita formale nel 1861 del Regno d’Italia e la sua successiva estensione nel 1870 a comprendere Roma e i residui territori dello Stato pontificio non produssero la conseguente e immediata nascita in ambito religioso di una Chiesa italiana, né tanto meno il rapido costituirsi di un episcopato italiano. Esistevano ovviamente vescovi nativi e che svolgevano la propria funzione sul territorio politicamente unificato del Regno d’Italia, ma essi – collettivamente intesi – non si sentivano e non venivano univocamente considerati negli stessi ambienti ecclesiastici come appartenenti ad un’unica neo-costituita entità: l’Italia, appunto. Chi per contro li inquadrò subito secondo questa visione che potremmo indicare, per quell’epoca, come “astrattamente” unitaria fu lo Stato italiano: per la necessità di applicare all’intero territorio nazionale normative omogenee, ma anche per favorire all’interno della numerosissima e variegata compagine ecclesiastica ereditata dagli Stati italiani pre-unitari la percezione della irreversibilità del processo storico testé compiutosi. Percezione non scontata. Le alterne vicende che avevano riguardato la Roma pontificia a inizio Ottocento (quando nella tarda età napoleonica il papa Pio VII era stato prelevato e tenuto per anni lontano dal centro della Cattolicità) e nel pieno della tormenta rivoluzionaria del 1848 (con la fuga di Pio IX a Gaeta) potevano infatti alimentare la speranza di un ennesimo rovesciamento degli eventi; lo confermava il progetto, volto al ripristino del potere temporale, cui a lungo si lavorò durante il pontificato di Leone XIII.
Sul fronte ecclesiale, invece, per alcuni decenni dopo l’unificazione i vescovi italiani si considerarono e vennero considerati dalla S. Sede come tuttora organizzati secondo la geografia ecclesiastica sagomata sulla situazione pre-unitaria. Lo attestano vari elementi: come la nomina a ordinari di diocesi per lo più dello Stato pre-unitario di origine; le forme di aggregazione episcopale per sottoscrivere mozioni di solidarietà per il pontefice; l’incentivo romano a organizzare incontri episcopali sulla base delle antiche province ecclesiastiche, o dal 1889 delle regioni; la stessa suddivisione territoriale delle diocesi così come ancora alla vigilia della prima Guerra mondiale appariva su pubblicazioni ufficiali della S. Sede.
Il problema non aveva solo valenze organizzative, o genericamente istituzionali. Esso rifletteva piuttosto l’effettiva realtà delle cose. I vescovi, ad esempio, erano abituati a rapportarsi tra loro su base essenzialmente locale, e tutt’al più a rivolgersi a Roma per le questioni di maggiore rilievo; mentre tutt’altro che simili apparivano tra loro le concrete condizioni religiose delle diverse aree del nuovo Stato. A tale ultimo riguardo si poteva assistere nelle zone settentrionali all’intensa proliferazione dell’associazionismo cattolico con finalità socio-economiche o allo sviluppo dei prodromi del cosiddetto “modernismo”, mentre altrove e in particolare nel Mezzogiorno sussistevano situazioni tuttora legate ad antichi accordi concordatari con le monarchie pre-unitarie o a lontane tradizioni di forte legame territoriale tra istituzioni ecclesiastiche e notabilato locale. D’altronde la stessa distribuzione delle diocesi sul territorio nazionale vedeva gli arcivescovi di Milano governare un sistema costituito da circa settecento parrocchie, a fronte delle poche decine di unità parrocchiali (venti nel caso di Amelia) su cui operavano i confratelli di varie delle innumerevoli diocesi e relative province ecclesiastiche in cui risultava frantumata l’Italia centro-meridionale.
La risposta romana al problema
Almeno in un primo tempo la S. Sede non favorì la nascita di una entità identitariamente e organizzativamente unica dell’episcopato nazionale: forse anche alla luce delle sfaccettature dottrinali e ideologiche che, nella fase di unificazione del nuovo Stato e anche di evoluzione teologica intervenuta in quei decenni, avevano visto taluni vescovi non totalmente allineati sulle posizioni “infallibiliste” riguardo al dogma sulla inerranza papale approvato al concilio Vaticano I, e soprattutto dimostrare “transigenza” di fronte alle conseguenze che l’unificazione italiana aveva comportato per lo Stato pontificio (i casi più rilevanti furono quelli del vescovo di Cremona G. Bonomelli e di Piacenza G.B. Scalabrini). Ma il delinearsi progressivo durante i pontificati di Leone XIII e soprattutto Pio X di un’organica risposta al nuovo Stato, nel quadro della reazione complessiva alla società moderna, richiedeva la costruzione di un sistema compatto: il più possibile omogeneo e univoco nei princìpi da porre a base dell’azione promossa da Roma.
L’organicità di tale disegno (emblematicamente riassunto nel motto di Pio X “Instaurare omnia in Christo”) si esplicitò tra l’altro in una vasta e capillare istruttoria sulla situazione delle diocesi e dell’episcopato nazionale, condotta mediante l’invio a inizio Novecento di visitatori apostolici coordinati da dicasteri della Curia romana. Al di là degli aspetti di dettaglio che emersero e determinarono valutazioni e interventi della S. Sede, ciò che va richiamato è il consolidarsi in quel periodo dell’idea di “costruire” un episcopato nazionale secondo due criteri ritenuti a Roma funzionali all’intero disegno sopra descritto: ulteriore recupero del modello episcopale tridentino, che – nel richiamo alla fisionomia del pastore ma anche dell’efficace conduttore/ispettore della vita diocesana, secondo quella prospettiva di disciplinamento della vita diocesana già sperimentato tra fine Cinquecento e primo Seicento – sembrava peraltro collegabile a quello cinquecentesco soprattutto nella volontà di risposta alle rispettive congiunture storiche; disponibilità dei vescovi ad adottare gli strumenti e le indicazioni romane quanto al ruolo strategico dell’associazionismo laicale cattolico, alla ristrutturazione complessiva del sistema formativo dei seminari, alle riforme del culto promosse dallo stesso pontefice Pio X.
E’ secondo tale duplice prospettiva, cui s’intrecciò la forte preoccupazione dottrinale connessa alla lotta antimodernista, che venne modellandosi una parte cospicua dell’episcopato residenziale italiano che avrebbe guidato le diocesi nella prima metà del Novecento, dunque in fasi cruciali come la lunga convivenza con il regime fascista e il drammatico scenario delle due guerre mondiali. Un “modellarsi” non solo ex post (nel senso di modificare eventuali passati orientamenti), quanto ex ante (mirata politica nel reclutamento dei nuovi candidati all’episcopato). Quando infatti nel 1928 il card. De Lai lasciò dopo vent’anni la guida della Congregazione Concistoriale, il dicastero restituito alle antiche ampie funzioni di scelta e controllo episcopale dalla riforma della Curia romana promossa da Pio X nel 1908, risultò che oltre due terzi dell’intero episcopato residenziale italiano attivo alla vigilia della Conciliazione era stato consacrato e dotato di prima nomina durante il mandato De Lai. E rispetto al secondo dei criteri prima richiamati non è forse irrilevante che nel confronto tra la fine del pontificato di Leone XIII e la fine di quello di Pio X la percentuale dei vescovi inviati a svolgere il proprio mandato episcopale fuori dalla regione di origine s’innalzasse dal 37.50% al 60.44%, e la direttrice principale di tale movimento fosse da Nord verso Sud: cioè, dalle zone dove maggiore era la risposta ai criteri prima indicati a quelle che fino ad allora, per svariate ragioni, risultavano meno sensibili agli stessi (tale processo si confermò anche in seguito: si vedano tra l’altro l’invio a Palermo del milanese A. Lualdi, e a Bari e successivamente a Napoli del bolognese M. Mimmi).
Tra Conciliazione, fascismo e guerre mondiali.
E’ nel trentennio che va dall’inizio della prima guerra mondiale alla fine della seconda che iniziarono a modificarsi la fisionomia dell’episcopato nazionale come entità collettiva e il suo ruolo complessivo rispetto alla società italiana. Concorsero significativamente a quell’esito sia fattori interni che esterni alle dinamiche puramente ecclesiastiche. Tra i fattori interni va senz’altro collocata la linea di forte omogeneizzazione e coordinamento perseguita da Roma secondo il progetto ricordato. Linea cui concorse, come vera e propria bussola normativa per l’episcopato, la divulgazione nel 1917 del C.J.C: da allora, e fino alla promulgazione dei documenti del concilio Vaticano II, immancabile riferimento per la crescente convocazione (salvo nelle fasi belliche) di sinodi diocesani, concili provinciali e concili plenari regionali. Tra i fattori esterni si tenga conto dello svilupparsi progressivo, anche in Italia, di una società di massa che poneva alle classi dirigenti problemi di guida e di consenso diversi rispetto al passato, e soprattutto non più gestibili – come confermava nel primo dopoguerra la crisi della classe dirigente liberale italiana – secondo i metodi e le possibilità di incidenza sociale delle circoscritte élites postrisorgimentali.
In quel nuovo scenario l’episcopato svolse un ruolo decisivo di orientamento delle popolazioni, soprattutto tenendo conto che l’Italia rimaneva tuttora un Paese rurale e a relativamente modesta concentrazione urbana: caratteri riscontrabili non solo al Centro-Sud e nelle isole, ma anche in quella ampia parte del settentrione che risultava ai margini del triangolo industriale Milano-Torino-Genova e che non a caso aveva fortemente alimentato il fenomeno della emigrazione all’estero. In tale ruolo di orientamento si mescolarono elementi strettamente religiosi e pastorali – come il culto e la protezione delle popolazioni dalle conseguenze belliche – con elementi di carattere ideologico e attinenti al modello di società. Ne derivò da parte dei vescovi una condotta pubblica che s’imperniò, maggioritariamente e in una prospettiva di lungo periodo, sul mantenimento/rafforzamento del nesso tra fede cristiana e sostegno alle autorità costituite. Il fenomeno si accentuò dopo che la stipula dei Patti Lateranensi sembrò risolvere sia in senso stretto la Questione romana sia più latamente il profondo conflitto con lo Stato liberale italiano e i suoi princìpi fondativi di matrice cavouriana; ne ricavò forza quella instauratio di una società cristiana apertamente ostile nei confronti delle svariate forme di espressione della modernità che era l’obiettivo esplicito dei pontefici, dopo che il disegno di ripristino del potere temporale si era rivelato inattuabile.
In tal senso il ruolo svolto dall’episcopato sul lungo periodo nei confronti della società italiana fu decisivo. Mentre assunsero un peso relativo le congiunturali oscillazioni nel consenso prestato al regime fascista: tra gli “alti” dell’iniziativa coloniale etiope, della battaglia del grano, del sostegno del governo italiano alla componente franchista nella guerra civile spagnola (si ricordino tra gli altri Schuster a Milano, Nasalli Rocca a Bologna, Dalla Costa a Firenze), dello stesso ingresso nella seconda guerra mondiale; e i “bassi” degli insistiti attacchi fascisti alla AC e dell’introduzione nel 1938 della legislazione razziale. Alla fine della seconda guerra mondiale, di fronte a uno scenario di distruzione materiale e morale senza precedenti per la storia italiana, l’episcopato si presentava come strumento fondamentale di raccordo tra le scelte della S. Sede in ordine al futuro assetto da dare al Paese e una società attraversata da divergenti spinte: in materia politica (monarchia-repubblica, ruolo dei partiti di massa a sinistra, scelta filoatlantica), economico-sociale (centralismo-federalismo, legislazione sul matrimonio, politiche scolastiche), morale (secolarizzazione dei costumi, equidistanza dai modelli di vita socialista e capitalista).
Verso un episcopato nazionale: dalle riunioni preparatorie della CEI alla partecipazione al Vaticano II.
Nell’affermare l’importanza di quel ruolo non si è inteso sottovalutare un problema sul quale la storiografia si è ripetutamente interrogata: se cioè si possa parlare per gli anni del secondo dopoguerra di una vera e propria Chiesa italiana, intesa come entità guidata organicamente dal proprio episcopato ed esprimente un’identità legata a eventuali specifiche caratteristiche, o se invece si debba considerare quello italiano dell’epoca come un sistema ecclesiale ancora guidato direttamente dalla S. Sede, con i vescovi – tra loro coordinati tutt’al più a livello regionale – a svolgere in genere la funzione di ponte organizzativo e istituzionale tra il vertice romano e la base; funzione tra l’altro non esclusiva, se si pensa al ruolo crescente assunto da istituzioni sempre più centralizzate e strutturate a piramide come l’AC. Due degli elementi sui quali si è frequentemente insistito per dare forza al suddetto interrogativo, e soprattutto risolverlo nel secondo senso, sono stati da un lato la presenza ininterrotta (dal 1523) di pontefici di origine italiana, e dall’altro il dato di fatto che fino agli anni Sessanta non venne prevista in Italia alcuna forma di aggregazione generale e su base nazionale dell’episcopato italiano. Né dal punto di vista concretamente operativo, né da quello formale.
Il primo elemento sopra richiamato non è certo stato ininfluente a giustificare l’idea che la presenza sul territorio italiano della S. Sede e di pontefici italiani ai vertici dell’intera cattolicità, cui si aggiungeva l’elemento fondamentale che il Papa pro-tempore era in ogni caso primate d’Italia, rendesse superflua (per taluni) o inopportuna (per altri) una strutturata organizzazione dell’episcopato nazionale italiano. Ma va sottolineato, a riguardo, come proprio gli ultimi papi di origine italiana (Giovanni XXIII e Paolo VI, tenuto conto della brevità del mandato di Giovanni Paolo I) abbiano contribuito in modo decisivo a porre fine alla situazione sopra descritta, favorendo l’istituzione di una vera e propria conferenza nazionale dei vescovi italiani. Ciò avverrà tuttavia a partire dalla fine anni Cinquanta e soprattutto dopo il Vaticano II, mentre per il ventennio che si estese dalla fine della seconda guerra mondiale alla metà degli anni Sessanta il ruolo svolto dai vescovi italiani all’interno della Nazione prolungò le caratteristiche che si erano venute delineando durante la fase storica precedente, con l’unica novità – significativa, ma che non rappresentava in sé la nascita di un effettivo organismo nazionale dei vescovi italiani analogo a quello operante negli altri Paesi – costituita dagli incontri più o meno annuali cui presenziarono dal 1952 i presidenti delle conferenze episcopali regionali.
Ben diverso naturalmente, rispetto al ventennio dominato dal regime fascista, era il contesto nel quale esplicare la propria funzione: sia in materia strettamente religiosa, che sociale, che latamente “politica”. Per quanto infatti gli accordi concordatari del 1929 conservassero il proprio effetto grazie all’art. 7 della Costituzione repubblicana, ci si trovava ora a operare in uno scenario formalmente democratico e politicamente pluralistico. In esso trovava di nuovo spazio (come già tra il 1919 e il 1926) un partito cattolico, mentre a livello degli equilibri internazionali, non ignorabili da un’Italia bisognosa di un forte sostegno economico esterno per la ricostruzione postbellica (quello che sarebbe poi venuto mediante lo statunitense Piano Marshall), occorreva assumere una chiara posizione nel quadro della “guerra fredda” che contrapponeva il blocco degli Stati occidentali a quello degli Stati comunisti raccolti attorno alla Unione Sovietica.
Soprattutto tra la fine degli anni Quaranta e per l’intero successivo decennio i vescovi italiani si trovarono dunque immersi in uno scenario dove lo schierarsi politico era pressoché inevitabile e le stesse linee e conseguenti azioni pastorali assumevano il carattere di orientamento ideologico della popolazione: in via diretta quando ci si trovava alla vigilia delle scadenze elettorali; in via indiretta, ma non per questo meno significativa, quando ci si impegnava nella elaborazione di iniziative volte al contenimento della contrapposta azione delle organizzazioni legate al PCI (il maggiore partito comunista attivo in uno Stato occidentale). Tanto che, nel clima esasperato di quegli anni, si pervenne in taluni specifici casi a dare la sensazione che rappresentanti dell’episcopato svolgessero una sorta di leadership politica supplente di quella, evidentemente ritenuta inadeguata, degli esponenti DC locali (tipico in tal senso il caso della Bologna del card. Giacomo Lercaro).
Con tali presupposti – riassumibili nella debole consuetudine a sentirsi parte di un unico grande organismo nazionale e con una forma mentis nutrita negli ultimi decenni prima dall’insidioso rapporto con il fascismo e poi dalla battaglia ideologica per il contenimento del comunismo – l’episcopato italiano si presentò al concilio senza poter esprimere in sede di elaborazione teologica un ruolo guida corrispondente al peso potenziale dato dall’essere sul piano numerico il maggior episcopato nazionale presente al Vaticano II. La leadership esercitata al suo interno dall’arcivescovo di Genova Giuseppe Siri, presidente dal 1959 dell’organismo che comprendeva i rappresentanti delle conferenze regionali, orientò poi gran parte dei vescovi italiani più verso le posizioni conservatrici vicine alla linea di taluni importanti dicasteri della Curia romana (emersero a riguardo le posizioni tra gli altri dell’arcivescovo di Palermo Ruffini, del vescovo di Segni Carli, dell’arcivescovo di Firenze Florit) che non a quella maggioranza conciliare che si coagulò – perlomeno nelle prime due sessioni conciliari – attorno agli episcopati del centro Europa. Ne fu un’emblematica conseguenza il fatto che una delle figure di presuli italiani destinata a svolgere in concilio un ruolo difficilmente sottovalutabile (quel cardinal Lercaro che condusse in porto la riforma liturgica e fece parte, come unico italiano, del collegio dei quattro moderatori conciliari istituito nel 1963 da Paolo VI) dovette quello stesso ruolo non tanto al riconoscimento dei propri colleghi italiani quanto a quello dei propri colleghi d’Oltralpe.
Dal postconcilio alla contemporaneità.
La condivisa esperienza conciliare, unita alla spinta in tal senso di Paolo VI, favorì in ogni caso l’approdo alla istituzione di una vera e propria conferenza nazionale dei vescovi italiani: sulla base di uno statuto dapprima provvisorio (1965) poi effettivo (1971). Si aprì con questo nuovo assetto istituzionale la stagione che poneva agli stessi presuli, quale inaggirabile priorità, la questione del come rapportarsi agli esiti del Vaticano II. Il problema si presentava sotto molteplici aspetti. Se da un lato infatti i documenti conciliari fornivano una serie piuttosto ampia di argomenti e auctoritates cui richiamarsi – ma ciò poteva avvenire, e di fatto avvenne, anche in termini più nominalistici che di sostanza -, dall’altro la vera discriminante era rappresentata dalla volontà, maggiore o minore, di recepire in modo profondo la spinta all’aggiornamento promossa dal Vaticano II. E ciò travalicava i confini della pura formulazione di richiami ai testi conciliari. Anche volendo infatti restringere la prospettiva al piano delle singole diocesi – e dunque non addentrandosi nel delicato tema ecclesiologico della collegialità episcopale – ciò abbracciava sul piano concreto l’attivazione dei nuovi organi diocesani previsti dall’assise conciliare (consiglio presbiterale e consiglio pastorale) e l’introduzione delle norme e fonti relative alla riforma liturgica, mentre su quello pastorale spingeva all’assunzione di linee coerenti con i princìpi riguardanti – tra l’altro – i rapporti con il mondo contemporaneo, il sacerdozio universale, le problematiche interconfessionali e interreligiose.
Di fronte a tale sfida l’episcopato italiano attraversò una prima fase postconciliare nella quale non mancarono forti sussulti, in parte prolungamento delle tensioni già emerse durante lo svolgimento del concilio e in parte frutto delle possibili vie alternative nell’applicazione dello stesso Vaticano II. Poi, verso la seconda metà degli anni Settanta e dunque all’avvicinarsi di quel 1978 che avrebbe anche rappresentato il concludersi della plurisecolare sequenza di pontefici italiani, si attestò su posizioni di recezione in chiave moderata del Vaticano II: realizzando infine, almeno in apparenza, quel processo di maggioritaria “montinizzazione” della Chiesa italiana al quale papa Paolo VI, secondo una data interpretazione storiografica, stava lavorando fin dagli anni trascorsi come sostituto nella Segreteria di Stato di Pio XII. Era una Chiesa italiana che, pur avendo acquisite una propria formale identità e organizzazione facente capo alla CEI, risultava tuttora vicinissima per sensibilità e ascolto alla S. Sede, teologicamente lontana dalle posizioni di frontiera (sia legate alla ricerca più spregiudicata, sia sensibili alle istanze anticonciliari del “lefebvrismo”), particolarmente incline a considerare la sfera politica nazionale come naturalmente soggetta all’orientamento da parte della gerarchia cattolica.
Rispetto a quest’ultimo punto, tradizionalmente centrale nella visione dei vescovi italiani operanti dal secondo dopoguerra in poi, si sarebbe registrato un imprevisto cambiamento di prospettiva a inizio anni Novanta: non per modifica della linea episcopale, costantemente legata al principio dell’unità politica dei cattolici, e nemmeno per le eventuali conseguenze della nuova stipulazione concordataria intervenuta nel 1984; bensì per il rapido sfaldamento della classe dirigente democristiana nel quadro delle indagini sul fenomeno chiamato “tangentopoli” e per la successiva frantumazione del partito cattolico in più entità (PPI, CCD, CDU). Tale inedita congiuntura, per di più inserita nel lungo pontificato di un papa come Giovanni Paolo II ben più lontano dalle problematiche italiane di quanto non fossero stati i suoi predecessori e da ultimo Paolo VI, ha inaugurato la stagione più recente. In essa l’episcopato nazionale, a lungo guidato dal card. Camillo Ruini, ha percorso un cammino nel quale vari fattori che in passato avevano guidato la coesione o anche il confronto si sono inesorabilmente allontanati: dalla centralità problematica ma indiscussa del concilio, all’univoca scelta in materia politica, alla perseguita guida di un sistema sociale che pur nelle sue tensioni interne appariva pur sempre rappresentativo di un quadro nazionale unitario. Nuovi e non sempre rassicuranti scenari si sono palesati negli ultimi anni: ponendo l’episcopato italiano ancora una volta di fronte al dilemma tra una più facile linea di vantaggioso adeguamento all’esistente e una meno facile scelta di libera espressione del proprio mandato pastorale.
Fonti e Bibl. essenziale
G. Alberigo, Santa Sede e vescovi nello Stato unitario. Verso un episcopato italiano (1958-1985), in Storia d’Italia. Annali, 9, Einaudi, Torino 1986, 857-879; G. Battelli, Santa Sede e vescovi nello Stato unitario. Dal secondo Ottocento ai primi anni della Repubblica, ivi, 807-854; G. Battelli, Vescovi e diocesi nel nord-Italia tra Cinquecento e Novecento. Panorama storiografico dell’ultimo secolo, in Ricerca storica e chiesa locale in Italia, Ediz. Dehoniane, Roma 1995, 37-82; P. Caiazza, Concili provinciali e conventus episcoporum da Pio IX a Leone XIII, in AHP 33 (1995), 197-245; Chiese italiane e Concilio. Esperienze pastorali nella chiesa italiana tra Pio XII e Paolo VI, Marietti, Genova 1988; V. De Marco, Vescovi del sud per i problemi del sud nel secondo dopoguerra, in Società, politica e religione in Basilicata nel secondo dopoguerra, Congedo, Galatina, 2013, 119-149; S. Ferrari, Diritto canonico e vita della Chiesa. Introduzione allo studio della legislazione sinodale, in I sinodi diocesani di Pio IX (1860-1865), Herder, Roma 1987, XI-XXXI; F. Fonzi, I vescovi, in Chiesa e società in Italia dopo l’Unità (1861-1878),Vita e Pensiero, Milano 1973, vol. I, 32-58; B. Gariglio, I vescovi, in M. Impagliazzo, La nazione cattolica. Chiesa e società in Italia dal 1958 a oggi, Guerini, Milano 2004, 91-115; M. Lupi, La Chiesa e l’Italia liberale, in Storia religiosa dell’Italia, ITL-Centro Ambrosiano, Milano 2016, 631-668; F. Malgeri, La Chiesa italiana e la guerra (1940-1945), Studium, Roma 1980; A. Marani, Una nuova istituzione ecclesiastica contro la secolarizzazione. Le conferenze episcopali regionali (1889-1914), Herder, Roma 2009; G. Martina, La Chiesa in Italia negli ultimi trent’anni, Studium, Roma, 1977; D. Menozzi, Introduzione, in Lettere pastorali dei vescovi dell’Emilia-Romagna, Marietti, Genova 1986, XI-XXXII; Episcopato e società tra Leone XIII e Pio X. Direttive romane ed esperienze locali in Emilia-Romagna e Veneto, Il Mulino, Bologna 2000; G. Miccoli, Sul ruolo di Roncalli nella Chiesa italiana, in Papa Giovanni, Laterza, Roma-Bari 1987, 175-209; A. Monticone, L’episcopato italiano dall’Unità al concilio Vaticano II, in Clero e società nell’Italia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1992, 257-330; A. Monticone, I vescovi meridionali 1861-1878, in Chiesa e società in Italia dopo l’Unità (1861-1878), Vita e Pensiero, Milano 1973, vol. I, 59-100; A. Parisi, Dall’episcopato pre-unitario all’episcopato post-conciliare, in Studi in onore di P. A. D’Avack, Giuffré, Milano 1976, vol. III, 451-496; R. Regoli, Concili italiani. I sinodi provinciali nel XIX secolo, in AHP, 46 (2008), 131-161; A. Riccardi, Chiesa di Pio XII o Chiese italiane?, in Le Chiese di Pio XII, Laterza, Roma-Bari 1986, 21-52; V. Saladino, L’episcopato italiano e i Savoia nelle istruzioni della Santa Sede durante il pontificato di Leone XIII, in Chiesa e storia, 2 (2012), 311-330; F. Sportelli, La Conferenza Episcopale Italiana (1952-1972), Congedo Editore, Potenza [1994]; G. Verucci, La Chiesa postconciliare, in Storia dell’Italia repubblicana, vol. II/2, Einaudi, Torino 1995, 297-382; M. Velati, I «Consilia et vota» dei vescovi italiani, in A la veille du Concile Vatican II. Vota et réactions en Europe et dans le catholicisme oriental, Univ. cath. de Louvain, Louvain 1992, 83-97; G. Vian, La riforma della Chiesa per la restaurazione della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d’Italia promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914), 2 voll., Herder, Roma 1998; R.P. Violi, Episcopato e società meridionale durante il fascismo (1922-1939), Editrice A.V.E., Roma 1990.
Immagini:
1) Ritratto del vescovo Geremia Bonomelli (1831-1914), esponente di punta dell’episcopato “transigente” nazionale.
2) Consacrazione di edificio fascista da parte dell’arcivescovo Ildefonso Schuster (1880-1954).
3) Tre dei quattro cardinali “moderatori” del concilio Vaticano II: primo a sinistra l’italiano Giacomo Lercaro, con accanto il tedesco J. Döpfner e il belga L.J. Suenens.
4) Camillo Ruini, presidente della Conferenza episcopale italiana dal 1991 al 2007.